
Walter Siti scava nel fondo dell’infame, «e qui riconosco la traccia del sacro»
Tommaso Aricò è un ex ragazzo obeso, cresciuto nelle borgate romane, figlio di un detenuto di Rebibbia. Matematico mancato, è un orso con le cicatrici che gioca con la finanza ad altissimi livelli: «Eccomi qui, a trentatré anni compiuti (l’età di Cristo) con una carriera al di là di ogni più rosa speranza, un sistema nervoso intaccato e una vita sentimentale aleatoria. Nessun messaggio per i posteri». Attorno a lui si muove un mondo in cui il denaro comanda e deforma. Dove il possesso è l’unico criterio di valore, il corpo è moneta e la violenza un vantaggio commerciale. Soldi puliti e sporchi si confondono in un groviglio inestricabile, e la distinzione tra bene e male non esiste («Ti sei appeso per nulla», dice il protagonista, rivolto al crocifisso). Walter Siti, scrittore e critico letterario, oltre che saggista (è il curatore delle opere complete di Pier Paolo Pasolini) dopo Troppi paradisi (2006) e Il contagio (2009) prosegue l’indagine narrativa sulle mutazioni profonde della contemporaneità con Resistere non serve a niente (Rizzoli, pagg. 320, euro 18). Una storia che scorre rapida e densa, in cui sesso e denaro si mischiano luttuosamente, anche come terminologia, perché la merce per eccellenza diventa l’altro, e a che servono gli altri, se «il mercato è in grado di fornire l’intero kit per un’individualità fai-da-te»?)
Non si contano le inchieste che hanno descritto nei minimi dettagli la “zona grigia” tra criminalità e finanza, fatta di banchieri accondiscendenti, broker senza scrupoli, politici corrotti, malavitosi di seconda generazione laureati in Scienze economiche e ricevuti negli ambienti più lussuosi e insospettabili. Siti sceglie però di sfruttare le risorse della letteratura per offrire un ritratto ravvicinato di Tommaso e del suo personalissimo inferno in terra, un mondo un cui «forse il denaro è la materia oscura che permette alla luce di propagarsi». Perché no, visto che «l’economia del mondo è per metà illegale»? Così la finanziarizzazione dell’economia diventa il simbolo dell’inaridimento dei rapporti umani, del collasso del mondo Occidentale. L’amore? Non esiste: con Gabriella, aspirante attrice, «non è proprio che convivano»: lei si ferma alcuni giorni poi sparisce («considerami missed»). E mentre lei trasferisce due bauli nella cabina armadio di Tommaso, lui paragona il loro rapporto a uno stage. Cosa ci vorrebbe? «Un po’ di silenzio e di pietà per se stessi; quel respiro di rassegnazione che serve a tendersi la mano. Macché, si pensano in una élite, si scambiano opinioni trendy al posto dei sentimenti; non potendo esiliarsi nella campana del sesso, si spendono in cene velleitarie tra banchieri che hanno corso la maratona di New York, costumisti froci (con golden retriever) ammiratori della Fallaci, figlie di industriali appena uscite da San Patrignano».
La loro crisi, tutta umana, riflette quella dell’anno orribile per i mercati mondiali. Tommaso si diverte a leggere i bilanci delle aziende, perché le magagne «appaiono luminose come le fratture quando il medico piazza una radiografia davanti alla luce. Non è difficile smascherare i bluff, le iniezioni di denaro che non c’è, le fusioni fasulle. Il crollo dell’Occidente padrone-dei-prodotti è segnato, si tratta solo di ipotizzare in quanto tempo e in che modo accadrà; tutti parlano del Titanic ma la metafora che a Tommaso piace di più è quella della fregata francese Méduse – più o meno ai primi dell’Ottocento, incagliata al largo della Mauritania: i più astuti e feroci si salvarono sulle scialuppe, i più pavidi e ingombranti (tra cui il governatore) si fecero trainare in una larga zattera; ma la cima si spezzò e la zattera andò alla deriva, molti caddero (o vennero gettati) in mare: i quindici superstiti raccontarono attoniti scene di cannibalismo a bordo». Sovrapporre i due universi (quello affettivo e quello finanziario) secondo Walter Siti, non è affatto una forzatura. «Dalle persone perbene la finanza è vista come un nemico esterno» ha spiegato durante la presentazione del libro alla Borsa di Milano, in Piazza Affari, proprio di fronte al dito medio di Cattelan. «La forza dei derivati è un sintomo di quello che siamo». Che significa? Che se un debito si può vendere all’infinito, diventa metafora della mancanza di responsabilità dei rapporti umani. È impossibile distinguere i soldi puliti e quelli sporchi, tanto che li chiamano entrambi “hot money”? È lo stesso azzardo di chi nelle relazioni con gli altri rinuncia alla ragione. La difficoltà del prevederla, la crisi, di captarne gli esiti, ci riguarda molto da vicino e rappresenta per Siti la crisi del legami generazionali, l’incapacità di progettare a lungo termine, il desiderio cieco del tutto e subito. Un orizzonte desolato, perché «la società è una finanza a lento rilascio, in cui sono impastati i peggiori tra noi. Che sono tanti».
Resistere, dunque non serve a niente? Non proprio: «La finanza rispettosa, colta, che sa quando fermarsi, esiste. Ma nei singoli: non ha la forza di dar la tinta al mondo. Occorre una rivoluzione interna, che è anche antropologica: dalla forma occorre passare alla sostanza. Dal possesso, alla famiglia». Perché indugiare, allora, nel laido e nel cinico? «Per capire che tipo di animali siamo. Nel fondo dell’infame, riconosco la traccia del sacro che troppo il fretta abbiamo eliminato. Ma a cui tendo. Con questo romanzo io celebro il funerale della post-realtà. Ho raschiato il fondo a un punto tale che non posso più tornare indietro. Ci sono solo due strade: o il nulla, o il cambiamento totale». Il prossimo romanzo? «Sarà su un prete pedofilo, trattato dal suo punto di vista. E lì, lo scontro tra l’infamia e la sacralità, arriverà al calor bianco».
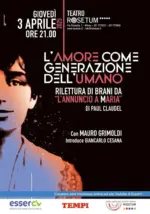
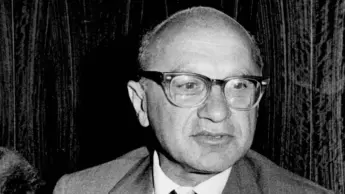

0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!