
Viaggio alla scoperta di un patrimonio inestimabile a cielo aperto

Passeggiando per via Veneto, che Federico Fellini rese celebre con il suo La dolce vita, si costeggiano hotel di lusso, caffè eleganti e celebri ristoranti. Qui, quasi nascosta dagli alberi, c’è una scalinata che porta dritti alla chiesa dei cappuccini di via Veneto dedicata all’Immacolata Concezione della beata Vergine Maria (foto sotto). Il museo e l’antica cripta decorata con migliaia di ossa raccolte nell’antico cimitero dell’ordine, richiamano ogni anno un pubblico numeroso, più curioso che fedele. Varcando la soglia della chiesa – consacrata nel 1630 da papa Urbano VIII – si è rapiti dalla straordinaria bellezza di un angelo che si staglia al centro del dipinto posto sull’altare di una delle cappelle laterali: è il barocco, virtuoso e vittorioso San Michele Arcangelo (1635) che brandisce la spada contro un Lucifero incatenato e calpestato, realizzato dal bolognese Guido Reni nel pieno della sua maturità artistica. All’epoca il dipinto – il cui protagonista oggi è patrono della polizia – fu commissionato dal cardinale Antonio Barberini, fratello di Urbano VIII, e ora grazie all’interesse dello Stato si può ammirare nel suo originario splendore. È infatti il ministero dell’Interno, oggi attraverso il Fondo edifici di culto (Fec), a occuparsi interamente, da più di cent’anni, di un patrimonio di oltre 750 chiese in Italia e delle opere in esse contenute.

Occorre andare indietro nel tempo per capire come mai non è più la Chiesa a possedere e gestire un tesoro così ricco di arte e di fede. L’anno da cui partire è il 1886: fu allora che venne conclusa la fase legislativa post unitaria che rendeva effettive le cosiddette leggi eversive che soppressero definitivamente le corporazioni religiose e che entrarono in vigore l’anno successivo con il secondo governo Rattazzi. Tutte le proprietà degli ordini sciolti – dagli edifici delle congregazioni, ai monasteri, ai conventi – passarono allo Stato e vennero trasformate in tribunali, scuole, ospedali, caserme e galere. Una grande quantità di oggetti d’arte finirono sul mercato, per la gioia di collezionisti e antiquari. A salvarsi dalle maggiori devastazioni e dall’uso improprio furono solo edifici e complessi monumentali di culto.
La nascita del Fec
«Furono le aziende statali a gestirli – racconta a Tempi il prefetto Lucia di Maro, dal 2007 direttore del Fec – fino a quando, nell’ambito degli accordi tra Stato italiano e Santa Sede, in occasione della revisione dei Patti Lateranensi, nel 1985 fu istituito il Fondo edifici di culto, ente dotato di personalità giuridica del ministero dell’Interno, gestito dalla Direzione Centrale e da un Consiglio di amministrazione. Il Fec è responsabile della conservazione, del restauro e della valorizzazione delle chiese e delle opere contenute al loro interno, che vengono concesse alle autorità religiose solo per fini di culto. La maggior parte di esse si trovano in Sicilia – circa 250 tra cui Santa Maria dell’Ammiraglio a Palermo, meglio nota come la Martorana (foto sotto), caratterizzata dai molteplici gusti artistici, architettonici e culturali che ne fanno un monumento storico in cui la tradizione bizantina sposa la cultura barocca – nel Lazio e in Campania. A Roma ce ne sono 70, tra cui San Bonifacio, Santa Croce in Gerusalemme – dove si può ammirare un mosaico di Melozzo da Forlì –, Santa Maria Sopra Minerva – dove sono contenute le tombe di santa Caterina da Siena, patrona d’Italia, e del pittore fra Giovanni da Fiesole, oggi beato e nel 1984 dichiarato da Giovanni Paolo II patrono universale degli artisti–, e Santa Maria del Popolo, che conserva, nella cappella Cerasi, la Crocifissione di San Pietro e la Conversione di San Paolo di Caravaggio». Tra gli altri edifici che meritano oltre a una menzione sicuramente una visita, ci sono Santa Chiara a Napoli – la più grande basilica gotica della città –, Santa Maria Novella a Firenze – dove nel coro della cappella Tornabuoni è conservato un importantissimo ciclo di affreschi di Domenico Ghirlandaio a cui probabilmente lavorò anche Michelangelo –, San Domenico a Siena – che custodisce la testa di santa Caterina –, e Santa Caterina d’Alessandria a Palermo – che riflette il gusto della controriforma grazie alla ricca decorazione dell’interno e all’unica navata. Ma come mai non è il ministero dei Beni e delle attività culturali a gestire un Fondo che deborda di arte e di cultura e che attrae ogni anno un gran numero di turisti e fedeli? «Il Fec – precisa Lucia di Maro – non ha solo il compito di preservare e valorizzare, ma anche quello di garantire l’uso ai fini di culto; per questo motivo è il ministero dell’Interno a esserne responsabile, e lo fa attraverso il dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, che ha proprio il compito di tutelare i diritti civili dei cittadini: di cittadinanza, d’asilo, d’immigrazione e di confessione religiosa. La tutela del bene ha, quindi, un valore aggiunto: quello culturale e religioso. Inoltre, le opere contenute all’interno degli edifici sono state realizzate con fini “catechistici”. Il loro primo fine è quello religioso e spirituale, e non, come potrebbe sembrare, quello prettamente artistico».

Biblioteche e foreste
Oltre alle chiese e alle opere d’arte e agli arredi in esse contenuti, il Fec possiede anche biblioteche, tra cui quella del Viminale che raccoglie circa cinquecento volumi di grande pregio. Affidato al Fondo anche il vasto complesso forestale di Tarvisio, in provincia di Udine, con i suoi 23 mila ettari di natura incontaminata al confine con Slovenia e Austria. La cura e la gestione di un patrimonio così importante (Michelangelo, Vasari e Tiziano sono solo alcuni dei grandi autori dei capolavori conservati all’interno di questi edifici) è frutto di una serie di attività e iniziative volte ad avvicinare non solo gli studiosi, i fedeli e gli appassionati, ma anche il grande pubblico. Oltre ai cataloghi d’arte e ai volumi scientifici già pubblicati, «lo scorso 20 dicembre è stato presentato, nell’ex biblioteca Sessoriana del complesso di Santa Croce in Gerusalemme, l’archivio storico del Fec che raccoglie il patrimonio documentario – catalogato dai volontari del servizio civile – e narra la storia del Fondo dalla metà del 1800 fino ai primi decenni del 1900, ed è frutto di una collaborazione con il vicariato di Roma e di una intesa con l’archivio centrale dello Stato». Tra i lavori in corso ci sono quelli per una pubblicazione relativa alle chiese dei Gesuiti presenti a Roma, come quella del Santissimo nome di Gesù e quella di Sant’Ignazio di Loyola, adiacente al Collegio Romano. Dall’interno di quest’ultima si ha la possibilità di accedere a quelle che furono le camere abitate dagli studenti che venivano dal noviziato di Sant’Andrea al Quirinale, e in particolare alle “stanze del Ritiramento” di san Luigi Gonzaga, dove il santo soggiornò dedicandosi allo studio e alla preghiera.
In viaggio per il mondo
«È in programma anche la realizzazione di una collana scientifica che presenterà tutte le chiese del Fondo, con schede redatte dalle competenti soprintendenze. Sono queste, infatti, a predisporre i progetti di vigilanza e di programmazione degli interventi, sulla base del codice dei beni culturali. Le direzioni regionali avviano le procedure e il Fec, con l’approvazione del suo consiglio di amministrazione, finanzia i lavori. A livello locale sono i prefetti i responsabili del patrimonio e quindi se il rettore di una chiesa rileva un problema, è necessario che si rivolga alla prefettura». Ma non basta una manutenzione ordinaria per proteggere e valorizzare questi tesori. È anche importante che questi vengano conosciuti al di fuori degli spazi che solitamente abitano, così che possano raccontare a tutti le virtuose abilità artistiche  delle maestranze italiane che li hanno creati, diventando anche un pregevole esempio di fede e devozione. Per questo motivo le richieste di prestito per mostre ed eventi in tutto il mondo sono sempre più numerose: «Durante l’Expo di Shanghai, ad esempio, sono stati esposti nel Padiglione Italia dei paliotti siciliani che il commissario Beniamino Quintieri vide in una mostra a Palazzo Raspoli e che poi volle ospitare per tutta la durata dell’evento». Tra i beni attualmente fuori sede ci sono due tele di Caravaggio appartenenti a due chiese della capitale: quella dei Cappuccini e San Pietro a Carpineto Romano. Raffigurano San Francesco in meditazione (foto a destra) ed entrambe hanno preso parte alla mostra “Conoscere Caravaggio” che è rimasta aperta fino al 6 aprile scorso al Muscarelle Museum of Art di Williamsburg in Virginia e che sarà visibile fino al prossimo 15 giugno presso il Museum of Fine Arts di Boston.
delle maestranze italiane che li hanno creati, diventando anche un pregevole esempio di fede e devozione. Per questo motivo le richieste di prestito per mostre ed eventi in tutto il mondo sono sempre più numerose: «Durante l’Expo di Shanghai, ad esempio, sono stati esposti nel Padiglione Italia dei paliotti siciliani che il commissario Beniamino Quintieri vide in una mostra a Palazzo Raspoli e che poi volle ospitare per tutta la durata dell’evento». Tra i beni attualmente fuori sede ci sono due tele di Caravaggio appartenenti a due chiese della capitale: quella dei Cappuccini e San Pietro a Carpineto Romano. Raffigurano San Francesco in meditazione (foto a destra) ed entrambe hanno preso parte alla mostra “Conoscere Caravaggio” che è rimasta aperta fino al 6 aprile scorso al Muscarelle Museum of Art di Williamsburg in Virginia e che sarà visibile fino al prossimo 15 giugno presso il Museum of Fine Arts di Boston.
I Borgia a Parigi
Importante è stata anche la partecipazione del Fec alla mostra “La Primavera del Rinascimento”, aperta la primavera dello scorso anno presso il palazzo Strozzi di Firenze, cui ha partecipato con il Viaggio dei Magi di Andrea del Sarto, La Visitazione di Pontormo e l’Assunzione di Rosso Fiorentino. Da Pechino è arrivata la richiesta di prestito di alcuni dipinti per una mostra sulla Roma barocca; a Tokyo vogliono ammirare Caravaggio e a Parigi stanno organizzando un’esposizione sui Borgia. «Per quanto riguarda il prestito delle opere è importante precisare – conclude Lucia di Maro – che il Fec ha introdotto già da qualche anno il loan fee, ovvero il canone per il prestito dei quadri». È una pratica poco diffusa in Italia, ma che dovrebbe essere presa in considerazione anche da molte altre istituzioni. Attraverso la concessione “prezzata” delle opere d’arte, infatti, si potrebbe avere un non indifferente ritorno economico che andrebbe a compensare la piccola cifra che lo Stato stanzia ogni anno per la conservazione e la valorizzazione del nostro tesoro artistico. Nel caso del Fec «lo Stato devolve ogni anno 1.700.000 euro, ai quali si aggiungono i proventi che il Fondo ricava dal suo patrimonio (dai 3,5 ai 4 milioni di euro). Capisce dunque che il budget a nostra disposizione è davvero minimo rispetto all’immenso patrimonio da gestire».
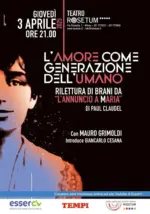
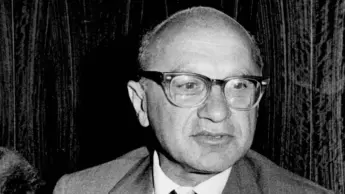

0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!