
Vaccino obbligatorio? «Senza la libertà non si fa il bene comune»
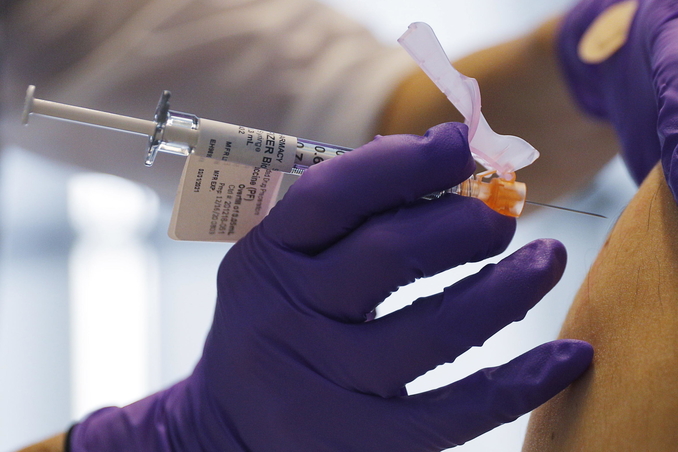
Più ci chiedono di sognare la palingenesi – resistere fino al vaccino, torneremo a vita nuova col vaccino – più le domande si moltiplicano. Non sull’utilità di una profilassi vaccinale – ditelo ai celebrazionisti per cui chiunque osi porre questioni è un negazionista no vax -, ma sul ridurre il problema e il debellamento di una pandemia all’obbligatorietà o meno di qualche puntura. Don Roberto Colombo è genetista clinico e specialista nella diagnostica molecolare delle malattie rare, docente della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica (Roma) e consultore del Dicastero Laici, Famiglia e Vita della Santa Sede. A lui abbiamo chiesto un aiuto ad orientarci in questo pandemonio di informazioni e dichiarazioni sguainate sulla profilassi anti-Covid. Ne è nato un lungo approfondimento su efficienza, immunità, sperimentazione, reazioni, distribuzione, affidabilità che vi proponiamo a puntate. Qui la prima (Non finirà con una puntura, «oggi non basta il vaccino per sconfiggere il Covid»), la seconda (Oggi vaccinati non significa “impermeabili al virus”), la terza (“Non esistono ‘cavie’ del vaccino, tutto il processo è sperimentale”). Ecco la quarta, a tema stoccaggio, distribuzione e il rischio vaccino “fatto di corsa”) e la quarta (“La corsa ai vaccini e vaccini fatti di corsa”). Ecco la quinta e l’ultima puntata: a tema, l’obbligo vaccinale.
Ancora non conosciamo la durata dell’immunità, né sappiamo se un vaccinato possa infettare ancora o meno. Non sappiamo nemmeno quando la popolazione “più attiva” potrà essere sottoposta a vaccinazione. Eppure in molti spingono sul cosiddetto “patentino di immunità”, ovvero un documento per dare accesso a luoghi e servizi solo a chi ha fatto il proprio dovere e ricevuto la dose di vaccino. Di più, il costituzionalista Gaetano Azzariti settimana scorsa dichiarava al Foglio che «il diritto alla salute è importante quanto il principio di uguaglianza» e la discriminazione tra vaccinati e non vaccinati sarebbe possibile dal punto di vista costituzionale se regolata da una legge statale. Lei cosa pensa di una legge sull’obbligatorietà vaccinale per il Covid?
La questione della obbligatorietà o meno di una pratica profilattica come la vaccinazione è assai complessa e delicata, sia sotto il profilo antropologico, etico, medico e psicologico che sul versante sociale, giuridico (anche di rango costituzionale) e politico. Sul piano antropologico ed etico, la considerazione del cittadino come soggetto di libertà (il cui esercizio può subire, in determinate circostanze, delle limitazioni quando al “libero arbitrio”, ma mai essere negata o coartata quanto all’autodeterminazione, perché l’uomo resta sempre e comunque aperto al proprio destino, al compimento di sé, cui la corporeità non è estranea né marginale) solleva domande ineludibili sulla correttezza di un “piano di vaccinazione di massa” che non veda la persona al centro di esso. La persona con la sua originale struttura antropologica che ne fonda la soggettività meritevole di rispetto incondizionato, di tutela fattiva e di promozione. La società si fonda sulla persona nella sua dimensione di relazionalità con le altre persone, non la persona si relaziona alla società come se ad essa fosse meramente strumentale. Il bene comune (come, in questo caso, la salute) è bene di tutti se e solo se è bene di ciascuno. In quanto bene della persona è bene della società. Una società “sana” è una società che riconosce, tutela e promuove la salute di ciascuno dei suoi membri. E la salute è una opzione della libertà, dell’io che si autodetermina come chiamato alla integrità del corpo e dello spirito.
C’è chi sostiene che bisogna “espropriare” la persona dalla gestione individuale della propria salute per garantirla a tutti.
La salute dei cittadini non è una scelta sociale e politica che si impone ad essi a prescindere dalla loro libertà, senza il coinvolgimento di essa. Anche quando questo coinvolgimento nel perseguire l’obiettivo comune – il bene della salute – deve fare i conti con la possibilità di una resistenza o di una negazione del consenso, per evitare la quale devono essere messe in campo tutte le possibilità (anche le più onerose in termini di impegno culturale, sociale e politico) prima di prendere in considerazione, quale extrema ratio – la coercizione. Come è noto, il trattamento sanitario obbligatorio (eticamente e giuridicamente accettabile, in determinate condizioni) scatta solo quando vi è documentata evidenza di una assenza di libertà del soggetto, di una incapacità di autodeterminazione in ordine al bene della propria persona secondo la dimensione antropologica della coscienza di sé e della ragionevolezza. Sul piano medico e psicologico, occorre tenere presente che la vaccinazione è un atto “invasivo” nei confronti del corpo (certamente “mini-invasivo”, come può essere una iniezione intramuscolare), tocca cioè la sfera antropologicamente e psicologicamente rilevante della corporeità della persona. La decisione se farsi inoculare un vaccino, quale farsi somministrare tra i diversi preparati disponibili e quando farsi vaccinare (per esempio, in dipendenza dei dati sulla sicurezza ed efficacia del prodotto, delle proprie condizioni di salute e aspettative di vita, delle relazioni affettive, familiari, lavorative, scolastiche, sociali, sportive o ricreative, ed altro ancora) non può che essere considerata – in prima e forte istanza – come una prerogativa della persona e non dello Stato o di una autorità da esso delegata.
Ma il governo può costringere con decreto o dpcm le persone all’inoculazione o “punirle” in caso di mancata adesione?
L’articolo 32 della Costituzione italiana prevede che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge». In teoria (punta di diritto), il Governo nazionale potrebbe ipotizzare il ricorso all’obbligo di vaccinazione per tutti i cittadini o per determinate categorie di essi (soggetti anziani, operatori socio-sanitari, addetti a servizi pubblici essenziali, forze militari, di polizia e di pubblico soccorso, insegnati, studenti e altre ancora), ma questo – in un regime democratico e uno stato di diritto – dovrebbe avvenire praticamente solo attraverso il ricorso ad una legge approvata dal Parlamento a seguito di un ampio dibattito (non certo con un atto autocratico del Governo), trattandosi di decisione che rimanda direttamente ed esplicitamente al diritto costituzionale. Inoltre, le sanzioni previste per chi non ottemperasse a tale obbligo di legge non potrebbero che essere amministrative, riguardando ammende pecuniarie ed eventualmente la esclusione dei non vaccinati dalla partecipazione ad attività o presenza in luoghi che prevedono l’incontro con altre persone suscettibili di venire infettate. La coercizione fisica o la condanna alla privazione della libertà non sono configurabili nella misura in cui il soggetto scelga (o sia obbligato) di avvalersi di altre valide misure profilattiche per evitare l’eventuale contagio di sé o degli altri: mascherina, occhiali od altri dispositivi di protezione individuale; igienizzazione delle mani; disinfezione dei locali in cui soggiorna; distanziamento fisico e ricambio d’aria; non accessibilità a determinati spazi od attività; ed altro ancora. Se l’obiettivo della profilassi (di cui la vaccinazione è solo una delle pratiche possibili) è la prevenzione della diffusione del coronavirus, come condannare ad una pena detentiva chi scegliesse e documentasse di attuare efficacemente azioni riconosciute sinora come utili per contenere la pandemia anziché sottoporsi alla immunizzazione indotta da un vaccino, esibendo le accettabili ragioni di questa scelta?
Neanche l’emergenza giustifica quella che in molti stanno invocando come «una forma d’obbligo» a vaccinarsi?
Il vaccino è uno strumento prezioso e deve essere promosso per tutti dopo una rigorosa validazione delle sue caratteristiche di sicurezza, efficacia e accessibilità. È un bene per la persona e per la società. Un bene comune. Ma come ogni bene deve essere offerto alla libertà e scelto dalla libertà di ognuno, non imposto. Senza il coinvolgimento attivo della libertà del cittadino – non escludendo il caso serio che la risposta non vada nella direzione auspicata – è dietro l’angolo lo scivolone verso il collettivismo o l’individualismo, tanto lontani tutt’e due dalla prospettiva del bene comune. Certo, sappiamo che la strada del coinvolgimento attraverso l’informazione, l’educazione e il consenso guadagnato onestamente è assai più lunga e faticosa di quella della imposizione autoritaria, che rischia di divenire dispotica. Ma sono un tempo e una fatica ben spesi, per “fare bene” il bene di tutti. Il bene va fatto per libertà, non per forza. Come scriveva San Paolo al suo collaboratore Filèmone, «non ho voluto far nulla senza il tuo parere, perché il bene che farai non sapesse di costrizione, ma fosse spontaneo» (Fm 1, 14). Anche il bene della profilassi individuale e sociale contro il flagello del Covid-19 non fa uno strappo a questo sano principio etico e civico, pur nella eccezionalità della situazione sanitaria in cui ci troviamo. L’emergenza non cancella la vocazione alla libertà attraverso la quale si costruisce la solidarietà, l’amicizia civica, la dedizione alla costruzione della “casa comune” che è la società. Al contrario, la sollecita come condizione imprescindibile.
(5. Fine)
Foto Ansa



0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!