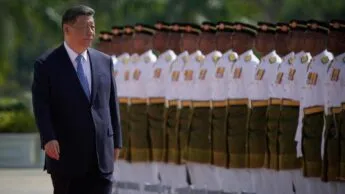
Mandela è stato ridotto ad un’icona, ma lui era l’uomo che diceva: «Non lodate me per maledire il resto»
«I will not leave South Africa, nor will I surrender. Only through hardship, sacrifice and militant action can freedom be won. The struggle is my life. I will continue fighting for freedom until the end of my days» (Nelson Mandela, 26 giugno 1961)
[internal_gallery gid=136715]
Da Stellenbosch (Sudafrica) – Nelson Mandela naque – il 18 luglio 1918 – con il nome Rolihlahla che in Xhosa significa letteralmente “che tira il ramo di un albero”. Ma fu lo stesso Mandela a spiegarne il vero senso, con ironico riferimento al destino scritto nei nomi: troublemaker, crea guai, attaccabrighe. Per i sudafricani è Madiba, il nome del suo clan. Tata Madiba, è il rispettoso modo con il quale i suoi compagni continuarono a rivolgersi a lui anche da presidente: dopo 27 anni di carcere e chissà quanti di trattative con gli Afrikaner dell’apartheid, Nelson Mandela divenne il primo presidente nero del popolo sudafricano chiamato tutto a votare per la prima volta il 27 aprile 1994.
Lui era l’unico che poteva sedersi a un tavolo con i suoi carcerieri: Mandela era un componente di uno dei rami della famiglia dei Thembu, che regnava sul Transkei; per studiare aveva lasciato il villaggio in cui era cresciuto – quella stessa Qunu dove si trova la sua residenza ufficiale – e si era laureato in legge durante gli anni dell’apartheid. Lo aiutarono molto due importanti avvocati bianchi di religione ebraica presso il cui studio Mandela iniziò a lavorare. Le occasioni di cui riuscì a godere nonostante le restrizioni giuridiche e quelle culturali, furono incredibili.
Il 26 aprile 1994 neri e bianchi, meticci e indiani si misero composti in lunghe code per votare, quattro anni dopo la fine ufficiale dell’Apartheid. Nelson Mandela, quando venne eletto a stragrande maggioranza, aveva 75 anni e un sogno ancora da portare a termine: «Assieme dobbiamo costruire una società in cui tutti i sudafricani, di tutti i colori, siano liberi di camminare dritti, senza paura nei loro cuori, sicuri dell’inalienabile diritto alla dignità umana: una Nazione Arcobaleno in pace con se stessa e con il mondo».
Fu così che nacque la Rainbow Nation, un concetto unico in un paese reso unico da quel processo di “riconciliazione” che evitò la probabile guerra civile già vista in tutti gli altri Stati africani diventati indipendenti. La commissione per la Verità e la Riconciliazione fu un Golgota sul quale salirono vittime e carnefici: fu un’ammissione di colpa di tutta una Nazione per quelli che avevano sangue sulle mani da pulire e per quelli che fecero finta di non vedere. Fu in molti casi una presa di consapevolezza di come il regime della “separazione” (questo significa apartheid in afrikaans) che si era via via estremizzato e di come quella convivenza separata si era avvelenata e radicalizzata. Non ci furono vendette ma rese dei conti sì: quelle erano già iniziate durante le trattative e Mandela fu duro nel chiedere, almeno quanto De Klerk – l’ultimo presidente Afrikaner – fu veloce nel concedere. I due, assieme, ricevettero nel 1993 il Nobel per la Pace e guidarono “assieme” il nuovo Sudafrica: poi l’ex presidente bianco se ne andò a vivere in Gran Bretagna mentre il nuovo presidente nero continuò a guidare il popolo sudafricano e a lottare anche contro i suoi compagni di sempre per cercare di non vanificare decenni di lotta pacifica e di lotta violenta e quel lungo difficile percorso verso la libertà. «Non lodate me per maledire il resto», avvertì i critici dell’African national congress.
La vendetta inutile
Il Sudafrica che ereditò Nelson Mandela era un paese ricco: ricco di diamanti e materie prime preziose, di aziende all’avanguardia, di un sistema sanitario di alto profilo che aveva visto i lustri con il primo trapianto di cuore al mondo a cura di Christian Barnard, all’ospedale pubblico Groote Schuur di Città del Capo. Il rand era forte sul dollaro e sulla sterlina, l’energia prodotta bastava per il Sudafrica e buona parte del continente africano, l’esercito era ben addestrato e in più, in quel 1994, gli Springboks vinsero i mondiali di rugby e al tifo patriottico dei bianchi si unì quello orgoglioso dei neri che fino a quel momento avevano identificato la palla ovale con i loro oppressori. Mentre cercava di mantenere gli standard economici che il paese aveva raggiunto e correva in tutti gli angoli del mondo per una rinnovata apertura internazionale, Mandela evitò il saccheggio brutale e l’umiliazione dell’avversario: i bianchi detenevano il potere economico e Mandela non voleva che il Sudafrica, per il quale aveva lottato e patito, facesse la fine del confinante Zimbabwe. Cacciare i bianchi come aveva fatto il dittatore Robert Mugabe, ancora oggi al potere, avrebbe significato lo stesso destino di depauperamento e di disperazione per milioni di neri, si sarebbe trasformato in aziende agricole incolte e seccate dal sole, posti di lavoro cancellati con un colpo di spugna, inflazione, povertà, fuga. Lo racconta egregiamente il film Invictus, questo delicato passaggio: la ricostruzione di Clint Eastwood è precisa nei minimi dettagli. Il presidente Mandela che non licenzia gli impiegati bianchi che fino ad allora avevano servito i governi Afrikaner ma che dice loro di andarsene, se incapaci di aderire al nuovo Sudafrica; il presidente Mandela costretto a irrompere in un comitato dell’Anc che vuole cambiare i nomi di tutto.
Una vendetta inutile che invece si sta mettendo in pratica oggi, con nuove titolazioni di strade e addirittura di città. Ha ragione Antjie Krog, poetessa, scrittrice, giornalista, ex direttore dell’Istituto per la Giustizia e la Riconciliazione: «Il mondo continua a guardare come a un’icona piuttosto che come a un grande leader. Vogliono tenere le sue mani, avere le sue foto ma mai, mai capire cosa sta cercando di indicare. È un rifiuto universale ad accettare il suo spirito».
E infatti il mondo non capì – anzi proprio non guardò – la portata del gesto che Mandela fece il 16 agosto 1995 quando si recò a Orania, enclave dei bianchi afrikaner duri e puri: arrivò nello sperduto villaggio del Northern Cape per incontrare la moglie 94enne dell’ex presidente Hendrik Verwoerd, soprannominato l’architetto dell’apartheid. Le critiche dai compagni dell’Anc furono feroci, ma Mandela non si fece intimidire e proseguì sul suo percorso di riconciliazione, dando l’esempio primo fra tutti: «Dobbiamo far capire anche ai più duri elementi della destra del paese che si devono sentire parte del nuovo Sudafrica», disse.
Il nuovo razzismo
Diceva cose scomode e impegnative, Nelson Mandela, a partire da quel semplice concetto sull’istruzione quale strumento unico per superare le iniquità. I suoi successori – a partire subito da Thabo Mbeki – preferirono la Black Economic Empowerment (Bee), l’affemative action che obbliga le assunzioni in base al colore della pelle. Un modo per ripareggiare i conti con secoli di esclusione, si disse. Ma da anni le critiche arrivano anche dagli intellettuali neri e coloured liberi di pensiero. «La Bee è la soluzione sbagliata perché aiuta una ristretta elite principalmente in base alla sua vicinanza all’Anc, piuttosto che per le loro reali capacità di creare e condurre le realtà economiche», scrive William Gumede nella prefazione a una delle autobiografie di Mandela, No Easy Walk to Freedom.
E soprattutto quello dell’istruzione è il principale fallimento. «L’istruzione è l’arma più potente per cambiare il mondo», è una delle frasi più famose di Mandela. E invece è il settore in cui di meno si è investito in questi due decenni: o meglio, a fronte di un consistente esborso di soldi, con percentuali simili a quelle del mondo occidentale, nelle township e nelle aree rurali l’alta eccellenza dell’istruzione sudafricana lascia il posto a scuole in container roventi d’estate, gelati d’inverno e troppo piccoli per tutti, tanto da ammassare alunni di diversi gradi o da richiedere turni mattutini e pomeridiani. E il basso livello degli insegnanti è considerato la principale causa degli insoddisfacenti risultati scolastici che ogni anno si registrano tra gli studenti neri e poveri.
Anche il ministro dell’Educazione ha ammesso questa grave lacuna da colmare, ma nel frattempo in questi quattro anni non ha varato le nuove linee guida e gli standard delle infrastrutture. Però provvedimenti sono stati presi, sono andati nella direzione di un abbassamento delle richieste e delle offerte formative: per accedere all’università non solo ci sono quote riservate in base al colore della pelle, ma ai neri sono richiesti voti inferiori rispetto ai bianchi. Ecco una delle tante cose che fa urlare al razzismo i sudafricani discendenti dai coloni olandesi e quelli di origini inglesi e che preoccupa gli analisti economici – di qualunque colore – per il futuro della Rainbow Nation. Con un livello di disoccupazione giovanile al 45 per cento, un mercato del lavoro sempre più globale e una crescita economica in forte rallentamento che cede il passo ad altri paesi africani più poveri, e con storie ancor più travagliate, come la Nigeria.



0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!