
Socialmente distanziati, politicamente morti. L’avvento del tiranno premuroso

Articolo tratto dal numero di giugno 2020 di Tempi. Questo contenuto è riservato agli abbonati: grazie al tuo abbonamento puoi scegliere se sfogliare la versione digitale del mensile o accedere online ai singoli contenuti del numero.
Le pandemie flagellano l’umanità. È sempre stato così e sempre lo sarà. Nel XX secolo, l’influenza spagnola del 1917 uccise 50 milioni di persone. La quasi dimenticata influenza asiatica del 1957 si portò via tra uno e due milioni di persone. Chi ha alle spalle abbastanza primavere da ricordare gli anni Sessanta sa che l’influenza di Hong Kong del 1968 uccise un milione di persone in tutto il mondo.
Per quanto riguarda l’attuale influenza di Wuhan – più educatamente conosciuta come Covid 19 – i modelli riguardo al tasso di mortalità variano molto. Più di 250 mila persone sono già morte in tutto il mondo a causa del nuovo coronavirus o insieme al coronavirus. L’attuale lockdown globale, inconcepibile durante le pandemie del XX secolo, porta a diverse conseguenze. Prima di tutto, isola temporaneamente dall’esposizione al virus molte persone. In secondo luogo, ne espone altre eccessivamente – soprattutto, come è noto, gli anziani e i degenti, che vengono posti in quarantena con altri in strutture infettate dal virus. Terzo, solleva un gran numero di domande su come dovremmo vivere cui i dottori e i nostri esperti sanitari semplicemente non sono in grado di rispondere.
Innanzitutto, bisogna porre il problema del rapporto tra medicina e politica. La prima persona a riflettere con attenzione su questo tema è stato Aristotele, nel IV secolo a.C. ad Atene. Nelle battute iniziali della sua Etica Nicomachea, il filosofo dichiarava che alla scienza maestra della politica tutte le altre scienze – medicina inclusa – sono subordinate. I dottori dell’Organizzazione mondiale della sanità o il Centro americano per il controllo delle malattie possono dichiarare, nel nome della scienza medica, che un paese debba essere posto in isolamento e che chiunque vive al suo interno debba entrare in quarantena. Noi però non viviamo in ospedali; viviamo in comunità politiche per le quali la sopravvivenza fisica dei propri pazienti, cui i dottori tengono tanto, è solamente un bene tra tanti.
Noi andiamo negli ospedali, non viviamo dentro gli ospedali. La comunità politica, e non la comunità dei professionisti sanitari, deve prendere le decisioni riguardo al lockdown, sulla base dei consigli della comunità medica e di un gran numero di altre comunità che hanno idee legittime su come vivere nel modo migliore. Il bene più alto di tutti non è la vita, ma vivere bene. Ed è proprio quest’ultimo che la comunità politica determina, presumibilmente attraverso un processo di decisione serio e continuo.
Proprio come la comunità politica a volte cede il passo a ciò che gli economisti raccomandano e a volte no, allo stesso modo in alcuni casi ascolterà ciò che la comunità medica raccomanda e in altri no.
La scienza più alta è la politica, non la medicina o l’economia. Questa affermazione non dovrebbe giustificare atteggiamenti avventati, ma spingerci a riconoscere una scomoda verità: e cioè che non tocca soltanto ai medici determinare che cosa è “bene”. L’uomo è un “animale politico”, ha scritto notoriamente Aristotele. Faremmo bene a pensare seriamente a che cosa significa in mezzo a questa pandemia di influenza di Wuhan nella quale i dottori sembrano avere l’ultima parola.
La piaga della solitudine
Per diversi mesi abbiamo prestato ascolto agli esperti medici che ci hanno spiegato come tenere alla larga la morte. Per cambiare, e per avere un contrappunto, ascoltiamo ora il grande dottore politico della democrazia del XIX secolo, Alexis de Tocqueville, per vedere che cosa ha detto a proposito della malattia politica del nostro tempo e di come possiamo vaccinarci da essa.
Forse la cosa più problematica riguardo alla malattia politica da cui siamo affetti è che il “distanziamento sociale”, che i nostri esperti medici raccomandano per tenere a debita distanza la morte, è proprio ciò che il nostro buon dottore Tocqueville indicava come fatale al corpo politico nell’era democratica. Sembra che ci sia più di un modo per morire.
Quando pensiamo alla democrazia oggi, pensiamo spesso al consenso dei governati, alla rappresentanza politica e a elezioni libere e giuste. Queste cose sono importanti, ma Tocqueville pensava che si potesse finire tra le braccia del dispotismo democratico nonostante il consenso, la rappresentanza ed elezioni periodiche. Con una grande intuizione, Tocqueville predisse che nell’era democratica sarebbero scomparsi i ruoli e i doveri che contraddistinguevano gli uomini nell’era aristocratica, mentre li avrebbero investiti le piaghe della solitudine, dell’isolamento e della mancanza. Contemporaneamente, tutti i legami che lo legavano agli altri si sarebbero spezzati.
Avvenuto tutto ciò, Tocqueville temeva che l’uomo non si sarebbe più rivolto ai suoi vicini, ai familiari, alla comunità o alla Chiesa per risolvere i propri problemi e costruire un mondo insieme, ma piuttosto al governo. Lo Stato sarebbe così diventato l’unico potere visibile al quale fare riferimento. E perché gli uomini avrebbero dovuto farlo? A causa della loro impotenza, pigrizia e paura; e a causa del compito straordinariamente difficile rappresentato dalla gestione dei rapporti sociali senza la guida che i ruoli e i doveri una volta fornivano.
«Perché rivolgere lo sguardo fuori da sé gli uni agli altri quando possiamo guardare sopra allo Stato – o forse all’Unione Europea – per tutti i nostri bisogni?». È questa la domanda dell’uomo democratico. Questo cambio di prospettiva, pensava Tocqueville, produce un circolo vizioso: più le persone si rivolgono al governo e meno fanno affidamento le une sulle altre; meno fanno affidamento le une sulle altre per risolvere i loro problemi e più il governo deve intervenire per farlo. Il governo diventa così più forte giorno dopo giorno, mentre i legami tra i cittadini si indeboliscono progressivamente. E insieme alla dissoluzione dei legami si rafforza il filo che lega i cittadini al governo.
Quando la “distanza sociale” tra i cittadini sarà sufficientemente ampia, il dispotismo democratico arriverà. Nel frattempo, tutto il bagaglio della democrazia – il consenso del governato, la rappresentanza politica, elezioni libere e giuste – rimarrà intatto, come se niente fosse cambiato. In realtà, il dispotismo democratico sarà già arrivato. Alla luce del sole tutto sembrerà uguale a prima, ma in segreto emergerà una tiranna gentile e premurosa. La sua causa sarà stata un distanziamento sociale sempre più grande.
I privilegiati digitali
I nostri esperti medici raccomandano il distanziamento sociale per salvarci dalla morte che si avvicina. A molte persone questo ha causato terribili difficoltà. Gli ultimi tra noi, quelli che portano il peso della povertà nelle sue tante forme, saranno caricati delle conseguenze sproporzionate del lockdown globale per molti anni a venire. Per un gruppo sufficientemente grande di altre persone, però, i disagi sono stati in qualche modo familiari. Per loro, la pratica del distanziamento sociale non è qualcosa di interamente nuovo, ma piuttosto un allargamento delle abitudini confortevoli che già avevano maturato.
Queste persone sono i privilegiati digitali, il cui lavoro, vita sociale e comfort casalinghi sono assicurati dal magico movimento delle dita su una tastiera del computer. La pandemia ha soltanto portato quel modo di vivere che loro già praticavano alla sua logica conclusione. Ora, possono realizzare tutte le loro “riunioni” in videoconferenza, trovarsi con tutti i loro “amici” sui social e “fare spese” comprando tutto ciò di cui hanno bisogno online da casa. Poiché il virus influenzale di Wuhan non può viaggiare su internet, il loro mondo digitale offre quella protezione a lungo agognata.
Allo stesso tempo, sono sollevati dagli inconvenienti che gli incontri reali, le amicizie genuine e il vero shopping sempre implicano. Per farla breve, vivono in un mondo comodo e libero dalla morte.
Dovremmo forse rimanere sorpresi dal fatto che la giustificazione originale per il lockdown – e cioè che bisognava evitare il collasso dei nostri ospedali – ora è cambiata? Ovviamente no. Una nuova giustificazione ha preso il suo posto: i privilegiati digitali vogliono rimanere sani e al sicuro in un mondo isolato e igienizzato, fino a quando non venga sviluppato un vaccino che li liberi dalla morte.
Cosa vuole il tiranno
Tocqueville temeva che proprio questo comprensibile quanto distruttivo desiderio per un mondo sano e sicuro avrebbe portato alla fine al dispotismo gentile e premuroso. E propose di sviluppare abbastanza coraggio da vivere in un mondo caotico e scomodo. In un simile mondo il lavoro è difficile ma necessario e bisogna vestirsi per le riunioni; le amicizie richiedono una stretta di mano, un abbraccio o un pasto da consumare insieme; e l’arte di creare una casa meravigliosamente accogliente si impara là fuori, nel mondo, non davanti allo schermo di un computer.
Abbiamo oggi il coraggio necessario per vivere in un mondo caotico e scomodo, dove la morte è un problema tra i tanti? Abbiamo il coraggio di vivere bene e trasmettere ai nostri figli ciò che nella nostra civiltà c’è di Buono, Vero e Bello? Queste sono le domande che l’influenza di Wuhan ci invita a porci.
Tocqueville capì che il distanziamento sociale ci protegge sì dal mondo caotico, scomodo e falcidiato dalla morte, ma ci conduce anche alla tirannia politica. «Un tiranno non si preoccuperà se i cittadini non lo amano, a condizione che non si amino tra loro», scriveva Tocqueville. Tenere le persone separate, assicurarsi che non facciano affidamento le une sulle altre per vivere bene, far sì che guardino solo al governo per tutti i loro bisogni – ottieni questo e inoculerai un virus che porterà alla morte politica della tua vibrante comunità.
I dottori ti garantiranno che sono state salvate delle vite. E avranno ragione. Peccato che non c’è solo una morte cui si può soccombere. La terribile conseguenza di tenere alla larga un tipo di morte a tutti i costi è che invitiamo un altro tipo di morte nella nostra comunità politica.
«La Chiesa è il veleno che ci offende»
Il coraggio, virtù greca, potrebbe non essere l’unica necessaria. La speranza, virtù cristiana, potrebbe essere altrettanto importante. Ahimè. «L’Europa», mi direte, «è stata modellata dal cristianesimo, ma non sa più che farsene. Qui nessuno ascolterà inutili discorsi sulle virtù cristiane. Forse ti ascolteremo a riguardo del coraggio dei greci, ma non attaccare con la solfa della speranza cristiana».
Per quanto rivoluzionario sia il tentativo di rovesciarlo, ad ogni modo, il passato non si può cancellare. La grammatica cristiana resta alla base dell’Europa anche se oggi le parole sono anticristiane. E il credo del cristianesimo non è cambiato: siamo nati nell’Eden liberi dalla morte, siamo stati cacciati dall’Eden e finiti in un mondo dove la morte ci tallona di continuo a causa del peccato, eppure certi della promessa di Cristo che la morte e il peccato non sono l’ultima parola. L’Europa contemporanea non si è ancora sbarazzata della dottrina cristiana sulla doppia maledizione del peccato e della morte nel mondo post-edenico, e continua a cercare rimedio a entrambi.
Friedrich Nietzsche scrisse alla fine del XIX secolo: «È la Chiesa e non il suo veleno che offende noi moderni europei». Lui si domandava come mai i suoi illuminati contemporanei cercassero di espiare le loro trasgressioni invece che dimenticarle semplicemente, come si dovrebbe fare in una vera era post-cristiana.
Non è forse l’Unione Europea di oggi costruita su questo arcaico bisogno cristiano di espiare i propri peccati nazionali commessi durante il colonialismo e le due guerre mondiali? Credere oggi nella nazione non equivale forse a convivere imperdonabilmente con il peccato? La grammatica cristiana del peccato rimane, ma l’espiazione non si ottiene più attraverso il perdono cristiano, che è oggi respinto. Oggi, l’espiazione in Europa si realizza attraverso la confessione di fede nell’Unione Europea.
«Chi ha fede, sarà libero»
Allo stesso modo la maledizione cristiana della morte ancora cattura l’immaginazione europea. Non accettando più di vivere in un mondo post-edenico dove la morte è sempre in agguato, ma nella speranza e confidando che la sua maledizione sarà distrutta da Cristo, l’immaginazione europea si rivolge all’altra alternativa, e cioè al ritorno al mondo dell’Eden dove non esiste la morte. Non abbiamo forse già preparato la strada per questo ritorno immaginando un’energia verde, pulita, immortale?
Credere che la quarantena sia in grado di isolarci dalla morte fino a quando un vaccino non ci proteggerà da essa è sconcertante. Questa non è scienza; è piuttosto un desiderio religioso di tornare al tempo in cui l’uomo non era toccato dalla maledizione della morte, un desiderio facilitato dall’invasività della tecnologia e da un sistema politico navigato che lucra sulle paure che il cristianesimo aveva sopito. Ecco perché Tocqueville scrisse: «Se un uomo ha fede, sarà libero; se non ce l’ha, ubbidirà».
Se viviamo nella speranza che la morte non è l’ultima parola, allora prenderemo precauzioni ragionevoli durante l’epidemia per proteggere i soggetti più vulnerabili e continuare a vivere nelle comunità politiche che ci sostengono. Se crediamo invece che la morte sia l’ultima parola, isoleremo subito e in attesa della prossima pandemia il mondo intero, praticheremo il distanziamento sociale e rinunceremo a quei rapporti faccia a faccia senza i quali siamo condannati al suicidio politico.
***
Joshua Mitchell, autore di questo articolo, insegna alla Georgetown University ed è considerato tra i massimi studiosi di Tocqueville. Ha scritto “The fragility of freedom: Tocqueville on Religion, Democracy and American Future” (1995) e “Plato’s Fable” (2006). A novembre uscirà “American Awakening: Identity Politics and Other Afflictions of Our Time”.
Foto Ansa
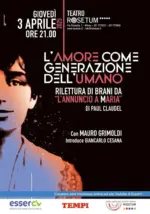
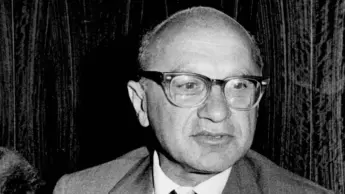

0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!