
Il sugo della storia
Anche le scuole italiane si aprano alla scoperta del grande Eugenio Corti
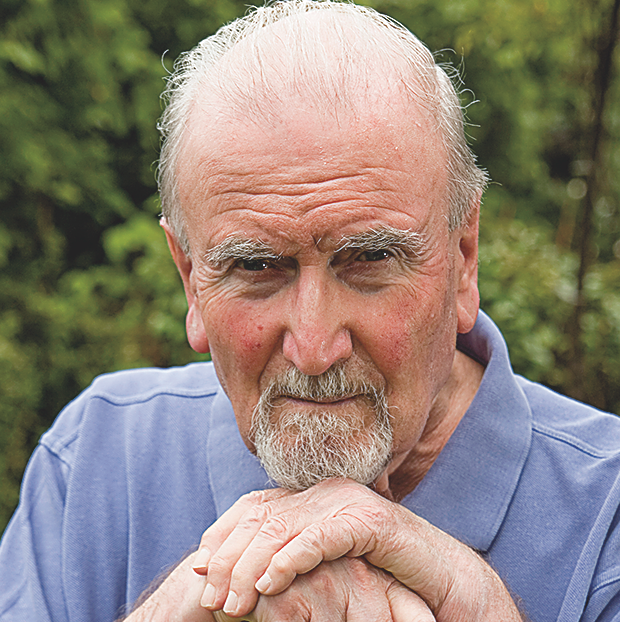 In partenza per il fronte russo (9 giugno 1942), Corti scrive alla famiglia: «Mamma e papà carissimi, questa mia vi giungerà che io sarò in viaggio per il Fronte russo. Ve la scrivo perché voglio che sappiate con quali sentimenti io parto. Vedo questa mia partenza per la guerra, come tutte le altre cose che capitano nella vita, inquadrata nei piani superiori della Provvidenza. Anzitutto per quanto riguarda me nelle mie relazioni con tutta l’umanità: non è giusto, vi pare, che mentre tutti i giovani della mia età, di quasi tutte le nazioni, sono coinvolti in questa grande prova, io ne rimanga fuori. Ma c’è di più: domani a questa guerra, come a tutte le guerre, seguiranno rivolgimenti e contrasti. Io non vorrò restarmene neghittosamente fuori: parteciperò anch’io in favore della Religione, della Famiglia, dello Spirito, di tutte quelle cose insomma in cui voi m’avete educato e nelle quali fermamente credo».
In partenza per il fronte russo (9 giugno 1942), Corti scrive alla famiglia: «Mamma e papà carissimi, questa mia vi giungerà che io sarò in viaggio per il Fronte russo. Ve la scrivo perché voglio che sappiate con quali sentimenti io parto. Vedo questa mia partenza per la guerra, come tutte le altre cose che capitano nella vita, inquadrata nei piani superiori della Provvidenza. Anzitutto per quanto riguarda me nelle mie relazioni con tutta l’umanità: non è giusto, vi pare, che mentre tutti i giovani della mia età, di quasi tutte le nazioni, sono coinvolti in questa grande prova, io ne rimanga fuori. Ma c’è di più: domani a questa guerra, come a tutte le guerre, seguiranno rivolgimenti e contrasti. Io non vorrò restarmene neghittosamente fuori: parteciperò anch’io in favore della Religione, della Famiglia, dello Spirito, di tutte quelle cose insomma in cui voi m’avete educato e nelle quali fermamente credo».
La preoccupazione principale di Corti è che papà e mamma possano essere angustiati per lui. Per il resto Corti parte sereno con una certezza: «Ciò che viene dalle mani di Dio dà sempre gioia. Vorrei che anche voi riusciste a pensarla come me. E ricordatevi: tornerò. Da quanto vi ho detto prima è chiaro che devo tornare […]. Sento che Dio mi guida per una strada che Lui solo conosce, ma che è ancora lunga. Il fatto che io sia, pur frequentando legge, di artiglieria, serve pure a comprovare questa mia sensazione».
La vocazione di scrittore di Eugenio Corti nasce quando è ancora ragazzino, incontrando la grande epopea dell’Odissea, poema in cui Omero era riuscito a trasformare in bellezza ciò di cui trattava. «Da grande» si era ripromesso il piccolo Corti «anch’io farò lo stesso». È una chiamata a trasmettere la grandezza della vita, a rendere gloria a Dio per il dono del creato, conscio che non c’è circostanza dell’esistenza a cui non siamo chiamati, non c’è nulla che non abbia senso. Se ogni circostanza ha senso, allora ogni momento ci chiama ad un compito e ad una responsabilità.
Il riconoscimento dell’opera di Corti è certo. Il suo Cavallo rosso ha raggiunto la trentunesima edizione dal 1983, ma anche I più non ritornano, il primo diario pubblicato sulla guerra in Russia, relativo ai ventotto giorni in una sacca sul fronte, è alle diciannovesima. Completano la sua ampia produzione Gli ultimi soldati del re, L’isola del Paradiso, Catone l’antico, La terra dell’indio, Il Medioevo e altri racconti, Il fumo nel Tempio, Processo e morte di Stalin. La casa editrice Ares ha il grande merito di aver colto la statura dello scrittore e di aver pubblicato l’intera produzione. Il miglior modo per celebrare un autore è quello di diffondere, di far conoscere il valore della sua opera. Del resto, questo significa il termine “celebrazione”, in latino vuol dire rendere affollato, partecipare in maniera numerosa ad un evento.
Eppure colpisce il fatto che pochi in Italia gli rendano il merito che gli spetta, che il suo nome sia pressoché assente nelle scuole, così come poco nota è la sua figura anche tra il mondo degli insegnanti. Non è allora piccola la responsabilità di chi ha incontrato l’autore e conosciuto la sua opera. Il primo compito è quello di diffondere i suoi scritti contribuendo all’affermazione del romanziere come un classico del Novecento, da leggersi nelle scuole come testimonianza di grande letteratura e, nel contempo, come documento storico e umano di un pezzo della storia italiana e universale. Un classico sa raccontare la vita, intercettando le domande dell’uomo di ogni tempo, il suo anelito alla verità e alla bellezza, alla felicità e alla salvezza.
Da qualche mese si è aperta una nuova fase negli studi dell’opera di Corti che sarà foriera di sviluppi futuri nello studio della genesi del capolavoro Il cavallo rosso. Sempre per conto di Ares sono state, infatti, pubblicate le lettere e le cartoline scritte da Corti durante la guerra, dal 6 giugno 1942 al 29 gennaio 1943. Il titolo della silloge è Io ritornerò. Una testimonianza unica dal punto di vista storico ed umano. Ma aggiungerei di più. La rilevanza letteraria dei documenti è grandissima, perché l’epistolario è una vera e propria fucina di uno scrittore che ha già scoperto la sua vocazione. Come lo Zibaldone di Leopardi permette di rinvenire la genesi dell’”Infinito” o del “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”, allo stesso modo le lettere dalla Russia di Corti ci offrono l’occasione spinta (per usare un’espressione cara a Montale) di tanti episodi del Cavallo rosso.
Alessandro Rivali, che ha curato la raccolta, ha annotato i molti punti di contatto tra le lettere e Il cavallo rosso. Solo per addurre qualche esempio, racconta il curatore, «la partenza della tradotta di Corti e l’analoga esperienza vissuta dal personaggio di Ambrogio, il primo contatto con i morti russi, la migrazione delle anatre e dei ragni trascinati dal vento, la descrizione della “terra dei cosacchi”, l’arrivo della corrispondenza al fronte, le incursioni degli aerei russi». «Le lettere» continua Alessandro Rivali «furono il regalo più inaspettato di un autore nei confronti di un giovane innamorato della storia. Corti mi fece capire che nel suo solaio erano nascoste le lettere in cui c’era la genesi del Cavallo rosso. Quando parlava con me, non parlava con l’editor della casa editrice, ma all’amico Alessandro Rivali. Questo è l’uomo Eugenio Corti».
Le lettere sono solo un piccolo spiraglio che rivela il cantiere nascosto di Corti che è molto ampio, ricco di tesori. Le carte che Rivali ha consultato lasciano intuire la passione per la verità dello scrittore che voleva essere documentato in maniera certosina su tutto quanto scriveva. Possiamo riscontrare questo scrupolo documentario nelle annotazioni presenti nei libri presenti a casa Corti. Vi sono decine e decine di volumi sul comunismo che attestano come il romanziere voleva che nella propria storia tutto fosse vero. Corti aveva descritto con tanta precisione e verità i reparti degli alpini che quando i reduci della campagna di Russia lo incontravano gli chiedevano in che reparto degli alpini fosse stato.
Ora l’auspicio è duplice: le scuole e gli insegnanti si aprano alla scoperta di questo grande autore; si tenga anche in Italia un importante convegno sulla sua figura, come è accaduto in occasione del secondo anniversario della morte il 29 e 30 gennaio all’Università Sorbona a Parigi con la partecipazione dei più importanti studiosi a livello internazionale.
Articoli correlati
5 commenti
I commenti sono chiusi.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!



Corti è, a differenza di Dante, più un filosofo che un letterato.
Si occupa più della profondità del mare che della schiuma della vita, di cui si occupa la letteratura.
Non è uno scrittore per parrucconi, per cultura, ma un amante della sapienza per natura, per nascita e necessità.
La sua opera ha per oggetto la vita, la sua preziosità, vista con gli occhi, per dirla con il padre Barzaghi, di un santo moribondo.
Per vedere la preziosità della vita la devo vedere contestata, contrastata continuamente, come nell’agonia dei miei malati, dei suoi commilitoni, dalla sua antagonista, la morte.
Solo costoro ne possono apprezzare radicalmente la bellezza, la grandezza, la preziosità!
Per far questo non bisogna far finta di essere moribondi, ma visitare i moribondi, essere fra essi, come Eugenio. Chi fa finta di essere morente è il giocatore di scacchi, anche lui un agonista, ma finto.
Per intra-vedere il barlume negli occhi del santo moribondo, la santità, la bellezza di Cristo sul Golgota, bisogna essere nell’atroce vallata di Arbusov.
Il filosofare è, per il maestro di Platone e Aristotele, esercizio verso la morte: io non temo la morte perché è separazione del composto dal semplice, dall’eterno, o meglio dalla vita eterna (solo Dio è eterno, l’anima è creata, è vita eterna, non eternità).
Il filosofare è preparazione a ciò che poi sarà eterno.
Nello sguardo del capitano Grandi tutto l’umano è messo in discussione, eccetto qualcosa, il divino.
Anche Qoelet dice che non c’è nulla di nuovo. Non resta nessuna cosa affidabile, eccetto credere in Dio (sia benedetto il Suo Nome santo!) e osservare la Sua Legge.
Sto rileggendo Il Cavallo Rosso. E’ ancora meglio, molto meglio della prima volta!
Della trilogia di Corti, Il Cavallo Rosso, ho letto il primo e il terzo romanzo (ho saltato il secondo perché supponevo che fosse per contenuto e stile simile al primo). Non metto in dubbio che la vicenda narrata possa essere interessante, ma per scrivere un romanzo bisognerebbe avere anche un qualche talento di scrittore, ed invece è proprio questo ciò che manca a Corti. Il suo stile è scialbo, monotono, privo di invenzione. Si sforza di essere asciutto, incisivo, ma è solo noioso e ripetitivo. Mi ha colpito in particolare, fin dalle prime pagine, il frequente ricorso al cosiddetto “nesso relativo”, uno stilema di derivazione classica, che rivela una sorta di ingenuo omaggio e adeguamento, da parte dello scrittore, all’idea che il linguaggio letterario risulti più elevato ricorrendo a certe “eleganze”. Lo usa talvolta anche Manzoni ( il nesso relativo), ma un lettore attento ne coglie subito il risvolto ironico. L’ironia purtroppo è una dote di cui Corti è completamente privo. Se c’è, e del tutto involontaria. Basti leggere le pagine quasi penose su Nilde Iotti, allieva dell’Università Cattolica di Milano. Se dovessi giudicare Corti con una formula sintetica lo definirei un volonteroso senza talento.
Linguaggio a parte, penso che si possano fare anche altre considerazioni circa la mediocrità di Corti come romanziere. Ho sempre pensato, e verificato, che i grandi scrittori e poeti sono sempre ideologicamente “irriducibili”. Potrei citare le numerose interpretazioni critiche che vedono in Leopardi o Manzoni o Verga o Pascoli ecc. ora un “progressista” ora un “conservatore”, anche con valide argomentazioni, ma certamente insufficienti e inadeguate a spiegarne la complessità. La natura umana e la visione storica a cui attingono i grandi artisti sono troppo complicate e profonde per essere inquadrate in uno schema ideologico. Al contrario, ogni pagina del buon Corti trasuda “ideologia”. Quella dell’Opus Dei o di Plinio Correa De Oliveira, tanto per intenderci, che trova l’origine di tutti i mali del mondo nel Rinascimento, seguito dall’Illuminismo, dalla rivoluzione russa e infine dal ’68. In questa visione apocalittica di inarrestabile decadenza, tutti i guai dell’umanità sono cominciati da quando la chiesa ha progressivamente cessato di esercitare la propria egemonia culturale sulla società. Il mondo di Corti risulta così ingenuamente diviso tra “buoni” e “cattivi” senza nessuna visione critica. Si può supporre che Manzoni (a cui qualcuno ha avventatamente accostato Corti) non avesse una grande stima dell’intelligenza della plebe milanese che saccheggiava i forni, ma almeno ha cercato di capirne le ragioni in pagine giustamente memorabili. Ma da dove saltano fuori i “cattivi” (i comunisti) nella pagine di Corti? Si era accorto che in Italia, nel dopoguerra, c’era stata una “rivoluzione” che aveva trasformato un paese ancora contadino in una potenza industriale? Forse sì, ma probabilmente la riteneva conseguenza del Rinascimento, oppure opera del demonio. In definitiva, oltre alla debolezza formale anche la rozzezza dello schema ideologico fa sì che il “romanzone” di Corti non meriti, almeno a mio parere, il tempo e la fatica necessari per arrivare fino in fondo.
P. S. Mi sono preso la briga di googlare i nomi dei partecipanti al convegno di Parigi. Sono tutti personaggi legati all’Opus Dei o al mondo del tradizionalismo cattolico. Lo schema utilizzato è quello di far passare Corti per una vittima della critica letteraria (e dell’editoria) che, essendo tutta sbilanciata a sinistra, avrebbe organizzato una specie di ostracismo contro lo scrittore cattolico. Ungaretti, Pirandello e molti altri erano stati fascisti convinti. Celine e Pound vigorosi antisemiti e collaborazionisti. La critica si è dovuta confrontare con la loro arte e non ha potuto negarne la grandezza. Evidentemente la modestia del romanziere Corti non ha mai suscitato altrettanto interesse.
Le auguro di leggere proprio il secondo volume. Se non ha lacrime,vuol dire che sarà anche un grande critico, ma le mancherà il retro-scena, lo sguardo contemplativo di una natura filosofica, divina.
Coinfermo, purtroppo. Corti è del tutto assente nelle scuole e nei testi usati, quasi del tutto sconosciuto agli insegnanti. La cultura dominante è totalitaria.Questo autore dalla fede grande e dalle grandi capacità di scrittore va riscoperto. La cultura non può essere a senso unico.