
Scola: La politica siamo noi (intervento integrale e video)
Commento del cardinale alle relazioni di monsignor Franco Giulio Brambilla, vicario episcopale per la cultura, Paolo Biscottin, direttore del Museo diocesano, Enrico Decleva, rettore dell’Università degli studi, Gianni Riotta, editorialista de La Stampa, Giacomo Poretti, attore, sceneggiatore e regista, membro trio comico di Aldo, Giovanni e Giacomo, Ferruccio Parazzoli, editore e scrittore
Il cardinale non deve, non è suo compito oggi parlare. Il suo compito oggi è di ascoltare, di imparare un poco. Anzitutto voglio dire il mio grazie a tutti voi, a cominciare dall’intelligenza con cui i collaboratori diocesani hanno voluto e preparato questi incontri, tesi a facilitare l’inizio di questo compito che mi è stato affidato in un’età, ahimè, non più giovanile, e che quindi, anche solo per quello, fa un po’ tremare le vene e i polsi. Milano ce l’ho nel cuore da sempre, non solo perché sono un ambrosiano purosangue, ma perché Milano ha sempre eccitato la fantasia di me bambino, subito dopo la guerra, quando si cominciava a conoscere, per la presenza dei soldati americani, il chewingum e lo si mandava giù, perché non si era capito che non bisognava mandarlo giù, con tutte le conseguenze del caso. Oppure quando gli stessi soldati americani giocavano con noi bambini un po’ come se fossimo delle palle da scagliare l’uno verso l’altro, e tuttavia percepivamo di uscire da un clima terreo, perché lì, sempre in questa villa settecentesca nella cui corte abitavo, con i miei erano passati prima i tedeschi e poi i repubblichini.
La gioia del cambiamento, della fine della guerra, e anche la presenza vivace dei soldati americani che parlavano dei loro incontri, dei loro viaggi. La prima volta che ho sentito la parola Milano avrò avuto sette anni, fu proprio da parte di due soldati americani, uno nero e l’altro bianco, che tornavano particolarmente ubriachi da una visita alla città. E questo cominciò un po’ a sollecitare la mia fantasia, che poi crebbe.
Scusate questo incipit autobiografico, può essere un po’ seccante ma mi sembra il taglio migliore per accogliere tutte le suggestioni che ho avuto. Quando venivamo, soprattutto al liceo, a vedere le prime mostre, ricordo la grandissima discussione che avemmo tra noi, con i docenti e con il professore di religione, quando ci fu la famosa mostra di Modigliani e vedemmo per la prima volta i celeberrimi nudi, con tutto lo scandalo che questo provocò, e il dibattito che nacque. E poi su fino ai temi dell’università, in cui Milano cominciò a diventare la mia città.
Quindi la prima cosa che voglio dire è che è giusta la parola “ritorno”, per me, dopo tanto girare, tanto pellegrinare, tanti compiti tra loro diversi, talora anche contrastanti, se penso a cosa ha voluto dire essere vescovo di una realtà potentemente popolare e grezza come la maremma, creativa, inventiva, con una coscienza di popolo che forse, almeno fino a quando ci sono stato io, ormai sono passati quasi vent’anni, era forse un’isola serena dentro la realtà complessa e articolata del nostro paese.
Dopo tanto girare, torno a casa. Passata la botta del distacco di Venezia, perché si perde molto, ho perso molto, ho pagato molto venendo via da Venezia, proprio perché Venezia è qualcosa. E ti costa lasciare ciò che vale. Ma mano a mano che in questi tre mesi mi sono avvicinato a Milano, questo sentimento pacifico del tornare a casa mi è entrato nelle vene, nei polsi, nel cuore ed è quello che mi dà pace di fronte all’impervietà di questo compito, che cercherò di svolgere con i miei collaboratori, perché l’Io di ogni autorità, e di un vescovo in particolare, permettetemi questo vocabolo un po’ laico, o è collettivo o non è.
Non esiste altra possibilità che non sia questa, e questo dovrebbe essere un segno indicativo per l’esercizio di ogni tipo di autorità: è impensabile che sia diverso. Perché l’Io è per sua natura in relazione, e l’Io di chi è chiamato a una responsabilità sociale, ecclesiale, se non vive, come ha detto all’inizio monsignor Brambilla, l’alterità come la condizione normale, per forza implode, per forza si inaridisce.
Io sono uso prendere appunti e segnare con degli asterischi la frase o la parola che più mi colpisce, e in genere poi uso tutte queste cose, perché di mio non è che ci metta molto, per imbastire anche quel che dico. Dipendo molto meno dai libri e molto di più dallo scambio vitale: nei sei anni di vista pastorale a Venezia abbiamo fatto in vari modi sicuramente più di duemila assemblee, in cui ci siamo ascoltati reciprocamente e da cui io ho imparato moltissimo. Non voglio adesso tediarvi riprendendo le parole che più mi hanno colpito.
La più imponente è una delle ultime, cioè l’apologia del rischio, perché la libertà non esiste senza rischio. Ai ragazzi porto sempre l’immagine di una delle mie esperienze di salita in Grigna, con donon Fabio Baroncini, che avendo le gambe più lunghe se la cavava meglio di me. Abbiamo fatto una volta la “via Segantini” e, arrivato ad un passaggio, io non riuscivo, avevo paura, perché era troppo lungo il salto da fare. E don Fabio mi diceva: Angelo, guarda che l’appiglio è qui, toccalo prima, allungati, non aver paura, è qui. E io non lo vedevo, lo concepivo con chiarezza, lo percepivo, ma non riuscivo: la volontà era come immobilizzata anche di fronte all’evidenza dell’appiglio. Questo è un carattere strutturale della libertà. E, secondo me, a questo si deve fare riferimento più che mai in questa situazione fluida, a cui tutti gli interventi hanno fatto riferimento secondo accenti plurali, molto significativi, di cui sono grato a ciascuno.
Quindi mi è venuto in mente, sentendo parlare di questa fluidità, uno degli incontri belli della mia vita, a Parigi, nel ’68. Perché anche se eravamo seminaristi la nostra Chiesa era molto aperta, quindi al mese di luglio del ’68 in cinque o sei seminaristi siamo andati a Parigi, e abbiamo cercato di capire cosa succedeva. E grazie all’inventiva di qualcuno abbiamo iniziato a suonare campanelli. Quello di Emmanuel Levinàs, di Jacques Derrida, di Louis Althusser, di Michel de Certeu. Non eravamo poi così chiusi, come si diceva. Non eravamo poi così integralisti, come si diceva. Ci interessava un paragone. E allora, incontrando il gesuita De Certeu, e sono molto contento che stia riprendendo peso oggi anche in Italia, già allora diceva che in questa società così fluida, «bisognava mettere lì qualcosa di solido». Detto nella complessità dell’oggi può sembrare banale, invece è soltanto elementare, è soltanto semplice, non è affatto banale.
Io credo che il rischio della libertà debba concretizzarsi nel coinvolgimento, nell’impegno di ciascuno e di tutti a porre appunto qualche cosa di duro e di solito.
Ancora, Parazzoli ha usato la parola senso, ma Giacomo l’ha tradotta con la sua splendida sensibilità, in mille immagini. Una vita senza senso si affloscia. Il senso è allo stesso tempo significato e direzione, non si può separare l’una cosa dall’altra. Non basta percepire un significato, occorre trovare la strada per camminarci dentro: e secondo me la parola insieme, usata verso la fine dal Rettore Magnifico, è la condizione di questa strada. Non abbiamo altra strada per porre qualcosa di solido su cui costruire, per camminare, che non sia l’insieme. La nostra società è plurale, vi albergano visioni opposte e talvolta contrastanti. Proprio per questo motivo dobbiamo identificare l’universale che ci accomuni. E, secondo me, non dobbiamo cercare questa comunione, questa comunicazione, tanto nell’ordine dei principi o delle idee, che pur ovviamente ogni soggetto porta con sé e che sono indispensabili, ma dobbiamo riconoscere umilmente che esiste un bene sociale, che è il fatto stesso che dobbiamo stare insieme, e non possiamo non stare insieme, e dobbiamo trasformare questo bene sociale in una scelta politica condivisa. Dobbiamo assumerlo consapevolmente.
Questo implica, e tocco taluni temi che voi avete sollevato di passaggio, un appassionato continuo confronto in vista di un riconoscimento reciproco. L’universale che può tenere insieme la nostra società è il bene pratico, sociale assunto come scelta politica di essere insieme. Essere insieme tra diversi comporta l’appassionato raccontarsi e il lasciarsi raccontare al di là di tutte le dialettiche, i conflitti, le incomprensioni, la pazienza, il tempo che ci vuole per capirsi, l’accettare l’umiliazione di essere fraintesi… È quest’opera comune che può rendere Milano un’oasi. Può rendere qualsiasi città, ma, secondo me, Milano in modo del tutto particolare, per la multiforme ricchezza delle sue variegate espressioni.
Mi è venuto spontaneo nell’omelia definirla “illuminata, operosa e ospitale”. E in quell’”illuminata” c’è dentro tutta la sua storia, che è storia sì di fede, ci mancherebbe altro, ma anche del famoso illuminismo lombardo e milanese, è storia di un movimento operaio che ha avuto il peso che ha avuto, che ha avuto la forza di un confronto con quello che fu il movimento cattolico.
Se è crisi di politica, è crisi del fatto che non abbiamo saputo trasporre l’esperienza di questa realtà, che era fondata su una categoria che spero ritorni alla vostra attenzione, era fondata sulla gratuità. Migliaia e migliaia di uomini, soprattutto perché allora purtroppo la donna non aveva il giusto peso, di uomini ma anche di donne, cattolici e legati alla grande esperienza variegata del socialismo, del comunismo e del movimento operaio, hanno portato fino alla metà degli anni Settanta la gestione delle nostre città e dei nostri mille paesi dentro una gratuità totale. Questi lavorano come tutti, si guadagnavo il pane lavorando e poi si giocavano, per la Chiesa, per il partito, per la società civile, gratuitamente. A un certo punto tutto questo è saltato. È saltato in nome della politica specialistica, in nome della competenza.
Adesso devo resistere alla tentazione di entrare in queste cose perché voglio lasciare la parola a voi, non senza aver detto un’ultima cosa su quello che sento essere il mio compito dentro la Chiesa di Milano, compito che come ho detto prima è un compito collegiale, un compito comunionale. Giacomo ha fatto riferimento a una delle realtà di sviluppo e di educazione più imponenti della nostra storia, che sono gli oratori. Centinaia di migliaia quest’estate sono passati dai Gres degli oratori, dai campi estivi, e lì c’è stato il grande passaggio di socialità e di libertà, sostenuto da preti, come ricordava sempre Giacomo.
Io ho una mia esperienza personale: ero un ragazzino delle medie, l’unico fortunato che aveva potuto grazie all’impegno socialista di mio padre andare a scuola, e il prete della mia parrocchia mi chiamava di tanto in tanto nel suo studio, e mi diceva «adesso ti leggo il pezzo di un libro: L’uomo senza qualità. Non posso darti tutto il libro, perché è proibito, però questo pezzo puoi capirlo anche tu». E me lo leggeva. Un’altra volta era Dostoevskij, o William Faulkner. E avevo 12, 13 anni. Un fenomeno educativo splendido. Cito l’oratorio per dire un’attitudine di una Chiesa che abbatte tutti i bastioni, che oggi si apre ad accogliere bambini, uomini e donne di ogni dove, i cittadini di domani, come è stato detto, non solo quelli di oggi, perché propone un senso. E questo senso è talmente imponente che non si può tacere.
Non so se Dio non ha più il piedistallo. Piuttosto Dio ha fatto una scelta strepitosa all’origine, mandando suo figlio ad assumere la nostra esperienza in tutto tranne che nel peccato, vivendo dall’interno come uno di noi per diventare esperto in quell’estrema esperienza dell’umano che è il patire, e poter così farci passare dalla cruna dell’ago della morte, come lui passò per primo, per spalancarci alla vita definitiva. Ma la cosa più strepitosa, la meraviglia della Grazia divina, la meraviglia dell’incarnazione, non è tanto che Dio ci ha salvato, ma come ci ha salvato. Ci ha salvato giocandosi lui davanti a noi e poi decidendo di aver bisogno di noi. Lui ha deciso di aver bisogno degli uomini, di tutti gli uomini. Perché la salvezza che lui procura è per tutti, di tutti gli uomini. Quindi il piedistallo siamo noi. E se siamo qui, c’è. Potrà essere un po’ malconcio, ma non è un grosso problema. Potrà aver paura dell’incontro col diverso, dimenticando che nella parola incontro c’è entro anche il “contro”: l’incontro non si può fare senza il contro, è un’astrazione, non esiste questo dato.
Era per dire che secondo la sua grandissima tradizione, la Chiesa di Milano è un luogo umano con tutti i difetti degli uomini di Chiesa, a cominciare dai miei, con tutti i peccati degli uomini di Chiesa, penso che siamo sufficientemente maturi per non farci illusioni, però vuol essere realmente un luogo di accoglienza. L’accoglienza implica l’andare con, e implica il gusto del confronto, del paragone, implica la curiositas, il domandarsi il perché davanti a tutte le cose, sempre, sempre. E io sono certo che la Chiesa di Milano è su questa strada, e per questo io sono stato preso a servizio della Chiesa di Milano, e con l’aiuto di tutti, sono molto utili anche le critiche: se sono garbate è meglio, se non sono piene di pregiudizi è meglio. Il pregiudizio è inevitabile, siamo uomini, io ti incontro e ho una re-azione. Che può essere una reazione di istintività o di opinione. Il dramma nasce quando tu elabori il pregiudizio invece che cercare di superarlo. Questo è il punto. La parola servizio può essere ancora ambigua, ma “essere presi a servizio” non è ambiguo, perché non dipende da te.
E io spero, con l’aiuto di tutti, di aiutare il cammino lunghissimo di questa Chiesa a servizio di ogni uomo e di ogni donna. Ogni uomo e ogni donna. Questo implica il coraggio di pro-porre, solo proporre, il nostro volto: dentro un paragone incessante che tende sempre al riconoscimento in vista di quello che io chiamo il compromesso nobile. Cum-promitto, promettiamo assieme. Questo mi sembra il senso del vivere in senso ecclesiale e con le debite distinzioni civile, e questo secondo me fa già di Milano un’oasi. Non lo dico per farmi coraggio: lo dico perché il bene che in Milano vive si impone.
Commento del cardinale agli interventi dalla platea.
Ringrazio tutti questi interventi perché hanno assecondato il desiderio di imparare Milano, di cui ho tanto bisogno, e quindi il mio desiderio è di ascolto. Perciò non sento il bisogno di aggiungere molte cose. Voglio però riprendere la bella provocazione sull’irrequietezza di Milano. L’oasi per sua natura è un crocevia, come Milano, la terra di mezzo, è il luogo permanente del passaggio per l’altro. C’è chi passa e va oltre, c’è chi si ferma e domanda spazio. Quindi non esiste opposizione, tra l’idea di oasi e quella di irrequietezza, si tratta solo di coniugarla bene. Ovviamente sarebbe semplicemente folle se noi pensassimo all’oasi come il luogo in cui tirarsi fuori dal reale. A parte che è impossibile, e poi il danno succede quando uno senza prenderne consapevolezza lo fa.
Invece, come dice l’etimo della parola della nostra città, Milano è allo scoperto: è per sua natura questa terra di mezzo allo scoperto. E quindi che sia crocevia è inevitabile. Crocevia vuol dire alterità, vuol dire l’altro, e la forma più acuta dell’altro è la differenza. Non la diversità, perché la diversità si può ancora comporre, ma la differenza è invalicabile. Il punto è distinguere la diversità dalla differenza, e come rendere ciò che è tipico e proprio della differenza una potente ricchezza.
Noi cristiani abbiamo una grande strada, si chiama trinità. Il pensiero della differenza è entrato in Occidente per pensare la trinità. Certo ci aveva pensato prima Aristotele, ma qui è arrivato così. E la trinità, come dice San Tommaso, è il luogo della massima differenza possibile: tutte le differenze che esistono stanno dentro questa differenza originaria, che esalta l’unità e non la spacca. Non abbiamo quindi nessun timore. E la parola inquietum è la grande parola agostiniana che dice il senso del cammino di ogni esistenza. Chi è l’uomo che non si porta dentro tutto questo? È un uomo infelice, è un uomo già morto prima, anzitempo. Queste sono reazione molto frammentarie, rozze e che non toccano il cuore dei tanti aspetti che sono emersi. Quello che si cercava questa sera era un dialogo profondo, e vi ringrazio, perché lo è stato, da parte di chi ha avuto la bontà di prepararsi per aiutarmi, e da parte di chi ha ascoltato, so che manca molto la capacità di lasciarsi fecondare dall’ascolto, ascoltare sul serio. Sono grato per questo dialogo, che come diceva Buber, in una delle sue importanti opere sul principio del dialogo, «è sempre uno scambio profondo con la realtà inafferrabile».
Se il parlare con l’altro non inoltra nel Mistero, il dialogo è un parlarsi addosso, è usare l’altro come specchio, prendendolo a pretesto per dire solo la propria. E io di questo tempo che avete avuto la bontà di dedicarmi vi sono veramente grato. E spero che questa iniziativa continui, secondo tutte le modalità espressive di cui oggi abbiamo abbondante ricchezza.

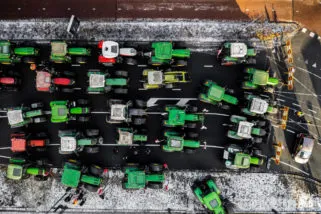

0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!