
Good Bye, Lenin!
Romeo e Giulietta nel lager. Storia di Heinz, nazista, e Inge, ebrea

La nostra storia comincia nell’estate del 1941, quando le truppe naziste raggiungono i paesi baltici «sostituendosi» al regime sovietico e vanificando le speranze di un ritorno all’indipendenza. In particolare, la Germania intende sfruttare le miniere estoni di scisto bituminoso (indispensabile per far fronte alla carenza di petrolio), e vuole trasformare il piccolo Stato baltico in area di sterminio per gli ebrei rastrellati da altri paesi. Dei circa 12.500 ebrei qui concentrati da altri paesi, oltre la metà moriranno, e verso la fine della guerra 4.600 verranno ricollocati altrove. Gli oltre 20 lager estoni sono più piccoli di quelli in territorio polacco, e dipendono dal campo principale di Vaivara, dove lavorano migliaia di detenuti raccolti dai ghetti baltici. Coloro che non sono in grado di svolgere lavori pesanti vengono trasferiti ai campi di sterminio o eliminati sul posto.
Nel settembre del 1942 in Estonia arriva il primo migliaio di ebrei dal campo cecoslovacco di Terezín, fra i quali c’è Ingeborg Sylten, una graziosa diciassettenne dai capelli castano-chiari. Proveniva da Brno, deportata con la madre e i due fratelli, mentre suo padre Robert – che cambiò il cognome ebreo Silberstein in Sylten per motivi ignoti – si è trasferito per lavoro in territorio sovietico (finirà nei lager staliniani, e nel dopoguerra avrà una vita avventurosa in Medio Oriente).
Inge e alcune sue compagne vengono assegnate per alcuni mesi al campo di Jägala, affidato a forze di polizia arruolate fra la popolazione locale. Si tratta di una situazione relativamente sopportabile: è permesso loro di indossare i propri abiti, il lavoro coatto è leggero, e grazie alla sorveglianza blanda possono persino allontanarsi a raccogliere bacche nei boschi o a chiedere cibo agli abitanti del luogo.
Successivamente le detenute sono inviate a Tallinn, dove svolgono lavori pesanti nei cantieri cittadini e al porto. Tuttavia la situazione continua ad essere ambigua: per evitare malcontento tra la popolazione estone, i nazisti permettono alle detenute di indossare i propri abiti sul posto di lavoro senza mostrare la stella gialla: ufficialmente sono semplici «operaie straniere». Possono avvicinare i civili che spesso le aiutano – alcune hanno anche il «fidanzato», qualche giovanotto del posto che porta pacchetti di viveri accompagnati da letterine d’amore. Scortate dalle guardie, possono recarsi anche dalla parrucchiera o frequentare i locali pubblici.
Una sopravvissuta ricorda come un tedesco, proprietario di una fabbrica, le ripeteva: «Se non lavori ti infiliamo in una cassa e ti trasformiamo in saponetta!». «E noi ridevamo – commenta lei – pensando che volesse spaventarci e che scherzasse… I marinai svedesi ci dicevano: “Venite via con noi, scappate”. Ma avevamo paura, e poi c’era il senso di responsabilità verso il gruppo: se scappo io, ci van di mezzo le altre».
Nell’autunno del ’43 Inge è assegnata al sottocampo di Ereda, che ospita circa 3000 detenuti. Ad attendere il contingente alla stazione c’è il comandante del campo, Heinz Drosihn, un giovanotto di bell’aspetto ma tutt’altro che tenero nei confronti degli ebrei. Alla vista di Inge, il sottufficiale nazista ha un colpo di fulmine: la invita a salire in auto e la accompagna all’infermeria del campo, dato che la ragazza appare molto provata. Drosihn le fa visita regolarmente, le dice che è preoccupato e teme che patisca il freddo e non possa alimentarsi a sufficienza, ma lei risponde che non può accettare né coperte né altro cibo se non vengono distribuiti anche alle altre detenute.
La loro conoscenza fortuita si trasforma pian piano in relazione pubblica e assume connotazioni particolari: la giovane si trasferisce di sua spontanea volontà nella residenza di Drosihn, ufficialmente gli fa da cuoca, benché la stessa mansione sia coperta dalla detenuta Gisela Danzigerová. «Secondo me – le dice Gisela – non è una buona idea andare a vivere da lui… Ma lei canticchiava, era molto giovane».
È evidente a tutti gli abitanti del campo che non si tratta di un capriccio del comandante: i due, provenienti da mondi così diversi e apparentemente inconciliabili, sono veramente innamorati l’uno dell’altra. Ormai è come se il campo, la guerra, per loro non esistessero più: Heinz si strappa persino i gradi, gira per il campo senza l’uniforme delle SS benché svolga ancora le solite mansioni, ma agisce in modo da non contrariare Inge. Le sopravvissute ricordano come un giorno lei si permette di strappargli di mano il frustino con cui sta per punire una detenuta, e da allora smette di usarlo.
Il loro rapporto affettivo supera preconcetti ed egoismi di parte, e suggerisce ad entrambi un nuovo modo di affrontare la vita che finisce per avere conseguenze positive per tutto il campo.
In inverno, un gruppo di detenute che stanno tornando da un cantiere lontano vengono colte da una tempesta di neve e alcune di loro, sfinite, non ce la fanno a rientrare; Inge, saputolo, insiste perché Heinz dia l’ordine di inviare una squadra di soccorso con slitte trainate da cavalli.
L’idillio va avanti per tre mesi, finché da Vaivara viene inviato un nuovo direttore temporaneo. All’arrivo dell’ispezione, nel febbraio 1944, Heinz non si trova al campo e da quel giorno sparisce. Trovano invece Inge nella residenza dell’amministrazione, viene interrogata e picchiata. Dopo tre giorni abbandona il campo fuggendo attraverso un cunicolo scavato dalle compagne di detenzione. Nessuno sa però la meta dei due fuggitivi. Secondo Gisela, la loro idea è quella di scappare in Svezia, paese neutrale, progetto che in inverno è difficilmente realizzabile: dovrebbero attraversare il Golfo di Finlandia ghiacciato, camminando decine di chilometri a piedi o con gli sci, oppure attendere la primavera e imbarcarsi clandestinamente su una nave.
Purtroppo la loro fuga finisce tragicamente. Non sappiamo in quali circostanze sono catturati, e nemmeno se vengono uccisi o se si suicidano. Sappiamo che le SS li seppelliscono in un punto imprecisato tra i boschi.
Scrive Grossman in Tutto scorre: «Gli uomini non volevano fare del male a nessuno, ma durante tutta la loro vita facevano del male. E tuttavia gli uomini erano uomini. E, meravigliosa, mirabile cosa: lo volessero o no, essi non lasciavano che la libertà morisse, e persino i più terribili di loro la conservavano con amore nelle loro terribili anime deturpate e tuttavia sempre umane».
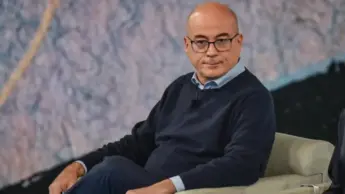


0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!