
Robert Spaemann non aveva paura della verità


Per gentile concessione di First Things, proponiamo di seguito in una nostra traduzione un articolo dello scrittore tedesco Martin Mosebach apparso lunedì 14 gennaio nel sito della rivista americana (qui l’originale in inglese).
Anche Tempi ha dedicato ampio spazio alla figura di Robert Spaemann, uno dei maggiori filosofi contemporanei, morto nel dicembre scorso: nel numero di gennaio del mensile è pubblicata una sua entusiasmante lezione sul rapporto tra libertà e verità, oltre a un ricordo di monsignor Luigi Negri, arcivescovo emerito di Ferrara.
* * *
Robert Spaemann, scomparso il 10 dicembre a 91 anni, è stato una voce essenziale tra quei filosofi contemporanei che ammettono che la ragione può conoscere la verità. Di più: che la ragione è proprio la capacità di conoscere la verità.
Nato nel 1927, Spaemann proveniva da un ambiente non convenzionale: fu l’artista Käthe Kollwitz a mettere insieme i suoi genitori, il giovane storico e poeta Heinrich Spaemann e la ballerina Ruth Krämer. Dopo aver letto Rousseau, i due si incuriosirono della religione e iniziarono un periodo di studio e riflessione che alla fine li condusse insieme nella Chiesa cattolica. Nel 1936 la madre di Spaemann morì di tubercolosi e in seguito suo padre fu ordinato al sacerdozio cattolico.
Spaemann crebbe in un’atmosfera che gli rese impossibile qualunque attrazione verso il nazionalsocialismo; fin da subito il mondo di Spaemann è stato un contro-mondo. Ancora oggi, in certe cerchie, la gente ammette malvolentieri il fatto che questo tipo di contro-corrente esistesse veramente in Germania, e che fosse legata alla Chiesa cattolica. Comunque Robert Spaemann ne è una prova. La sua vita integra e retta, in un secolo segnato dal tradimento, genera meraviglia e perfino invidia.
Il fatto che fosse un “outsider” negli anni del nazismo non significa però che si sentisse superiore a quanti non lo furono. Non lasciò mai che alcuna forza collettiva lo sollevasse dalla sua personale responsabilità morale. All’età di 17 anni voleva sapere che cosa era accaduto agli ebrei scomparsi nel nulla. Rifiutandosi di credere alle storie secondo le quali erano stati semplicemente mandati in campi di lavoro, interrogava i soldati di rientro dal fronte orientale finché non conobbe l’orribile verità.
Aspirare alla verità non implica soltanto dire addio al richiamo della menzogna. Proibisce anche un “atteggiamento ironico verso il mondo”, come lo definirebbe Richard Rorty, “mettere il ‘mondo’ tra virgolette”. Nell’abuso di espressioni come “per così dire” in bocca a tante cosiddette persone educate, Spaemann vedeva una forma volgarizzata del rigetto della realtà da parte del filosofo moderno. Per lui “realtà virtuale” e “simulazione” – concetti chiave del pensiero contemporaneo – erano sintetizzati nell’aforisma del poeta Charles Péguy: il modernismo «non crede in ciò in cui crede». Il giovane Spaemann non sopportava l’idea di accettare il mondo dell'”apparenza” come obiettivo finale. Il suo scopo era penetrare il velo dell’apparenza e raggiungere il muro oggettivo del reale – anche se alla fine non avesse potuto arrampicarvisi.
Si rifiutava di seguire il consiglio di Wittgenstein di “gettare la scala con cui si è raggiunta la conoscenza”. Credeva che ognuno dei pioli della scala meritasse uno studio dettagliato, perché nessun passo è completamente incorporato nei passi che lo seguono. «La filosofia è caratterizzata da un movimento che è sia un avanzare che un indietreggiare», ha scritto. «Il progresso filosofico non ha luogo allo stesso modo del progresso delle scienze empiriche, per incrementi lineari». Non guardando al passato come a qualcosa di definitivamente depositato ma come a qualcosa di innestato nel presente e nel futuro, con sfide ancora da scoprire, la filosofia ricerca un modo di vivere intensamente. Ogni persona e ogni idea che Spaemann incontrava rafforzavano in lui la sensazione di essere vivo.
La scrittura di Spaemann era di una chiarezza incredibile: egli non invocava mai il diritto all’oscurità reclamato da tanti pensatori (specialmente tedeschi). Non ritenne nemmeno necessario inventare il suo personale gergo o dialetto filosofico. Sotto questo aspetto, seguiva Cartesio, verso il quale su altri temi era assai critico. Vedeva la “Caduta” del pensiero europeo moderno come la rottura rispetto a una mentalità che aveva contraddistinto la filosofia europea per duemila anni, e cioè quella secondo la quale la pienezza dell’essere andava intesa nei termini di un grande adempimento [performance, ndt] da accettare (in una visione antropomorfica) come qualcosa di familiare eppure unico, non da sfruttare in funzione della sua utilità. Nel tentativo di raggiungere un’autentica revisione, di mutare il corso del pensiero dopo trecento anni in cui il dominio sulla natura è diventato il pericolo della distruzione della natura, Spaemann non puntava appena a tornare a Tommaso d’Aquino, con cui la filosofia antica aveva trovato un radioso compimento. Piuttosto tentò di spalancare la prigione del nichilismo e del relativismo moderni con le categorie di Kant, Hegel, Karl Marx e Nietzsche. Era nella natura di Spaemann il fatto di non apprezzare il sapere della filosofia “come privilegio” (san Paolo), ma di lasciarle dimostrare il proprio valore nella vita concreta. Traeva conseguenze morali e politiche dalla sua comprensione della verità. Per lui la filosofia senza conseguenze rappresentava un’impresa insensata.
Spaemann era sposato con Cordelia Steiner, figlia del pittore Heinrich Steiner (allievo di Hans von Marées) e di una madre ebrea. Questo naturalmente significa che Cordelia durante il periodo nazista era in pericolo, e la storia della sua conversione alla Chiesa cattolica è strettamente legata alla sua messa in salvo. Era una letterata, una poetessa e traduttrice del poema ermetico di David Jones Anathemata. Dopo la sua morte, Spaemann ebbe a dire che per tutto il loro matrimonio aveva guardato il mondo con quattro occhi. Cordelia lo sostenne nella sua battaglia durata decenni in difesa della liturgia cattolica tradizionale, soppressa dopo il Concilio Vaticano II. Quella battaglia non era appena questione di una disputa infinita tra filosofi: era in gioco un’esperienza che precede il pensiero e insieme costituisce il suo coronamento. Per Spaemann, è solamente nel rito – che attraversa tutto il tempo – che una persona sperimenta l’unità della famiglia umana.
A tre anni, seduto in grembo a sua madre, ascoltava coscientemente i canti gregoriani dei monaci benedettini e protestava quando i suoi genitori provavano a portarlo fuori dalla chiesa. E da vecchio annuiva con un sorriso di approvazione all’aforisma di Confucio: «L’uomo superiore che ha studiato a fondo i libri dei saggi e sottomette il suo sapere ai riti tramandati, non può smarrirsi». La verità – liberata dal potere del pensiero – si manifesta e conferma la sua cogenza attraverso i sensi. Era questo il sottofondo mentale di Robert Spaemann, filosofo appassionato.
Foto da Demo für Alle (Wikimedia)
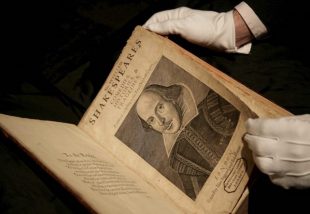


0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!