
Repubblica, l’unico quotidiano con liturgia della parola incorporata
«Cazzo, coglioni e vaffa», scrive il fondatore Eugenio Scalfari nel tentativo di parodiare il linguaggio di Beppe Grillo, o forse di riprodurlo, nel consueto editoriale/sermone sulla prima pagina de la Repubblica di domenica 4 novembre. Sottoposti a un’attenta lettura del testo, gli adepti del quotidiano cult si saranno distinti in tre categorie: quelli che sono rimasti scioccati alle parole inconsulte del Fondatore, un po’ come se le avesse pronunziate dal pulpito un prete con la sindrome di Tourette; quelli che sono rimasti scioccati a scoprire che per un qualche motivo l’editoriale fosse lungo la metà del solito; quelli che hanno continuato ad annuire con aria grave senza avvedersi del turpiloquio. La lettura di Repubblica è infatti un atto sempre più simile alla distratta presenza fra i banchi di una chiesa: lo si fa un po’ perché ci si crede confusamente, un po’ perché non si ascolta, un po’ per tacitare la coscienza, un po’ perché bisogna farsi vedere.
GIORNALE LITURGICO. Repubblica, intendiamoci, è il quotidiano più bello d’Italia: i colori sono raffinati, l’impaginazione delle sezioni culturali è alto design, le vignette di Altan e Bucchi rasentano l’arte, le foto bucano la pagina, la carta è quasi serica, il formato consente di piegare il quotidiano nella sacca della giacca di velluto o nello zainetto finto-povero lasciando sempre in bella evidenza la testata. Sembra fatto apposta per non essere letto. I suoi articoli vanno dunque considerati per quello che sono, ossia un riempitivo all’interno di un progetto editoriale più vasto in cui l’aura conta più dei temi, la testata più dei titoli e la firma più del contenuto. Hanno la stessa portata delle omelie domenicali, che possono anche riuscire bene ma non decidono del valore di ciò che le contiene – e, se si dovesse giudicare il cattolicesimo dalle prediche, staremmo freschi. Repubblica è un giornale liturgico che vive di riti cristallizzati e di gesti calibrati (come la stretta di mano di Ezio Mauro ai redattori più importanti all’inizio delle riunioni); l’editoriale domenicale del Fondatore ne costituisce il vertice ciclico, la nota dominante che tutto racchiude in sé, il rassicurante coperchio che garantisce dell’acquisto a scatola chiusa di tutto il calderone.
NON SI LEGGE, MA SE SUCCEDE… Per questo svegliarsi in una pigra e grigia domenica mattina e trovare scritto “cazzo, coglioni e vaffa” in prima pagina è scioccante: non per le parolacce in sé, peraltro nascoste fra parentesi, ma perché esse danno uno scossone al lettore distratto e assuefatto; lo spingono a sfregiare il velo di Maya iniziando a leggere Repubblica come se fosse un giornale vero, ossia per quello che c’è scritto, per trarne contenuti senza forma. Le sorprese non mancano. Ad esempio, a pagina 3 Michael R. Bloomberg (sindaco di New York, la città dove cancellano le maratone senza rimborsare le iscrizioni) s’imbarca in arditi sillogismi per spiegare che, nonostante che non ci sia motivo di credere che Sandy sia dipesa dal riscaldamento globale, è necessario appoggiare Obama in ragione del suo pluriennale impegno contro il riscaldamento globale, a seguito del quale impegno è infatti arrivata Sandy. Su qualsiasi quotidiano un ragionamento così cristallino sarebbe stato esposto alle pernacchie del lettore neutrale, ma non su Repubblica dov’è corazzato dall’equilibrata scelta di farlo iniziare in prima pagina sotto una foto trionfale di Obama (vestito con la stessa camicia di Gianni Riotta) e di fianco a un pezzo di Joseph E. Stiglitz in cui si asserisce che è necessario che gli americani votino Obama perché «il numero dei non americani favorevole alla sua rielezione è schiacciante rispetto a chi vorrebbe che a vincere fosse il suo sfidante».
ASTENERSI PROVINCIALI. D’altra parte, chi si sognerebbe di criticare Bloomberg e Stiglitz una volta che venissero citati, con grande autorità e competenza, dai lettori più attenti nel corso del pranzo domenicale? Non ci riferiamo alle loro opinioni ma ai loro nomi. Repubblica offre loro validi sostituti anagrafici; le stesse idee, sostenute da Gian Luigi Scabbia o da Giacomo Frangiflutti (pesco nomi a caso dalle firme delle lettere al quotidiano), suonerebbero se non meno credibili di sicuro più criticabili. Basta invece che si chieda: «Avete letto Bloomberg e Stiglitz?», e tutti automaticamente danno loro ragione al solo scopo di non fare la figura dei provinciali. Mica per niente Michele Serra, in apertura de “L’amaca” dello stesso giorno, spara: «Non potrei essere provinciale neanche se lo volessi: non sarei credibile». Lettori e autori di Repubblica tutto possono essere meno che provinciali e infatti venerdì 2 alle province in bilico, quelle in cui l’accorpamento potrebbe comportare la guerra civile, viene dedicata un’intera pagina tutta rivolta all’allisciamento dell’immaginario del target di Repubblica: il pisano Marco Malvaldi preferisce contaminarsi coi livornesi piuttosto che «pagare auto blu a Fiorito» (che non è né pisano né livornese), il tarantino Giancarlo De Cataldo plaude alla fusione con Brindisi così da poter «lottare insieme per lavoro e ambiente» (perché evidentemente separati non ne vale la pena), Luca Bottura rivendica che «la diversità è la nostra ricchezza» (ma a ben guardare sta parlando delle ricette dei tortellini), l’erudito Umberto Eco non batte ciglio di fronte al miscuglio tra Alessandria e Asti «tanto io parlo entrambi i dialetti» (e quindi io, che parlo inglese e francese, posso dirmi favorevole all’accorpamento dell’Italia a Inghilterra e Francia). Massimo Carlotto si oppone invece alla fusione di Padova intellettuale e filo-operaia con «la Treviso della Lega»: è noto infatti che la miglior maniera per insegnare ai leghisti i benefici dell’integrazione multiculturale è isolarli in un angolino con Giancarlo Gentilini.
SINDROME AUGIAS. I lettori di Repubblica sono così lontani da ogni provincialismo che sembrano essere i maggiori beneficiari del taglio delle province imposto dal governo, a eccezione degli alunni delle terze elementari che dovranno impararne a memoria molte di meno. Chissà se questo non contrari Corrado Augias, che sabato 3 tuona dalla sua tribuna contro «quei genitori che assistono passivi al precoce corrompimento intellettuale dei loro figli» in risposta a una signora che sta valutando se iscrivere la sua frugoletta alla Deutsche Schule perché in quella italiana mancano le lavagne multimediali e ci sono suore che parlano male dell’aborto. Augias d’altronde gestisce le pr di Repubblica con i lettori e far finire una propria lettera nel suo box grigio equivale a un cavalierato, talché si crea una sorta di sindrome di Stoccolma per la quale i lettori cercano di assecondare Augias e Augias cerca di assecondare i lettori. Memorabile la lettera di martedì 30 ottobre, in cui un tale Paolo Lupo e Augias conversano amabilmente di Berlusconi senza nominarlo, come due amici sorpresi sul treno a chiacchierare di un terzo: lo evocano come colui che «ha rubato il sogno di una generazione onesta», colui che «ha cambiato la percezione del denaro», «uomo furente e spaventato», «attore consumato». Quando si tratta di Berlusconi, l’intesa fra lettori e autori di Repubblica diventa telepatia. Lunedì 29, a seguito dell’intemerata di Villa Gernetto, il quotidiano più intelligente d’Italia ha avuto il talento di assecondare tutte le diversificate reazioni di tutte le possibili tipologie di suoi lettori offrendo loro una rosa dei venti di opinioni complementari. Piero Ottone («Credevo che non mi sarei mai più occupato di lui») ha blandito coloro che pensano che Berlusconi meriti la camicia di forza con un’analisi psicologica della sua mania di protagonismo e del suo senso di persecuzione. Ilvo Diamanti ha consolato quelli che ascrivono a Berlusconi tutti i mali della società raccontando che «le sue invettive risuonano come grida nel vuoto» nonostante che «il sistema politico e il modello di partito imposti da Berlusconi ruotino intorno alla sua persona e alla sua comunicazione».
IL CERCHIO SI CHIUDE SEMPRE. Filippo Ceccarelli ha solleticato i fautori del Cavaliere da operetta, quello che fa fare brutta figura in società, analizzando «il terribile mascherone» di «un pupazzo arancione che si ostina a mettere in scena la propria consumazione», ormai vittima della vendetta del tempo. Infine Eugenio Scalfari, tanto per chiudere il cerchio, esaltava i caimanisti con un ponderato editoriale intitolato “Una follia eversiva destabilizza il paese”. È dunque chiaro che i collaboratori di Repubblica scrivono ciò che i lettori vogliono leggere e i lettori comprano Repubblica perché ci trovano ciò che vogliono sentirsi dire; operazione commercialmente impeccabile ma che rende superfluo l’esercizio della scrittura. Il club di Repubblica è un circolo che ha sostituito al proselitismo la conservazione degli iscritti per mezzo della radicalizzazione delle convinzioni tramite la ripetizione a oltranza di concetti già assodati. Se la lettura dei quotidiani è la preghiera del mattino, Repubblica s’è fatta, né più né meno, pura e sacrosanta liturgia; come scriveva Scalfari stesso giovedì 25 ottobre, «la liturgia ha rappresentato per molti secoli la custodia ben sigillata della ritualità tradizionale». Solo che nella circostanza non stava parlando del suo quotidiano ma della nostra religione, in un lungo articolo a margine del sinodo in cui spiegava a Benedetto XVI come far finalmente funzionare il cattolicesimo. La portata liturgica del quotidiano più incontestabile d’Italia e del suo Fondatore spiega il senso di un articolo del genere. Repubblica non ha nulla contro la Chiesa, Scalfari non ha nulla contro il Papa. È solo che non sopportano la concorrenza sleale.
Articoli correlati
9 commenti
I commenti sono chiusi.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!
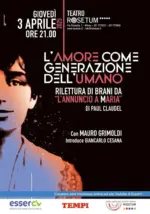
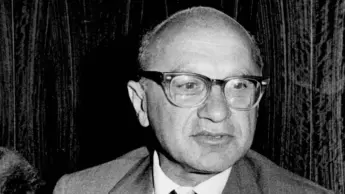

Quando leggerò su Tempi un articolo che criticherà il celeste imperatore all’ora riterrò tempi degno di criticare la Repubblica.
Su che cosa criticarlo?
Avere uno stile di vita che niente ha a che fare con il voto di povertà tanto sbandierato.
Quando dice che il grattacielo che si è eretto costa meno degli affitti senza dire quanto ci ha messo in conto capitale.
Quando si vanta della sanità lombarda “dimenticandosi” di dire da dove era partito e di tutti gli scandali che ci sono stati, non ultimo, l’ospedale di Bergamo dove, tra l’altro, ci sono tanti piccoli artigiani non pagati.
E come dimenticare le “veline” che riguardano l’assessore Cattaneo con tutte le grandi infrastrutture da lui realizzate lavorando 15 ore al giorno per il “misero” stipendio di assessore.
Tanti anni fà fu detto “non guardare la pagliuzza………..” , ma i redattori di Tempi non sono tutti cattolici praticanti? In catechismo voto 2 meno meno. Studiare di più e comprendere quello che legge.
Eh sì, Luigi, hai proprio ragione. Quelli di Tempi dovrebbero proprio imparare a non guardare la pagliuzza nell’occhio altrui. Dovrebbero imparare da quelli di Repubblica, questi bravi ragazzi, esempi di umiltà e autocritica, così lontani da ogni ideologia, così tormentati dalla trave nel loro occhio. Eh sì sì. Eh già già.
Ho forse detto che quelli di Repubblica sono dei santi? Ho voluto dimostrare che a Tempi sono come quelli di Repubblica. Non la pensi come me? argomenta su quello che dico o dai una tua opinione.
Anche per te voto 0 in comprensione della lettura.
Tempi = la Repubblica, come faziosità, arroganza, disonestà intellettuale ?
NO, IO NON CI STO !!!
“Ho forse detto che quelli di Repubblica sono dei santi?”
R: No
“Ho voluto dimostrare che a Tempi sono come quelli di Repubblica.”
R: Ammesso, e non concesso, che nel caso specifico (il “celeste imperatore”) tu abbia ragione, un singolo caso non è un campione statisticamente significativo per la tua dimostrazione.
“Non la pensi come me? argomenta su quello che dico o dai una tua opinione.”
R: Già fatto.
“Anche per te voto 0 in comprensione della lettura”
“In catechismo voto 2 meno meno. Studiare di più e comprendere quello che legge.” (dal commento precedente)
R: ah sì, le famose pagluzze rigorosamente negli occhi altrui. Ho comprato una copia del tuo libro “Lezioni di umilà e di sana autocritica”: me lo autografi? 😉
In merito alla tua risposta “R: Ammesso, e non concesso, che nel caso specifico (il “celeste imperatore”) tu abbia ragione, un singolo caso non è un campione statisticamente significativo per la tua dimostrazione”
Faccio presente che oltre l’imperatore citavo anche un’assessore, quindi i casi, statisticamente parlando, aumentano.
Ti cito altri casi:
. Nessun articolo pro Obama, che non mi sembra un presidente indifferente ai più poveri del suo paese
. Nessun articolo per la donna irlandese morta di setticemia a causa di medici che si sono rifiutati di praticargli l’aborto, almeno raccontare la notizia e lasciare che ogni persona tragga le sue conclusioni.
. Gli articoli di Giovanardi dove minimizza la corruzione in Italia, guarda te se è il caso di minimizzare.
. Non ricordo articoli sul nuovo ospedale di Bergamo costruito su terreno paludoso e con fornitori non pagati.
Mi fermo qui a te il compito di vedere come vanno le statistiche.
Ti ricordo che il libro “Lezioni di umilà e di sana autocritica” ti vede come coautore e quindi un mio autografo vale solo se c’è anche il tuo.
Faccio autocritica: non so mettere le faccine.
Lascio a te il compito di completare la statistica, in modo che tu possa dimostrare – com’era tua intenzione – che “a Tempi sono come quelli di Repubblica” e quindi che Tempi non e’ “degno di criticare la Repubblica”.
Mi sorge un dubbio leggendo gli esempi che fai.
Mi sembra di capire che Obama tutto sommato ti piace. E’ legittimo, ci mancherebbe. A me piace un po’ meno perche’ la filantropica attenzione ai poveri che s’accompagna al finanziamento (e quindi alla promozione) dell’uccisione dei piu’ poveri fra i poveri – i bambini non nati – mi sembra avere un non so che di luciferino (e non riguarda solo Obama). Promozione dell’aborto che non ha nulla a che vedere con il caso della donna irlandese (caso che non so quale sviluppo abbia avuto nell’appurare l’eventuale negligenza dei medici), poiche’ casi come questo (e altri, magari inventati, vedi il “caso Seveso”) fungono semplicemente da grimaldello per creare consensi, sulla scia delle emozioni generate da singoli casi particolari, all’aborto tout-court: avrai sentito parlare degli aiuti ONU ai paesi poveri subordinati alla liberalizzazione dell’aborto, della promozione dell’aborto selettivo da parte dal UNFPA (leggi: eugenetica), eccetera. Mi sembra che questi finanziamenti troverebbero miglior destinazione se fossero impiegati per l’aiuto ai poveri gia’ nati o in procinto di nascere (poveri che “gli” Obama, evidentemente, ritengono non avessero/non abbiano il diritto di nascere) e alle loro famiglie. Tutto questo senza voler minimizzare la corruzione. Ma, davvero, come posso sorprendermi (in Italia e altrove) della corruzione, dell’egoismo, dell’attaccamento al denaro in un paese (l’Italia e non solo) dove il diritto di uccidere un bambino non ancora nato e’ considerato segno di civilta’? Dove, per non usare la parola scomoda “omicidio”, ci si inventa che il non-nato non e’ persona e quindi abortire non e’ poi cosi’ diverso dal togliersi un callo (e si legittima, cosi’, la valutazione di una persona in termini di efficienza/requisiti minimi anziche’ riconoscere alla persona un valore che non dipende dal come/dove/quando quella persona si viene a trovare)? Dove la cosmesi linguistica introduce termini come “aborto tardivo” per fare strada all’infanticidio? Dove l’eutanasia, se ancora non e’ legale, avanza subdola, strisciando, tutta ammantata da toni filantropici per cui si arriva all’assurdo che chi uccide un malato e’ il buono e giusto perche’ lo fa per il suo bene (leggi “Eluana. I fatti” di Bellaspiga/Ciociola e confronta i fatti con gli articoli di Repubblica…)?
Se e’ lecito disfarmi dell’inerme, perche’ dovrei farmi scrupoli a danneggiare chi, se non altro, puo’ tentare di difendersi?
Su temi come questo – e come quello della famiglia e delle “unioni omosessuali” e loro fondamento ideologico (confronta gli articoli su “Egalia” di Tempi e di Repubblica…), i “valori non negoziabili” insomma, che non sono certamente gli unici ma che, accettati come fondamento oppure rifiutati, fanno la differenza nella visione antropologica della persona e nelle conseguenti scelte politiche e sociali – ebbene su questi temi avrai notato l’approccio nettamente differente delle due testate che metti sullo stesso piano: Tempi li sostiene, Repubblica li tratta, con un certo fastidio, come carta igienica di bassa qualita’.
Gli esempi che hai fatto mi hanno dato l’impressione (faccio ammenda se l’impressione e’ sbagliata) che certa tua ostilita’ a Tempi muova i passi da una opposta visione, diciamo cosi’, su queste tematiche. Ecco, non difendo gli atti di chi ruba o predica bene e razzola male, ci mancherebbe. Ma nemmeno mi scandalizzo di chi cade dopo aver intrapreso un cammino cercando di farlo in piedi e non strisciando. Disprezzo, questo si’, l’apologia dello strisciare e l’apologia di certi disvalori che Repubblica fa, al contrario di Tempi. Che certamente non e’ il Vangelo ed e’ fatto di peccatori recidivi come me e, credo, te.
Ciao
Vediamo se ho capito bene.
Se una persona non la pensa come Tempi sui “valori non negoziabili” all’ora è giusto criticarlo qualsiasi cosa dica o faccia anche su cose che niente hanno a che questi valori e, di contro, chi dice di accettarli questi valori può dire e fare ciò che vuole.
Quindi anche per Tempi vale il titolo di questo articolo e valida il mio primo commento.
Penso che se non ho capito al 100% il tuo ragionamento l’avrò capito almeno al 90 e all’ora mi permetto di darti un consiglio che è quello di valutare bene chi dice, su questi temi, le stesse cose che dici tu. Non parlo di persone comuni, che senz’altro difendono le loro idee e fanno bene, ma di chi facendo leva su questi sentimenti persegue altri scopi
Non ho scritto che se uno dice “W i valori non negoziabili!” allora puo’ permettersi di fare quel che vuole, anche perché il rispetto della persona “dal concepimento alla morte naturale” include tutto l’arco di vita che sta fra questi due estremi. Continuo a pensare che promuovere l’uccisione di un bambino non ancora nato sia peggio di dare/ricevere una tangente (con questo, _non_ dico che la tangente è cosa buona e _non_ dico che vada promosso lo scambio di tangenti) e, assieme ad altro, crea quel clima culturale che favorisce la mentalità autoreferenziante del “penso per me, e di te me ne frego, ché tanto a mio avviso vali meno di me”.
Il consiglio che mi dai è sacrosanto e su questo non posso che essere d’accordo con te.