
Tremende bazzecole
Quel “benefattore seriale” che c’è in ognuno di noi
 «Né creator né creatura mai/ – cominciò el – figliuol, fu sanza amore» (Purgatorio, canto XVII)
«Né creator né creatura mai/ – cominciò el – figliuol, fu sanza amore» (Purgatorio, canto XVII)
Matteo Renzi ha promesso che a maggio 10 milioni di lavoratori dipendenti vedranno 80 euro in più in busta paga. Ha detto che ci mette la faccia e se non succede gli si può dare del buffone; molti lo aspettano al varco, dubitano che ci siano le coperture, e dicono: vedremo. Senz’altro si tratta di un gesto platealmente chiaro e metaforicamente efficace.
In fin dei conti, si chiama dono. Possono esserci scopi, visioni e interessi sinceri o maliziosi, ma l’immagine del dono è dirompente: lo faceva Robin Hood, ed è ricordato come eroe; lo facevano gli imperatori romani col panem et circenses, e lo si classifica come demagogia. Poi, tradizionalmente, lo fa ogni anno Babbo Natale e a tutti – ammettiamolo – piace che ci sia un periodo in cui «siamo tutti più buoni».
La cronaca testimonia che quest’istinto amabile non c’è solo a Natale; ultimamente a Busto Arsizio è tornato in azione il benefattore seriale: un’anonima buon’anima che nottetempo mette nelle cassette postali di certe Onlus assegni di migliaia di euro. Aiuta associazioni che si occupano di disabili, minori e malati e nell’ultimo caso ha corredato il dono con un bigliettino scritto a macchina: «Grazie per quello che siete e per tutto quello che fate». E immancabilmente noi commentiamo questi gesti buoni e belli con un fondo di amarezza: magari capitasse anche a me, e poi chissà cosa c’è dietro, e chi pensa alle famiglie che non arrivano a fine mese? Se poi è la politica a usare la chiave della generosità, i sospetti, le critiche, i pregiudizi lievitano a dismisura.
Ma c’è innanzitutto da constatare che la chiave funziona perché è quella giusta per la serratura della nostra porta. Un gesto di bene gratuito è per noi una calamita; e l’idea del donare è attraente ancor più di quella del ricevere un regalo. È una radice umana inestirpabile e, come tale, nutre una pianta rigogliosa, le cui fronde possono poi diramarsi in direzioni molto varie – positive e negative. La radice, però, è una sola e la sintetizzerei dicendo che è stato bravo chi ha coniato l’espressione «benefattore seriale». Implica che qualcuno sia recidivo nel bene. Ed è così che siamo. Tralasciando i molti modi in cui siamo capaci di assecondare e tradire il bene (solidarietà, bieco interesse, slancio momentaneo), in fondo noi siamo garantisti quanto al buono.
E ce ne rendiamo conto quando facciamo un dono. È una cosa da veri adulti, perché il bambino è giustamente goloso di ricevere. Ma l’adulto sa come sta quando pratica la gratuità, ed è una misura che non si racconta a parole. Ha a che fare con lo spalancarsi di una finestra: le braccia si aprono ed entra aria fresca nei polmoni.
Il centro esatto della Divina Commedia è il canto XVI del Purgatorio ed è dedicato al tema della libertà; l’argomento deborda nei canti successivi, perché a Dante sta molto a cuore dimostrare che la libertà umana non inizia da un dato neutro: l’anima non è una bilancia equidistante dal bene e dal male, è pesantemente «tarata» sul bene. Nei cosiddetti secoli bui, Dante propagò l’eco di ciò che già la luminosa voce di san Tommaso aveva gridato: «Ogni essere agente, qualunque esso sia, compie ogni sua azione in forza di un qualche amore».
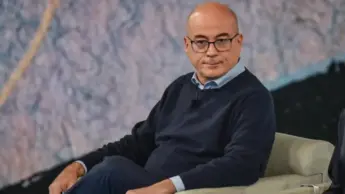


0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!