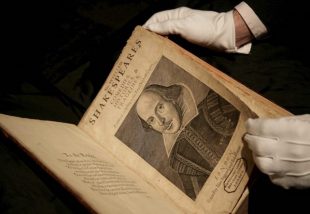
Politiche educative tra descolarizzazione e riscolarizzazione

L’educazione, nel contesto attuale, assume una posizione centrale nella società, ne consegue che il servizio offerto alle nuove generazioni deve consistere in una formazione solida. Questa non va intesa naturalmente in un senso riduttivo come semplice istruzione o addestramento, ma deve fornire a ognuno la capacità di vivere al meglio in un società complessa. Si tratta di aiutare i giovani ad acquisire una preparazione valoriale, culturale e professionale elevate che consenta loro di inserirsi da protagonisti in un mondo sempre più articolato e privo di punti di riferimento forti, capaci di dare alle opzioni degli individui un orizzonte di senso e di significato, e di offrire una guida alla discrezionalità dell’agire umano e una prospettiva di futuro nel mondo del lavoro e delle professioni. Questa finalità, tuttavia, si scontra con l’incapacità dei sistemi scolastici di garantire effettivamente a tutti almeno una formazione di base e una prima qualifica professionale. Si tratta di una carenza che assume valenze drammatiche nei Paesi in via di sviluppo, ma che tuttavia è seria anche nei Paesi industrializzati.
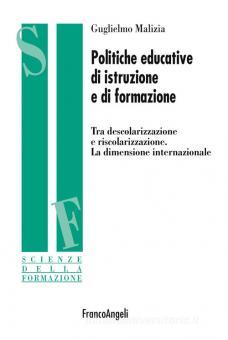
In questo quadro viene a realizzarsi la riflessione di Guglielmo Malizia – professore emerito di Sociologia dell’Educazione e direttore dell’Istituto di Sociologia dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana, nonché direttore del Centro Studi per la Scuola Cattolica della Cei – con una analisi della situazione e delle numerose problematiche riscontrabili nei sistemi educativi all’inizio del terzo millennio. L’obiettivo non va individuato nell’introdurre qualche cambiamento, quanto piuttosto nel puntare ad una riforma generale, in argine ad alcune proposte che puntano ad una vera e propria descolarizzazione.
Il volume, dal titolo Politiche educative di istruzione e di formazione – Tra descolarizzazione e riscolarizzazione. La dimensione internazionale (FrancoAngeli editore) – si esprime chiaramente per una riscolarizzazione, il cui punto di partenza è una nuova concezione dell’educazione, ispirata alla Dichiarazione di Incheon dell’Unesco del 2015 che così la descrive: “assicurare una educazione di qualità, equa e inclusive, e promuovere opportunità di apprendimento per tutti lungo l’intero arco della vita”.
Gli argomenti affrontati dalla pubblicazione comprendono anzitutto la presentazione del quadro generale delle politiche educative a livello internazionale, a cui seguono quattro capitoli illustrativi delle strategie secondo i vari gradi e ordini di scuola e di formazione professionale; l’educazione di base; la scuola secondaria e l’istruzione e formazione tecnico-professionale; l’istruzione superiore; l’educazione degli adulti.
Completano l’ampia disamina due tematiche di carattere trasversale: il ruolo e la formazione degli insegnanti, e la governance della scuola e della formazione professionale tra autonomia e libertà.
Per quanto concerne la figura dell’insegnante, la concezione tradizionale secondo cui l’insegnante detiene il monopolio delle conoscenze, le trasmette a chi non le ha e cessa dalla sua funzione quando l’allievo ha appreso tutto ciò che sa l’insegnante, è concezione superata. Tale concezione presuppone che le conoscenze abbiano una natura fissa, finita e quantitativamente misurabile, ma non è più così. La società è cambiata, l’espansione enorme delle conoscenze evidenzia che nessuno può vantare il monopolio dei saperi in un determinate settore di studio. In contrapposizione si é accentuate l’esplosione delle aspettative di eguaglianza che rende sempre meno accettabile l’esistenza di una gerarchia rigida di status tra le diverse categorie di insegnanti. Da qui viene avvalorata la funzione dell’insegnante di dare risposte ai bisogni degli studenti, e ciò richiede all’insegnante una maggiore e più profonda formazione iniziale, e, con l’adempimento del compito di accompagnare l’alunno nel suo procedure verso la realizzazione di sè, una disponibilità ad una formazione personale continua.
Per quanto concerne la governance della scuola, nel testo viene evidenziato che è necessario assicurare ad ogni scuola potere di iniziativa e risorse sufficienti per elaborare e realizzare un suo progetto e costituirsi una propria identità. E alle famiglie assicurata la libertà di scelta dell’ambiente a cui affidare la formazione dei propri figli. Ciò consiste nel garantire ad ogni scuola potere di iniziativa e risorse sufficienti per realizzare quel suo progetto, insieme elaborato con le componenti della comunità educante. Pertanto il cuore della autonomia – sottolinea l’autore – è costituito dal riconoscimentio della competenza progettuale: ogni scuola deve essere messa in grado di elaborare il proprio progetto educativo in cui si rispecchi la sua identità e la sua fisionimia. A questo proposito vanno attribuiti ad ogni unità scolastca poteri adeguati di autonomia didattica, formativa, organizzativa e finanziaria. Certamente tutto ciò non va confuso con una privatizzazione selvaggia,, nemmeno si può pensare ad una abolizione della struttura centralizzata dello Stato. Essa deve invece assicurare l’esercizio delle responsabilità educative, in un quadro unitario garantito dal centro a cui spetterà l’impulso, il coordinamento, la definizione di indicazioni generali e il controllo.
Attualmente l’autonomia si presenta come una tendenza solida in quanto su di essa converono le politiche scolastiche e formative di tutti I Paesi, per cui non la si può considerare come “una molla passeggera o l’ennesima infatuazione pedagogica” (Vittadini, 2015).
Una dimensione basilare della nuova concezione dell’educazione – così come evidenziato da Guglielmo Malizia – va ricercata nella sua visione umanistica non solo dell’educazione stessa, ma anche del suo sviluppo. Una chiaratestimonianza in questo senso viene dai valori di riferimento: “I diritti dell’uomo e la dignità umana; la giustizia sociale; l’inclusione e la tutela; la diversità culturake, linguistica ed etnica; una responsabilità e un obbligo a rendere conto condivisi” (Unesco, 2015). La nuova concezione vuole essere una garanzia.
La pubblicazione pone in risalto molti problemi ed evidenzia soluzioni possibili alla realizzazione di un progetto di riscolarizzazione. Per questa ragione – grazie all’ampia articolazione messa a disposizione dall’autore per una prospettiva educativa e formativa migliore – i destinatari del testo sono i dirigenti scolastici e gli insegnanti di scuola e di istituti di formazione professionale, gli stessi studenti che si stanno preparando all’insegnamento, gli amministratori e i politici impegnati in questi ambiti, e, con loro, anche genitori e famiglie quali principali responsabili dell’educazione dei propri figli.



0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!