
Perché da un secolo e mezzo una Breccia divide l’Italia

Articolo tratto dal numero di ottobre 2020 di Tempi. Questo contenuto è riservato agli abbonati: grazie al tuo abbonamento puoi scegliere se sfogliare la versione digitale del mensile o accedere online ai singoli contenuti del numero.
Sono trascorsi pochi giorni dal 150esimo anniversario della Breccia di Porta Pia, quando, il 20 settembre 1870, le truppe del recente (1861) Regno d’Italia entrarono con la forza a Roma. Si compiva così il processo di unificazione politica della penisola: un processo così divisivo nelle modalità con cui fu realizzato che ancora oggi se ne possono constatare le conseguenze.
Giova, infatti, ricordare che Roma non è sempre stata la capitale italiana, ma fino al 1870 era la capitale di uno Stato con un proprio territorio (al suo apogeo comprendeva Lazio, Umbria, Marche e Romagna) che aveva come sovrano il pontefice. Piaccia o non piaccia, quello Stato sovrano venne sconfitto con la violenza e contro ogni rispetto del diritto internazionale. Si aprì così una frattura fra gli italiani, che non si è mai veramente ricomposta. Il papa “prigioniero” in Vaticano non era appena un sovrano sconfitto, era anche il capo della cristianità, e contro di lui si erano rivoltate forze che non erano ostili solamente al suo potere temporale, ma soprattutto al suo “ruolo” spirituale.
La frattura non si chiuse veramente neppure con il Concordato del 1929, quando il regime fascista risarcì la Chiesa e le offrì un ruolo importante nella vita pubblica. La Chiesa dovette, infatti, rinunciare al sogno di (ri)costruire in Italia uno Stato secondo i princìpi della dottrina sociale cristiana. I modelli di riferimento dello Stato italiano rimanevano antitetici a quel progetto: un sistema politico con un solo partito, quello fascista; una società conflittuale in cui fascismo e Chiesa si sarebbero fatti concorrenza nell’ottica dell’egemonia culturale.
Da Mazzini e Cavour ai socialisti
È difficile comprendere la storia moderna del paese se non si riescono a cogliere i risvolti più profondi del 20 settembre 1870. Da allora (in realtà già dall’inizio del Risorgimento) gli italiani si suddivisero in diversi “partiti”. Vi erano quelli che volevano scristianizzare l’Italia: i liberali “moderati”, che sostenevano la soluzione sabauda del processo di unificazione e facevano rifermento al conte Camillo Benso di Cavour; i nazionalisti repubblicani, che avevano come leader Giuseppe Mazzini. Poi vi erano i cattolici: ancora maggioranza all’epoca, non volevano necessariamente il ritorno al papa-re, tuttavia furono emarginati e perseguitati, pertanto si dedicarono all’organizzazione del paese “reale” in contrapposizione a quello “legale”, cioè alle istituzioni pubbliche.
Questo conflitto durerà fino alla Prima Guerra mondiale, quando per la prima volta i cattolici vengono coinvolti nel governo del paese in nome della solidarietà nazionale di fronte all’invasore. Durante le elezioni del 1913, in occasione delle quali fu stipulato il cosiddetto Patto Gentiloni (un accordo elettorale che metteva fine alla fase più acuta del conflitto Stato -Chiesa), i cattolici erano andati a votare in massa e avevano favorito l’elezione di 228 deputati cattolici o conservatori in opposizione ai socialisti. Questi ultimi, costituitisi in partito nel 1892, erano diventati il “nuovo” partito anticristiano che sfidava elettoralmente i liberali moderati e cercava di conquistare le masse, ponendosi in concorrenza con il mondo cattolico e le sue organizzazioni.
L’unità impossibile
Il quadro culturale e politico subì ulteriori modifiche con il fascismo e soprattutto con il Concordato. La Chiesa riottenne la sua libertà grazie al possesso di un territorio, piccolo ma reale, che le garantirà una certa indipendenza. A prezzo però di una nuova rinuncia dei cattolici all’azione politica diretta. La “ferita” di Porta Pia scomparirà dal dibattito pubblico, con il regime fascista impegnato ad autopresentarsi come il custode e il compimento del Risorgimento e i cattolici impegnati, a loro volta, a presentarsi come non ostili all’Italia. Questo atteggiamento non muterà neppure nel secondo dopoguerra. I cattolici andranno al governo con la Democrazia cristiana; la loro cultura politica, però, era stata sconfitta: la mancanza di una lettura condivisa della storia nazionale ne impediva l’unità, secondo l’analisi di Augusto Del Noce.
Oggi la situazione è ulteriormente peggiorata per i cattolici, ridotti a minoranza e soprattutto divisi. Non si parla più della Breccia di Porta Pia, né del movimento che nacque nel 1874 con l’Opera dei congressi. Rimangono don Luigi Sturzo e Alcide De Gasperi, ma non si capisce da quale storia siano usciti. Si parla spesso oggi di un ritorno della presenza politica, o comunque pubblica, dei cattolici. Se non se ne conosce la storia, con i suoi passaggi difficili ma reali, difficilmente essa sarà efficace.
Foto Ansa


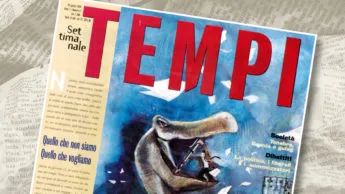
0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!