
Per il popolo niente ponti


Articolo tratto dal numero di Tempi in edicola (vai alla pagina degli abbonamenti) – Sociologo, docente di analisi dei dati all’Università di Torino, Luca Ricolfi è una figura anomala nel panorama culturale e accademico italiano. Il suo è il caso di un ricercatore che lascia parlare dati, numeri e fatti senza piegarli a un teorema ideologico stabilito a priori. Non è un’intelligenza di destra Ricolfi, tutt’altro, ma al campo liberal e progressista la sua abitudine di preferire alla “narrazione” vendoliana o al “racconto” renziano “la realtà effettuale delle cose” non garba. C’è da capirli: nel 2008 Ricolfi dedicò alla sinistra il suo Perché siamo antipatici (Longanesi), descrivendo il complesso dei migliori che non ha mai smesso di affliggere il campo progressista. Adesso arriva l’altro affondo: Sinistra e popolo. Il conflitto politico nell’era dei populismi (Longanesi, 288 pagine, 16,90 euro). Qui Ricolfi spiega perché oltre ad essere antipatica la sinistra tradizionale è ormai anche priva di consenso.
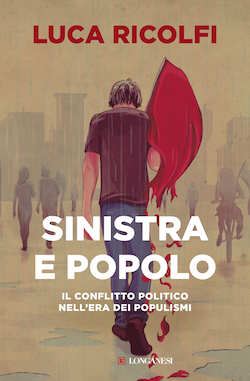 Professore, lei parla dell’estinzione delle categorie di destra e sinistra, contestando alla sinistra di avere usato fino ad oggi questa assiologia a suo favore come discrimine tra il bene e il male. Qual è il nuovo discrimine allora? La sua analisi farebbe intendere che è quello tra chi sta sopra e chi sotto nella piramide sociale.
Professore, lei parla dell’estinzione delle categorie di destra e sinistra, contestando alla sinistra di avere usato fino ad oggi questa assiologia a suo favore come discrimine tra il bene e il male. Qual è il nuovo discrimine allora? La sua analisi farebbe intendere che è quello tra chi sta sopra e chi sotto nella piramide sociale.
Il problema è che, nell’era della globalizzazione, non c’è un solo discrimine ma ve ne sono due. Il discrimine più importante è fra forze dell’apertura, che accettano o promuovono ogni tipo di scambi (merci, servizi, capitali, informazioni), e forze della chiusura che invocano qualche tipo di chiusura, economica o sociale, comunque basata sull’idea che gli stati debbano riprendersi alcune prerogative, dal controllo delle frontiere a quello della moneta. In questo quadro il discrimine fra destra e sinistra resta, ma assume un carattere più sfumato, e soprattutto è trasversale alla dicotomia fra forze dell’apertura e forze della chiusura. In entrambi i campi, sinistra significa una maggiore attenzione ai diritti e alla lotta alle diseguaglianze, destra significa maggiore attenzione ai doveri, alla tradizione e alla difesa della libertà, soprattutto in ambito economico. Ma è piuttosto comune che questi più o meno nobili ideali subiscano contaminazioni e ibridazioni: la sinistra, ad esempio, sta sempre più diventando la paladina dei garantiti e dei ceti medi, la destra oscilla tuttora fra il polo conservatore e quello liberista.
I nemici della società aperta – mercato libero, globalizzazione, istituti sovranazionali – sono i populisti, lei dice, di destra e di sinistra, mentre i suoi sostenitori sono i liberali di destra e di sinistra. Tuttavia esistono declinazioni a sinistra del populismo che sono favorevoli, per dire, alla circolazione degli uomini ma ostili alla libertà di mercato.
Certo, la sinistra conservatrice, talvolta erroneamente definita “estrema”, “radicale”, “antagonista”, è proprio questo: sogna un mondo iper-regolato in economia, ma del tutto aperto ai flussi migratori.
È soprattutto la sinistra liberal a essere identificata con l’establishment: favore per la globalizzazione e politicamente corretto. Dunque è questa sinistra ad essere insieme il bersaglio della polemica populista e la vittima destinata dell’emorragia di consenso tra i ceti popolari. Perché il popolo non trova più nella sinistra la sua naturale espressione politica? Come è avvenuto il divorzio?
Il divorzio si è prodotto nell’arco di quasi mezzo secolo, dalla fine degli anni Sessanta a oggi. La ragione per cui il popolo non trova più nella sinistra la sua voce e la sua espressione politica è molto semplice: l’establishment di sinistra non ama il popolo, e disprezza profondamente la gente comune, di cui non capisce né le ansie né i drammi quotidiani. Da molti decenni, ormai, la preoccupazione centrale dei partiti di sinistra è l’espansione dei diritti (dall’aborto ai matrimoni gay, dal divorzio alla fecondazione assistita, eccetera) e, in campo economico, la protezione dei ceti medi, non certo la lotta contro la povertà e contro le conseguenze negative della globalizzazione.
«Spesso chi è per l’accoglienza senza se e senza ma, più che non conoscere i problemi, semplicemente non ne ha. Ad esempio non vive in un quartiere degradato». Sono parole sue, pronunciate dopo la manifestazione milanese per l’accoglienza dei migranti. Tuttavia c’è chi contesta la sua tesi opponendo dei dati: dove ci sono più stranieri – viene notato – il voto anti-stranieri è basso. La Lega a Milano non supera il 10 per cento, a Torino non arriva al 5. E nella Parigi colpita dal terrorismo islamista Marine Le Pen non va oltre il 5.
È un ragionamento fallace. Per cogliere gli umori politici dei ceti popolari in un paese come l’Italia occorre tenere conto non solo della Lega ma di tutto lo spettro di forze politiche anti-immigrati, che includono Fratelli d’Italia, il Movimento Cinque Stelle e, per molti versi, la stessa Forza Italia. Ma, soprattutto, occorre osservare la distribuzione geografica del voto: le forze populiste raccolgono consensi altissimi nei quartieri popolari, anche in grandi città come Roma e Torino. Il consenso alla Lega è un pessimo indicatore della forza delle istanze populiste.
Se la sinistra ha esaurito il suo ruolo storico e se i populismi danno risposte facili e inadeguate a problemi complessi, cosa c’è oltre questo stallo professore? Lei sembra suggerire alle forze dell’apertura alla globalizzazione di destra e di sinistra di integrare alcune spinte populiste: più protezione economica, meno immigrazione incontrollata.
Esattamente, anche se non è semplice e non basta. Il problema economico è come assicurare protezione senza la scorciatoia, alla lunga controproducente, di un ritorno al protezionismo. Il problema sociale è non solo come governare i flussi migratori, ma come contrastare la criminalità di tutti (nativi e stranieri), che colpisce innanzitutto chi abita in quartieri degradati, e come impedire che il welfare per gli stranieri vada a detrimento dei nativi.
Nel suo studio, ricchissimo di citazioni trasversali, manca un riferimento a un grande outsider della cultura politica e imprenditoriale italiana: Adriano Olivetti. Il quale fu non solo un imprenditore illuminato ma anche un pensatore politico realmente al di là della destra e della sinistra, antesignano di un federalismo comunitario e democratico senza essere populista. Pensa che la visione di Olivetti, né internazionalista né nazionalista, possa avere un futuro nel nostro paese?
No, perché ormai ci siamo spinti troppo in là. Le nostre società (non solo l’Italia) sono ormai divenute ultra-individualiste e ultra-competitive, con pochissimo spazio per le istanze comunitarie. Il senso di comunità viene tanto più teorizzato e propagandato nel discorso pubblico (media, pubblicità, politica), quanto più viene calpestato e offeso nei nostri modi di vita, improntati a egocentrismo, consumismo, narcisismo, ostentazione, volgarità. Siamo agli antipodi del mondo sognato da Olivetti, e a quanto pare ci sta bene così.
Foto Ansa



0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!