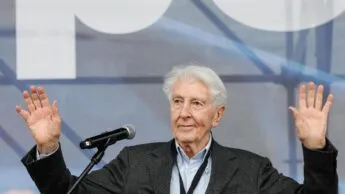
Oggi vaccinati non significa “impermeabili al virus”

Più ci chiedono di sognare la palingenesi – resistere fino al vaccino, torneremo a vita nuova col vaccino – più le domande si moltiplicano. Non sull’utilità di una profilassi vaccinale – ditelo ai celebrazionisti per cui chiunque osi porre questioni è un negazionista no vax -, ma sul ridurre il problema e il debellamento di una pandemia all’obbligatorietà o meno di qualche puntura. Don Roberto Colombo è genetista clinico e specialista nella diagnostica molecolare delle malattie rare, docente della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica (Roma) e consultore del Dicastero Laici, Famiglia e Vita della Santa Sede. A lui abbiamo chiesto un aiuto ad orientarci in questo pandemonio di informazioni e dichiarazioni sguainate sulla profilassi anti-Covid. Ne è nato un lungo approfondimento su efficienza, sperimentazione, reazioni, distribuzione, affidabilità e obbligatorietà vaccinale che vi proponiamo a puntate. Qui la prima puntata (Non finirà con una puntura, «oggi non basta il vaccino per sconfiggere il Covid»). Ecco la seconda, a tema la durata e il tipo di immunità.
Professor Colombo, cosa si sa del periodo di azione del vaccino: per quanto tempo potrà avere effetti sulla persona e sulla comunità e con quale durata di immunità?
Non disponiamo ancora di dati affidabili sulla durata della immunità conferita dai diversi tipi di vaccini che hanno completato o stanno completando la fase III della sperimentazione clinica. E questo è comprensibile, perché il periodo di osservazione degli studi sui volontari che hanno ricevuto il vaccino è stato sinora troppo breve. Come ha scritto pochi giorni fa sul New England Journal of Medicine un gruppo di ricercatori e medici statunitensi che stanno studiando i vaccini basati sulla biotecnologia del mRna (è il caso del vaccino mRna-1273 di Moderna, da loro indagato, ma anche del BNT162b2 di Pfizer-BioNTech), «le risposte longitudinali del vaccino [cioè nel tempo successivo alla sua inoculazione] sono di una importanza critica e per questo è in corso una analisi di tipo follow-up [controllo periodico programmato dei vaccinati] per valutare la sicurezza e la immunogenicità [del vaccino] nei partecipanti [allo studio] per un tempo di 13 mesi». Siamo ancora lontani da questo traguardo della ricerca. I dati preliminari consento solo di osservare che «gli anticorpi neutralizzanti presenti nel siero [dei vaccinati] continuano ad essere osservati in tutti i partecipanti [allo studio] 119 giorni […] dopo la prima vaccinazione (90 giorni dopo la seconda vaccinazione)». Mancano ancora 10 mesi di osservazione per completare lo studio di follow-up indicato dagli autori, i quali concludono affermando che, «sebbene i correlati della protezione [vaccinale] contro l’infezione da Sars-Cov-2 non sono ancora stati accertati, questi risultati mostrano che, nonostante l’atteso lieve declino dei livelli degli anticorpi leganti e neutralizzanti, il [vaccino] mRna-1273 ha la potenzialità di fornire una immunità umorale duratura». Quanto duratura, per ora non possiamo dirlo. Si noti, tra l’altro, che il campione di vaccinati sperimentalmente preso in esame dagli autori è di soli «34 adulti sani che hanno partecipato allo stesso studio ricevendo [ognuno] due iniezioni di vaccino alla dose di 100 microgrammi» a 28 giorni di distanza l’una dall’altra, e che i soggetti di studio hanno tutti una età superiore ai 18 anni (nulla sappiano di come si comporti lo stesso vaccino nei bambini e negli adolescenti).
Non sappiamo quanto siano duraturi, però i produttori hanno più volte sottolineato, con dovizia di percentuali, l’efficacia dei loro vaccini.
Una pubblicazione scientifica ancora più recente (10 dicembre) apparsa on-line sulla stessa rivista medica, che riguarda il vaccino BNT162b2, ribadisce quanto precedentemente annunciato dal produttore Pfizer-BioNTech che il preparato ha una «efficacia del 95 per cento nel prevenire il Covid-19 (intervallo di credibilità al 95 per cento: 90.3–97.6)». Il modello statistico assunto per ricavare l’efficacia è quello Bayesiano con distribuzione beta-binomiale. È necessario però ricordare che questo valore così elevato si riferisce alla efficacia in condizioni sperimentali, con un protocollo di studio molto rigoroso ed una organizzazione di reclutamento dei vaccinandi e di tempistica delle inoculazioni altamente efficiente. Come l’esperienza su altri vaccini insegna (in primis, quella suoi vaccini anti-influenzali), l’efficacia pratica, nella prassi ordinaria della sanità, è sempre inferiore a quella determinata sperimentalmente e potrebbe non superare il 70 per cento. In questa seconda pubblicazione non viene preso in considerazione il quesito sulla durata della immunizzazione anti-coronavirus conferita dal vaccino e non sono riportati dati sui livelli di anticorpi leganti e neutralizzanti presenti nel siero dei vaccinati a distanza di tempo dalla somministrazione delle due dosi di vaccino (30 microgrammi, a distanza di 21 giorni l’una dall’altra). Comunque, anche in questo studio il periodo di osservazione clinica è stato sinora breve, «con un tempo medio di follow-up di due mesi dopo la seconda dose» di vaccino. Anche se fossero stati presentati, i dati sui livelli di anticorpi presenti a tale data non avrebbero aggiunto ulteriori informazioni utili sulla durata dell’effetto immunizzante dei vaccini a mRna rispetto a quanto riportato dagli autori che hanno pubblicato il 3 dicembre sulla stessa rivista.
Deborah Fuller, esperta di vaccini presso l’Università di Washington, ha detto inoltre che non si sa ancora se i vaccini Pfizer-BioNTech e Moderna proteggano completamente le persone dall’infezione virale o solo dai sintomi del Covid-19. In altre parole, le persone vaccinate potrebbero ancora essere suscettibili di venire infettate e potrebbero trasmettere il virus. È corretto?
La vaccinazione anti-virale può produrre due tipi di immunità nei soggetti vaccinati: quella cosiddetta “sterile” e quella “non sterile”. I vaccini sinora sviluppati ed utilizzati nella profilassi inducono quasi tutti una immunità non sterile. Fanno eccezione quelli contro l’epatite di tipo A e contro l’infezione da papillomavirus umano (Hpv), che hanno dimostrato di essere efficaci sia contro la manifestazione dei sintomi della malattia, sia contro le infezioni asintomatiche. Si tratta di una sorta di “impermeabilità al virus”. Nel caso degli altri vaccini, quelli che forniscono una immunità non sterile, essi prevengono l’insorgenza della malattia con i suoi sintomi, ma non proteggono dalla infezione virale che la causa, così che il soggetto vaccinato – qualora entri a contatto con il virus in condizioni contagiose – può sviluppare una infezione asintomatica e potrebbe trasmettere ulteriormente il virus ad altri soggetti. Oggi non abbiamo dati scientifici affidabili per rispondere alla domanda su quale dei due tipi di immunità sarà indotta dai vaccini anti-Covid.
Però è una domanda enorme, cosa ci dice l’esperienza di altri coronavirus?
Uno dei pochissimi studi che hanno messo a tema la questione (di notevole rilevanza per quanto concerne il contenimento della pandemia attraverso la profilassi vaccinale) è quello pubblicato on-line come pre-print sul sito BioRxiv da un gruppo di ricercatori statunitensi (National Institutes of Health) e inglesi (Jenner Institute). Utilizzando il macaco come modello animale sperimentale, gli studiosi hanno osservato che l’inoculazione di un vaccino genetico che induce la produzione della proteina spike del coronavirus (come fanno i vaccini di Pfizer-BioNTech e Moderna) da parte delle cellule del corpo porta ad una protezione dell’animale nei confronti della polmonite bilaterale e ad una riduzione della replicazione virale nei polmoni, ma non ha effetto di contenimento della carica virale nelle vie aeree superiori, quelle maggiormente implicate nella trasmissione della infezione da soggetto a soggetto. Occorre assumere con cautela le conclusioni di questo e altri studi su modelli animali, perché l’organismo umano potrebbe rispondere in modo differente al medesimo tipo di vaccino. Ma questi dati non sono comunque una buona notizia. Anche a prescindere da questi risultati sull’animale, le esperienze che abbiamo con altri coronavirus e con i virus che provocano infezioni delle vie aeree superiori, suggeriscono che non ci si deve aspettare che i vaccini anti-Covid conferiscano una immunità sterile. Ma, come ha dichiarato il coordinatore dello studio, Vincent J. Munster, «trasformare la malattia [Covid-19] da polmonite a raffreddore è comunque un grande passo avanti». Ci auguriamo che possa essere davvero così: se non proprio un raffreddore, in una sindrome simil-influenzale che verosimilmente continuerà ad accompagnarci ancora per parecchio tempo.
Scusi, ma se col vaccino abbattiamo nella popolazione solamente o prevalentemente il numero di soggetti positivi sintomatici, come faremo a sapere se il virus circola ancora e in che misura?
Per monitorare l’andamento della diffusione del virus nella popolazione vaccinata si dovrà ricorrere non alla registrazione delle manifestazioni sintomatiche e neppure ai comuni test immunologici, ma alla rilevazione della presenza del Rna virale attraverso i test molecolari (tampone rinofaringeo o altri). Il tampone molecolare specifico per il betacoronavirus Sars-Cov-2 col tempo, quando l’immunizzazione di ampie fasce della popolazione sarà stata raggiunta o per via infettiva o tramite la vaccinazione, tornerà ad essere ciò che in origine è, secondo la natura di questo strumento di laboratorio: un test utile per la ricerca e per le indagini epidemiologiche, non un sostituto della diagnosi clinica di Covid-19, che dovrà anzitutto basarsi sulla valutazioni di segni e sintomi specifici di questa malattia, che in questi mesi abbiamo imparato a conoscere con sempre maggiore precisione. Solamente quando strettamente necessario per una diagnosi differenziale non altrimenti formulabile si dovrà ricorrere alle indagini molecolari per l’identificazione del Rna virale.
(2. Continua)
Foto Ansa



0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!