
Ci sono anche Pechino e Baku dietro alle rivolte antifrancesi in Nuova Caledonia

Malgrado la partenza nella serata di martedì di Emmanuel Macron alla volta della Nuova Caledonia, appare sempre meno probabile che il presidente riesca a mantenere fede al suo proposito di convocare a Versailles entro la fine di giugno il Congresso del Parlamento, cioè la riunione di Assemblea nazionale e Senato per l’approvazione definitiva dell’emendamento costituzionale che modificherebbe le norme che regolano le elezioni provinciali nel Territorio d’Oltremare: sei morti a causa delle sommosse scoppiate nell’arcipelago il 13 maggio, 200 milioni di euro di danni per la distruzione di automobili, officine, negozi e infrastrutture, barricate a impedire il traffico sulle strade principali, la sospensione dei voli dall’aeroporto internazionale della capitale provinciale Noumea e la necessità di proclamare lo Stato d’emergenza fino al 27 maggio non sono le uniche ragioni.
Da giorni anche alcune delle forze politiche che avevano approvato la riforma del corpo elettorale per le elezioni provinciali caledoniane messa ai voti in Senato e all’Assemblea nazionale e alcuni stretti alleati del presidente Macron chiedono di rallentare la marcia e di dare più tempo a un possibile accordo istituzionale fra indipendentisti e anti-indipendentisti nel territorio annesso alla Francia da Napoleone III nel 1853.
Chi ha iniziato le rivolte in Nuova Caledonia
Con il provvedimento voluto dal governo il corpo elettorale per le elezioni provinciali della Nuova Caledonia verrebbe allargato a tutti coloro che risiedono nel territorio da almeno dieci anni, mentre attualmente tale voto è riservato a coloro che risultavano residenti al 1° gennaio 1998. In pratica il 25 per cento degli attuali 270 mila abitanti è escluso dal voto per gli organi di governo del territorio (mentre tutti i maggiorenni attualmente cittadini francesi hanno diritto al voto politico e a quello per le elezioni presidenziali).
A scatenare la protesta violenta contro la riforma in itinere è stata la comunità kanaka, che rappresenta il 41 per cento degli abitanti e l’etnia indigena autoctona, fautrice da sempre dell’indipendenza da Parigi. I kanaki vedrebbero penalizzata la propria rappresentatività da un allargamento (calcolato in 25 mila votanti, che porterebbero il corpo elettorale da 170 mila a 195 mila aventi diritto) che favorirebbe i soggetti di recente immigrazione, francesi metropolitani e polinesiani.
I referendum per l’indipendenza della Nuova Caledonia
Il governo e la maggioranza del Parlamento francese si sentono autorizzati ad andare oltre a quanto era stato stabilito con gli accordi di Matignon (1988) e di Noumea (1998) per mettere fine alla guerra civile strisciante che aveva tormentato l’arcipelago fra il 1984 e il 1988 perché sarebbero stati assolti i principali obblighi che la Francia si era assunta davanti agli indipendentisti: lo svolgimento di un referendum sull’indipendenza dell’arcipelago, ripetibile fino a tre volte in caso di bocciatura della richiesta di separazione dalla Francia.
Tre referendum si sono svolti fra il novembre 2018 e il dicembre 2021, tutti e tre negativi per la causa indipendentista, ma l’ultimo appuntamento è stato boicottato dai kanaki per motivi religiosi: il territorio ha perduto 314 vite a causa della pandemia da Covid, per il 70 per cento fra i non europei, e la cultura locale prevede un anno di lutto; i partiti che rappresentano gli indigeni indipendentisti si sono rifiutati di condurre una campagna referendaria in queste condizioni.

Gli accordi di Noumea
Parigi a sua volta si è rifiutata di rinviare l’appuntamento con le urne, e così anziché l’81-85 per cento degli aventi diritto dei precedenti referendum a quello del dicembre 2021 ha partecipato solo il 44 per cento degli elettori; e mentre nei due precedenti referendum il “no” aveva vinto prima col 56 e poi col 53 per cento dei voti, nel terzo ha trionfato col 96 per cento. Secondo gli accordi di Noumea al fallimento dei referendum indipendentisti doveva seguire un negoziato fra tutte le componenti del mondo politico caledoniano per la definizione di un nuovo statuto della Nuova Caledonia all’interno della Repubblica francese. Il negoziato non c’è stato a causa del rifiuto kanako di accettare il risultato del dicembre 2021, e così Macron ha deciso che dopo due anni e mezzo di impasse sarebbe stata Parigi a definire il futuro dell’arcipelago.
Contraccolpi nazionali e internazionali per Macron
I contraccolpi negativi dell’accelerazione macroniana per il governo e per il presidente si collocano a due livelli, quello nazionale e quello internazionale. A livello nazionale, le cose sembravano essersi messe bene dopo il voto dell’Assemblea nazionale che nella notte fra il 14 e il 15 maggio aveva approvato il progetto di legge costituzionale con 351 voti a favore e 153 contro. Ai voti di Renaissance, il partito di Macron, si erano aggiunti quelli dei gollisti e degli altri centristi e quelli della destra radicale del Rassemblement Nationale di Marine Le Pen. Avevano votato contro socialisti, comunisti, Verdi e gli islamo-goscisti di La France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon.
Tutti costoro giudicano sia che la Nuova Caledonia costituisce un’eredità coloniale che la Francia non può gestire senza il consenso delle popolazioni autoctone, sia che il progetto di riforma non deve andare avanti per non provocare violenze come quelle che si sono poi effettivamente materializzate da parte degli indipendentisti. Scoppiato il caso, anche alcuni di coloro che avevano votato a favore del provvedimento hanno fatto marcia indietro, a cominciare dal partito di Marine Le Pen, che ha invitato a rinviare almeno di sei mesi la convocazione del Congresso del parlamento per ratificare la riforma elettorale e ad offrire ai kanaki la possibilità di un altro referendum, non prevista dagli accordi di Noumea.
La Francia è poco amata dagli stati dell’Oceania
Su una linea simile si colloca anche il presidente del Senato Gerard Larcher, affiliato a Les Republicains (gollisti), che invece in grande maggioranza restano favorevoli alla convocazione del Congresso entro fine giugno se nel frattempo indipendentisti e anti-indipendentisti non trovano un accordo in Nuova Caledonia. Ma anche il sindaco di Noumea Sonia Lagarde e la presidente dell’Assemblea nazionale Yaël Braun-Pivet, che appartengono al partito di Macron, chiedono di prendere tempo per evitare che la violenza dilaghi nell’arcipelago che dista da Parigi 16.700 chilometri.
Ancora più preoccupante il quadro internazionale: la Francia si è improvvisamente risvegliata da un certo autocompiacimento per scoprire quanto poco sia amata dagli stati indipendenti dell’Oceania, tutti più favorevoli – chi apertamente, chi obliquamente – all’indipendenza della Nuova Caledonia che al suo mantenimento sotto sovranità francese. Continua a opporsi alla presenza francese e a rinnovare periodicamente la presentazione della causa kanaka presso il Comitato speciale delle Nazioni Unite per la decolonizzazione il “Gruppo punta di lancia melanesiano”, un’associazione regionale di stati che comprende la Papua Nuova Guinea, le Isole Salomone, le Figi, Vanuatu e il Fronte di liberazione nazionale kanaka e socialista, la storica organizzazione politica indipendentista caledoniana.
Nuova Caledonia, «Macron ascolti la minoranza kanaka»
Sulle pagine di Le Monde l’ex console generale australiana in Nuova Caledonia Denise Fischer ha elencato tutte le dichiarazioni perplesse o ostili di capi di governo della regione nei riguardi della volontà francese di svolgere il referendum del dicembre 2021 nonostante il boicottaggio kanako. E ha concluso così il suo intervento:
«Negli ultimi decenni, la Francia ha investito molto per riconquistare la fiducia della regione. In particolare lo Stato francese ha messo fine ai suoi test nucleari nella regione e concesso maggiore autonomia ai suoi territori del Pacifico. E questo, nel rispetto per le popolazioni e per le autorità locali. Emmanuel Macron ha collocato la Nuova Caledonia al cuore delle sue ambizioni geopolitiche. Per preservare il suo desiderio di vedere la Francia diventare una grande potenza nella regione indo-pacifica, il capo dello stato deve ora ascoltare la minoranza kanaka in crescita (secondo la Fischer oggi rappresenterebbe il 45 per cento della popolazione – ndt) e gli appelli dei governi della regione. Deve farlo con l’obiettivo di progredire, mano nella mano, con umiltà e rispetto».
Gli interessi della Cina e la guerra ibrida dell’Azerbaigian
D’altra parte non è un segreto per nessuno che sulla Nuova Caledonia ha messo gli occhi la Cina, già molto influente nella regione: dal 2022 le Isole Salomone hanno un accordo per la reciproca sicurezza con Pechino, nel gennaio di quest’anno Nauru ha riconosciuto il governo di Pechino come legittimo rappresentante della Cina e ha interrotto i rapporti diplomatici con Taiwan (la stessa cosa avevano fatto negli anni precedenti le Isole Salomone e Kiribati), l’anno scorso il presidente uscente degli Stati Federati di Micronesia, David Panuelo, ha descritto la “guerra politica” che la Cina avrebbe condotto attraverso la sua ambasciata, comprese operazioni di intelligence clandestine, interferenze negli affari interni e corruzione di funzionari governativi per favorire gli interessi di Pechino.
La Nuova Caledonia è interessante per le miniere di nickel, nelle quali si trova fra il 20 e il 30 per cento delle riserve mondiali di questo minerale, indispensabile per la produzione di elettrodomestici e batterie per automobili. L’attuale produzione locale invece rappresenta l’8 per cento del totale mondiale. Ciliegina sulla torta, fra le mani e sulle magliette dei manifestanti indipendentisti che hanno infiammato le recenti proteste sono state notate bandiere dell’Azerbaigian e addirittura ritratti del presidente Aliyev. Il ministro degli Interni Gérald Darmanin assicura: «L’interferenza azera non è un fantasma, è una realtà. Una parte degli indipendentisti caledoniani ha concluso un patto con l’Azerbaigian». Baku appare impegnata in una guerra ibrida contro la Francia motivata dal sostegno diplomatico di Parigi alla causa armena del Nagorno Karabakh.
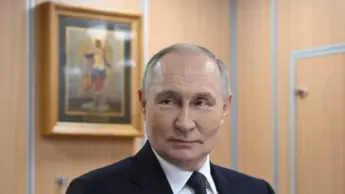


0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!