
Non consumare l’ambiente, ma abitarlo

Pubblichiamo l’intervento di Rodolfo Casadei al convegno “L’uomo e il Creato: l’ecologia integrale di fronte alle sfide ambientali” tenutosi a Rimini il 13 dicembre 2019. All’incontro ha partecipato anche lo scienziato Franco Prodi (qui la sua intervista a Tempi).
Sono molto grato all’Umana Dimora e in particolare a Franco Boarelli per l’invito di stasera. Ammiro il vostro coraggio di associazione ambientalista che vuole ascoltare e fare ascoltare esponenti di posizioni di nicchia, che non rientrano in nessuno dei grandi schieramenti in campo sulla questione ambientale. Non mi paragono nemmeno lontanamente al prof. Franco Prodi, che è uno scienziato di valore indiscutibile, ma rilevo semplicemente che abbiamo in comune un elemento di dissenso rispetto al pensiero dominante su questi temi, e uno sforzo di ricerca (da parte sua) e di riflessione (da parte mia) che vorrebbero essere un po’ originali.
Per questo motivo introduco la mia breve relazione con due premesse. La prima premessa è che stasera rappresento soltanto me stesso, non incolpate l’Umana Dimora per quello che dirò o non dirò. Come si legge in fondo a certi articoli di giornale: il punto di vista dell’Autore non rispecchia necessariamente la linea editoriale. La seconda premessa è che io sono cristiano e parlo da un punto di vista cristiano. Questo è decisivo rispetto all’argomento di stasera, perché un cristiano crede che il mondo non si salva da sé, ma è salvato da un Altro. Il cristiano crede che il Regno di Dio non si realizza in terra, per opera degli uomini, perché siamo tutti condizionati dal peccato originale, che ha investito tutta la creazione, anche la natura. La perfezione è irraggiungibile, l’utopia è utopia. Cieli nuovi e terra nuova si avranno solo col ritorno di Cristo, col suo secondo avvento, ma prima del secondo avvento di Cristo c’è l’avvento dell’Anticristo, che mira esattamente a realizzare il Regno di Dio in terra senza Dio, la sua è un’imitazione usurpatrice del cristianesimo. Come sanno gli esperti di queste cose, non mi riferisco tanto all’Apocalisse quanto alle due lettere di Giovanni e alla lettera di Paolo ai Tessalonicesi.
Viviamo tempi apocalittici? Questo nessuno può osare dirlo: non sappiamo né il giorno né l’ora. E poiché non sappiamo né il giorno né l’ora, dobbiamo semplicemente cercare di vivere secondo virtù, come hanno sempre cercato di fare gli uomini di retta coscienza, prima e dopo Cristo. Anche la conversione ecologica a cui chiama oggi la Chiesa cattolica altro non è che una definizione aggiornata della vita virtuosa, cioè la vita conforme alla nostra natura creaturale, cioè conforme ai nostri limiti. La virtù è giusta misura, il vizio è smisuratezza. La virtù è vita dentro ai limiti propri dell’umano, il vizio è vivere e agire secondo il principio dell’illimitatezza. Ancora oggi si sente dire che la crisi ecologica è una conseguenza dell’antropocentrismo giudaico-cristiano, che vede nell’uomo il vertice della creazione, a lui sottomessa. Come si legge in Genesi 1,28: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela e dominate sui pesci del mare, sui volatili del cielo, sul bestiame e su ogni essere vivente che striscia sulla terra». L’esegesi del testo ha sempre spiegato che il dominare di cui si parla qui consiste nell’esercizio di un retto governo sul creato, e non nello sfruttare senza limiti. Ma soprattutto vorrei dire che l’affermazione secondo cui il degrado ambientale sarebbe un prodotto dell’antropocentrismo giudaico-cristiano è un falso storico: la Rivoluzione industriale, col suo forte impatto ambientale, la massiccia immissione in atmosfera di gas a effetto serra che non vengono riassorbiti ma soprattutto di molti altri inquinanti coincide con l’inizio del processo di secolarizzazione; l’impronta ecologica umana media è diventata insostenibile all’inizio degli anni Settanta del secolo scorso, cioè proprio quando è cominciato il declino del cristianesimo nei paesi industrializzati; e l’aggravamento di questa insostenibilità va di pari passo col declino numerico del cristianesimo nei paesi industrializzati europei e nordamericani.
Mi rendo conto che su questa come su altre cose non siamo tutti d’accordo. Non siamo tutti d’accordo sul peso da attribuire alle emissioni di anidride carbonica nei cambiamenti climatici; non siamo tutti d’accordo sul giudizio politico e culturale da dare sul movimento dei “Venerdì per il futuro” ispirato a Greta Thunberg. Ma su una cosa credo che siamo tutti d’accordo: siamo di fronte a una crisi ecologica epocale, l’uomo sta distruggendo la sua propria casa e se stesso. Siamo tutti d’accordo che a causa dell’azione umana migliaia di specie animali e vegetali si stanno estinguendo, l’aria è irrespirabile a causa del particolato in Europa e dei fumi industriali in Asia; siamo d’accordo che acque e terre sono inquinate da prodotti non biodegradabili, siamo d’accordo che stiamo esaurendo la fertilità dei suoli e distruggendo le foreste tropicali, stiamo impoverendo la biodiversità, stiamo distruggendo ecosistemi, stiamo consumando risorse più velocemente di quanto esse possano ricostituirsi: nel giro di 40 anni la data in cui l’uomo comincia a sovraconsumare le risorse terrestri s’è spostata dal 3 novembre (com’era nel 1980) al 29 luglio, come è stato misurato quest’anno.
Probabilmente siamo tutti d’accordo, o quasi tutti d’accordo, che le cause principali di questo degrado sono il consumismo, il materialismo volgare, l’individualismo. Dove torniamo a dividerci, io credo, è sulle soluzioni del problema e sulla loro fattibilità. Molti pensano che la soluzione stia nella tecnologia; molti pensano che le alternative tecnologiche pulite esistono già e che se non vengono attivate è per colpa degli interessi particolaristici dei governi, dei politici e dell’industria del petrolio; molti pensano che le alternative tecnologiche pulite ancora non esistono e allora bisogna fermare l’economia mondiale così come è ora, coi suoi consumi di energia, e investire tutte le risorse nella messa a punto di tecnologie dell’energia senza emissioni. Io invece penso che il problema è la tecnologia! Nel senso che i nostri problemi sono stati creati da tecnologie che sono l’espressione di una visione distorta dell’uomo e della natura; penso che non è vero che le tecnologie pulite in grado di sostenere consumi e stili di vita prossimi a quelli attuali esistano, e che sia colpa dei potenti se non vengono sostituite a quelle esistenti; penso che non sia realistico immaginare di fermare il mondo per tutto il tempo necessario a inventare nuove tecnologie per la produzione di energia senza emissioni.
Di seguito illustro questi punti. Il problema è la tecnologia perché la tecnologia contemporanea è improntata a quello che la Laudato Si’, l’enciclica di papa Francesco, definisce il “paradigma tecnocratico”, nel quale conta solo la quantità di potere sulle cose che l’individuo acquisisce. L’enciclica lo descrive così:
«In tale paradigma risalta una concezione del soggetto che progressivamente, nel processo logico-razionale, comprende e in tal modo possiede l’oggetto che si trova all’esterno. Tale soggetto si esplica nello stabilire il metodo scientifico con la sua sperimentazione, che è già esplicitamente una tecnica di possesso, dominio e trasformazione. È come se il soggetto si trovasse di fronte (una) realtà informe totalmente disponibile alla sua manipolazione. L’intervento dell’essere umano sulla natura si è sempre verificato, ma per molto tempo ha avuto la caratteristica di accompagnare, di assecondare le possibilità offerte dalle cose stesse. Si trattava di ricevere quello che la realtà naturale da sé permette, come tendendo la mano. Viceversa, ora ciò che interessa è estrarre tutto quanto è possibile dalle cose attraverso l’imposizione della mano umana, che tende ad ignorare o a dimenticare la realtà stessa di ciò che ha dinanzi. Per questo l’essere umano e le cose hanno cessato di darsi amichevolmente la mano, diventando invece dei contendenti. Da qui si passa facilmente all’idea di una crescita infinita o illimitata, che ha tanto entusiasmato gli economisti, i teorici della finanza e della tecnologia. Ciò suppone la menzogna circa la disponibilità infinita dei beni del pianeta, che conduce a “spremerlo” fino al limite e oltre il limite. Si tratta del falso presupposto che “esiste una quantità illimitata di energia e di mezzi utilizzabili, che la loro immediata rigenerazione è possibile e che gli effetti negativi delle manipolazioni della natura possono essere facilmente assorbiti”». (LS, n. 106)
L’enciclica cita Romano Guardini, pensatore cattolico italo-tedesco, fra i precursori di questa consapevolezza del potere umano sulla natura che sfigura tanto l’uomo quanto la natura. Molti altri pensatori tedeschi del Secondo Dopoguerra hanno sviluppato questo tema. Il più famoso di loro, Martin Heidegger, ha formulato lo stesso concetto che troviamo nella Laudato Si’ circa la tecnica che non è più accompagnamento della natura stessa delle cose, ma imposizione della volontà assoluta dell’uomo sulla realtà. Heidegger è complicato, perciò lo cito attraverso un suo commentatore di oggi, il francese Alain Finkielkraut. Che ha scritto recentemente:
«(…) la tecnica moderna affronta la realtà secondo la modalità della sfida e non dell’accordo. Essa non si accorda più alle sue forme, essa non si confronta più con le sue manifestazioni, essa le ordina di manifestarsi in un’oggettività calcolabile e sfruttabile. Ciò che veniva chiamato, con sentimenti misti di ammirazione e di apprensione, la natura, diventa, sotto la sua egida, una semplice riserva di materiali e di energie. Che cosa è un suolo per la metafisica che ci governa? Un deposito di minerali. Che cos’è un fiume? Un fornitore di pressione idraulica: “La centrale idroelettrica non è costruita nel Reno come l’antico ponte di legno che da secoli unisce una riva all’altra. Qui è il fiume, invece, che è incorporato nella costruzione della centrale” (Martin Heidegger, La questione della tecnica)».
Su questi temi tornerò più avanti. Adesso cerco di spiegare brevemente perché manca di realismo chi sostiene che la soluzione è dietro l’angolo e si chiama green economy e manca ancora più di realismo chi esige, pestando i piedi e alzando la voce, come ha fatto Greta Thunberg a New York, che siano inventate seduta stante nuove tecnologie che ci permettano di azzerare le emissioni nel giro di otto anni e mezzo, dopodiché sarebbe troppo tardi. Due anni fa, Alberto Clò, ministro dell’Industria nel governo Dini, grande esperto di energia e grande amico di Romano Prodi, ha scritto un libro che si intitola Energia e clima. L’altra faccia della medaglia. Poco dopo ha rilasciato un’intervista che aiuta a capire il senso del suo discorso. Dice Clò:
«La tesi che sostengo nel libro è che gli scenari energetici almeno nell’arco della prossima generazione possono dirsi sostanzialmente predeterminati dalla path dependence energetica – le scelte future dipendono da quelle passate – sul versante sia dell’offerta che della domanda che impone tempi lunghi e imprevedibili per scardinare gli attuali sistemi energetici. Al carbone necessitò intorno a un secolo per scalzare la legna, similmente al petrolio per detronizzare il carbone, mentre il gas naturale impiegò mezzo secolo dal 1900 al 1950 per guadagnare un decimo dei consumi e 85 anni per salire a un quinto. Che le nuove rinnovabili (…) possano divenire dominanti in tempi brevi è in teoria possibile, ma lo ritengo altamente improbabile».
L’intervistatore gli chiede: “Una società a emissioni zero è utopistica?”
Risposta:
«Più che utopica è – allo stato delle conoscenze – impossibile tecnicamente ed economicamente. Può essere al massimo un ideale di riferimento ma non è tra i traguardi conseguibili. Sostenere il contrario, facendo balenare la possibilità che nel giro di pochi decenni – un tempo breve dati i tempi degli investimenti – tutte le risorse fossili possano essere sostituite, solo volendolo, è del tutto illusorio, specie se non si indicano le condizioni necessarie. A partire dai costi e da chi li sostiene».
Altra domanda dell’intervistatore: “Le fonti rinnovabili sono la soluzione?”
Risposta:
«È fuor di dubbio che le nuove rinnovabili, (…) costituiscano un’opzione tecnologica in grado di fornire un determinante contributo alla lotta ai cambiamenti climatici. Lo è altrettanto il fatto che la loro attuale configurazione tecnologica non è tuttavia in grado di conseguire gli obiettivi attesi. Continuare comunque a sussidiarle tali e quali con un onere crescente per i consumatori – per un montante dal 2008 di 800 miliardi dollari su scala mondiale – non può ritenersi il modo più efficace ed efficiente per allocare le risorse disponibili. L’innovazione tecnologica può consentire di superare i limiti che le penalizzano, ma questo non potrà che avvenire in un futuro al momento indeterminabile (…) le nuove rinnovabili hanno rappresentato nel 2016 intorno al 3% dell’insieme delle fonti di energia consumate nel mondo contro una quota delle fonti fossili prossima all’86%. Per ribaltare questo rapporto di circa 1 a 30 necessitano tempi lunghissimi, considerando che negli ultimi venti anni la quota delle fossili si è ridotta di appena 1,4 punti percentuali».
Su questi argomenti è uscito recentemente un articolo molto interessante sul Financial Times a firma di Simon Kuper che si intitola “Il mito della crescita (economica) verde”. Vi propongo alcuni passaggi:
«Per avere una crescita economica verde, dovremmo emettere molta meno anidride carbonica per unità di prodotto interno lordo (Pil). La quantità di emissioni necessarie a produrre 1 dollaro di Pil è recentemente diminuita dello 0,4 per cento all’anno. Ma per mantenere l’aumento delle temperature a livelli sicuri, l’intensità di emissione dovrebbe diminuire 10 volte più rapidamente. I fautori della crescita verde dicono: “Non preoccupatevi, le energie rinnovabili stanno decollando”. È vero che le nuove rinnovabili ora coprono il 10 per cento del consumo energetico totale, e che nel 2050 dovrebbero toccare il 30 per cento. Ma il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico stima che avremmo bisogno di aver raggiunto una percentuale doppia per quella data. (…) I fautori della crescita verde vantano la trasformazione delle economie europee negli ultimi decenni: il Pil aumenta, le emissioni diminuiscono. Ma questo accade perlopiù perché questi paesi hanno trasferito altrove le loro emissioni: molto di ciò che consumano oggi è prodotto in Asia. Inoltre l’aviazione e il trasporto marittimo non sono calcolati nei bilanci nazionali delle emissioni. Se calcoliamo le emissioni implicite nelle merci importate, le emissioni di anidride carbonica dell’Unione Europea sono superiori del 19 per cento alla cifra ufficiale dichiarata. La triste verità è che il passaggio dalla crescita sporca alla crescita verde richiederà molto più tempo di quello che abbiamo a disposizione». (FT, 24 ottobre 2019)
Nel breve periodo non possiamo aspettarci miracoli. Mentre ci impegniamo nella transizione a fonti energetiche rinnovabili, non potremo non farci carico dell’adattamento alle nuove condizioni climatiche che si stanno creando. Anziché sovvenzionare tecnologie che non risolvono il problema, i soldi delle sovvenzioni è meglio usarli per adattarsi ai cambiamenti che non possiamo fermare: perciò costruire dighe e argini, piantare alberi, selezionare le specie vegetali più adatte, creare materiali resistenti alle nuove temperature, ecc.
Nel medio e lungo periodo, è necessaria una rivoluzione antropologica che contrasti il paradigma tecnocratico, che è diventato tecnopolio: oggi la tecnologia esercita un potere monopolistico sulle società umane. L’odierna tecnologia non è neutrale, è il frutto di una determinata antropologia. Quando dico questa cosa, ci sono ancora dei cattolici che reagiscono: «sei reazionario, condanni lo sviluppo tecnologico, la tecnologia è buona se si usa bene e cattiva se si usa male». Invito questo genere di cattolici a rileggere la Laudato Si’ al n. 114:
«Ciò che sta accadendo ci pone di fronte all’urgenza di procedere in una coraggiosa rivoluzione culturale. La scienza e la tecnologia non sono neutrali, ma possono implicare dall’inizio alla fine di un processo diverse intenzioni e possibilità, e possono configurarsi in vari modi».
Adesso che ho citato papa Francesco, posso citare anche Rod Dreher, l’autore de L’Opzione Benedetto. Purtroppo ci sono cattolici che ti dicono: «se citi l’Opzione Benedetto, sei contro il Papa». Io gli rispondo: guarda che sulla tecnologia Francesco e Dreher dicono la stessa cosa. Nell’Opzione Benedetto leggiamo:
«La maggioranza delle persone parte dal presupposto che la tecnologia non sia nient’altro che una forma di scienza applicata, il cui significato morale dipende da quello che ne fa l’utente. È un’ingenuità. In un discorso del 2015 il filosofo Michael Hanby spiegava che “prima che la tecnologia diventi uno strumento, essa è fondamentalmente un modo di guardare il mondo che ha in sé una concezione dell’essere, della natura e della verità”».
Scrive Dreher:
«Per l’Uomo Tecnologico, la “verità” è ciò che funziona per estendere il suo dominio sulla natura e trasformare quella materia in oggetti che egli trovi utili o piacevoli. Guardare il mondo dal punto di vista tecnologico significa vederlo come materiale su cui estendere il proprio dominio, soggetti soltanto ai limiti della propria immaginazione. Nella concezione cristiana classica, la vera libertà per il genere umano, secondo la sua natura, va trovata nell’amorevole sottomissione a Dio. Qualsiasi cosa non sia di Dio è una schiavitù. Nel suo libro del 1993 Technopoly. La resa della cultura alla tecnologia Neil Postman spiegava che le culture premoderne ammettevano che le loro convinzioni metafisiche e teologiche indirizzassero il modo in cui utilizzavano i loro strumenti. È soltanto nei tempi moderni, con l’ascesa della tecnologia, che gli strumenti a nostra disposizione ci hanno cambiato le carte in tavola ed acquisito il potere di indirizzare le nostre convinzioni metafisiche e teologiche».
Il punto decisivo è questo: non siamo più noi che sviluppiamo le tecniche a partire dalla nostra visione del mondo, ma è la tecnica trasformata in tecnologia che modella la nostra visione del mondo e alla fine la nostra stessa antropologia. E questo oggi è considerato un processo inevitabile. A cavallo fra il XIX e il XX secolo dominava la convinzione del determinismo storico: l’economia politica è passata dal feudalesimo al capitalismo, e per un processo storico necessario approderà al socialismo e alla società senza classi. Nel XXI secolo domina il determinismo tecnologico: siamo passati necessariamente dall’età della pietra alla rivoluzione industriale, e necessariamente approderemo all’era dell’uomo trasformato in prodotto tecnologico: diventeremo tutti cyborg, la riproduzione sessuale sarà sostituita dalla riproduzione artificiale, gli algoritmi prenderanno le decisioni al posto nostro, e così via. C’è già tutta una letteratura su questi temi: da Daniel Boorstin a Noah Yuval Harari, l’autore di Homo Deus, passando per Francis Fukuyama. Ma questa tecnologia centrata sull’idea che la libertà consiste nell’avere sempre più potere su se stessi e sulle cose è distruttiva sia della natura dell’uomo che dell’ambiente naturale. Occorre tornare al concetto classico, greco-romano ma anche giudaico-cristiano di libertà: la libertà è l’esperienza che facciamo quando moderiamo i nostri appetiti, quando governiamo i nostri desideri, quando coltiviamo l’essere più dell’avere. Questo genere di libertà non consuma l’ambiente, lo abita. E le tecnologie che da esso nascerebbero sarebbero quelle che permettono di abitare l’ambiente, e non di esaurirlo. Sarebbero quelle che permettono di fare dell’ambiente l’umana dimora. Grazie.

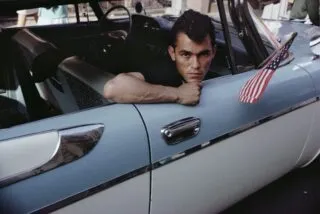

0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!