
Non chiudete il liceo classico. «Studiare gli antichi aiuta a recuperare se stessi»
Il liceo Giuseppe Parini difende la tradizione del liceo classico. Nonostante le iscrizioni per l’anno scolastico 2012/2013 stiano registrando un notevole calo, alla proposta sollevata dal preside Arrigo Pedretti di aprire nuovi indirizzi nell’Istituto, la risposta è stata quasi unanimemente negativa. I professori ne hanno discusso in un collegio docenti settimana scorsa e si è votato per la tradizione. Un liceo delle Scienze Umane che elimini lo studio della lingua e cultura greca, accanto ad una riduzione drastica del latino non sarà preso in considerazione, almeno per quest’anno. Nella scuola che ha visto maturare menti come Carlo Emilio Gadda e Dino Buzzati la visuale è chiara, ma le motivazioni a sostegno del classico si limitano a evidenziare un attaccamento per lo più affettivo al normale corso liceale. In verità il Parini è solo uno dei tanti licei italiani che vedono il classico messo in discussione, aprendo numerosi dibattiti anche sull’utilità delle università dedicate allo studio di Lettere Antiche. Dovrebbe forse la scuola arrendersi alle esigenze del tempo che gli richiederebbero di abdicare dalla sua funzione primariamente culturale in favore del puro contesto tecnico-economico? A discutere della questione Tempi.it ha voluto sentire Giuseppe Zanetto, professore di Letteratura Greca alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Milano.
Professore, come descriverebbe la situazione dei licei classici attuale?
Fra colleghi si discute spesso di questa regressione in Lombardia, prototipo dell’Italia, per cui i licei classici paiono sotto minaccia. In risposta a questo fatto si tenta sempre con maggior frequenza di ridurre le ore “critiche” del latino e del greco. Ciò su cui però vale la pena soffermarsi è la reazione che il paese esige in questo preciso momento storico. Da una parte, può essere utile promuovere i licei classici dando l’opportunità ai ragazzi delle medie o di altre scuole di conoscere il percorso educativo che vi si propone, in maniera diretta ed onesta, sostenendo cioè un confronto che li faciliti nella decisione futura. Dall’altra, indirettamente, si potrebbero indicare incontri (come ce ne sono stati di recente nell’Università Cattolica di Milano) sulla cultura antica, rieducando i ragazzi a frequentare luoghi come teatri o musei, per aiutarli a conoscere la civiltà e le sue opere prima di rifiutare entrambe a priori.
Quale deve essere la posizione dei docenti nei confronti del rilevante calo d’iscrizioni?
C’è una posizione di natura tipicamente aziendale che consiste nell’allargare l’offerta didattica, presentando una modifica del liceo tradizionale che comporta la riduzione netta del latino, sufficiente per trovare qualche etimologia, e l’eliminazione definitiva del greco. Oppure c’è la posizione coraggiosa di chi trova nel classico un’opportunità formativa ancora valida e che accoglie la sfida riproponendo il liceo in maniera migliore, ascoltando e ritoccando il proprio operato sulle richieste degli studenti.
Come giustifica questa disaffezione del popolo italiano verso l’elemento antico?
Punto cardine da cui partire per comprendere la crisi della cultura antica è il distacco evidente tra giovani e antichità che si situa in controtendenza rispetto alla scena internazionale. Paesi come gli Stati Uniti o l’Inghilterra sentono il bisogno di studiare latino, greco e materie umanistiche mai come prima d’ora. I migliori studi contemporanei di Dante si svolgono nelle università americane. Abbiamo svolto qualche mese fa un seminario in Università Cattolica in cui si confrontava l’importanza per l’antico in Italia e nelle altre nazioni, a partire dal XX secolo. Si è verificato un curioso fenomeno culturale per cui la presenza dello studio dell’antico all’inizio del ‘900 era rigorosamente richiesto. Oxford, Cambridge, altre università di rilievo, non permettevano la frequentazione dei corsi senza una conoscenza della lingua e della civiltà greca e latina. Oggi, naturalmente, le cose non stanno più così. L’antico ha subito una progressiva perdita di spazio, si è dato avvio a corsi che esaminano la civiltà antica tralasciando la grammatica, leggendo testi in traduzione, secondo una tecnica di scarto di ciò che non è più visto come essenziale. Negli ultimi anni, tuttavia, si è registrato un parziale atto di ripensamento, per cui si tenta di reintrodurre uno studio approfondito delle lingue antiche. Si è tornati a guardare alla lingua del popolo e non solamente alla civiltà in quanto tale, perché ancora dopo secoli la lingua continua ad aver tanto da dire e da dare.
E in Italia invece?
Osservo che di frequente l’Italia ricalca il comportamento internazionale, con qualche anno di ritardo. E spero che questa situazione ne sia un ulteriore esempio. In Italia siamo ancora nella fase della demolizione, viaggiamo su un treno a rilento. Il rifiuto di un certo livello di scuola superiore è una contraddizione che segue la terribile “scomunicazione” di massa. La maggior parte dei ragazzi recita la frase: “Il latino e il greco non servono a niente, sono lingue morte” secondo l’inconsapevole pregiudizio che li vede unicamente come un’amara medicina e non come portatori dell’affascinante insegnamento degli antichi. Oppure il rischio attuale è vederle come studi riservati a un élite di pochi intellettuali, per chi agogna ad un’educazione di livello alto, e così il classico parte subito svantaggiato.
Come può sussistere un’identità culturale se il popolo che la ricerca nel presente non accetta e, anzi, guarda con fastidio al passato che gli è proprio?
La base della scuola, così come la radice dell’educazione, è profondamente inserita nella tradizione antica, su questo non ci sono dubbi. Lo smarrimento dell’antico è in primo luogo una crisi della coscienza culturale e della conoscenza di sé. L’antico non è ancora passato, ma viene già percepito come morto. Bisogna interrogarsi sul perché questo modello, valido per secoli, sia stato poi smantellato. Sicuramente l’idea del progresso esercita una forte pressione sul pensiero moderno. L’umanità capisce di essersi incamminata su una strada a cui non può rinunciare e che richiede continui sacrifici e cambiamenti su ogni fronte o categoria, in nome dell’evoluzione. L’ansia di adeguarci e dare il nostro contributo al mondo porta allo sconvolgimento delle istituzioni e al superamento del modello classico. Oltre a questo, sussiste una difficoltà oggettiva delle lingue antiche che pretendono uno studio efferato e non semplice. Forse il metodo maturato dai professori non sempre è stato adeguato ai ragazzi, fino a far risultare il classico poco appetibile in un programma di scuola sempre più finalizzato alla rigorosità stabilita da misuratori e parametri. Per ultimo, non si può escludere dalla questione la crisi che sta attraversando la letteratura: l’uomo moderno non si riconosce più nel pensiero, nel discorso letterario e di conseguenza non riesce nemmeno a cogliere il richiamo alla vita che questo esercita. La cultura latina e greca non hanno valore se non lette secondo questa prospettiva. Chi legge è risvegliato ad una letteratura profondamente letteraria (aldilà del gioco di parole) cioè ad una letteratura che promuove il senso della realtà e promuove quella problematicità della vita umana, molto poco di moda ai nostri tempi. Pertanto sostengo l’importanza degli antichi per il recupero di noi stessi. Il liceo classico, che ora sta pagando a caro prezzo il fardello della crisi, è il vero luogo da cui ripartire.
Articoli correlati
3 commenti
I commenti sono chiusi.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!


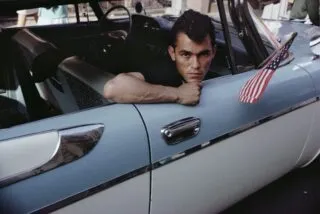
Secondo me c’è un equivoco, la “disaffezione” verso il Liceo Classico, che comunque non è scomparso, soltanto è stato un po’ ridimensionato come preferenze, deriva dalla convinzione, entro certi limiti VERA, che questa scuola richieda un grande impegno, il che è vero, per dare in cambio molto poco. Soprattutto come prospettive occupazionali, sappiamo infatti che, a torto od a ragione, è sconsigliabile intraprendere, dopo la maturità classica, università di tipo tecnico o scientifico (quelle che, non essendo sovraffollate, permettono ancora di trovare occupazione dignitosa…), per cui si ci butta nelle solite facoltà iperaffollate ed oramai senza grandi prospettive facoltà generaliste. Rusultato? Tanti giovani, abili e moltio intelligenti, fuori dal mondo del avoro, che non ha bisogno di filosofi o grecisti in gran numero, oppure sotto-occupati nei call center. Queste cose le sanno tutti, ecco perchè madri e padri pensano che il Liceo Classico sia una brutta idea
L disprezzo verso la cultura umanistica non è “spontaneo” ma pilotato da chi vuole distruggere non solo la memoria storica ma la centralità dell’essere umano ai fini della sua più facile manipolazione. I Greci infatti e in misura minore i Latini hanno trasmesso un sapere fondato sulla libertà di ricerca, infatti chi ha studiato al classico è notoriamente più aperto e approfondito anche nella comprensione dei fenomeni conremporanei. Il sistema dell’ignoranza asservito al mercato degli schiavi che non hanno più bisogno di pensare finirà per deprivare di intelligenza e cultura i giovani dato che non è in grado di offrire loro non solo un passato in cui rispecchiarsi ma il futuro.