
Non bisogna avere paura della verità. È ciò di cui tutti hanno più bisogno

Per gentile concessione dell’editore Liberilibri, pubblichiamo ampi stralci del capitolo “Media e cultura: la verità è divisiva?” de L’interminabile ’68 di Giancarlo Cesana, prefazione di Giuliano Ferrara, ora in libreria. I titoletti sono opera redazionale.
***
Quando frequentavo il liceo, cominciai a comprare saltuariamente il giornale; poi, andando all’università, divenne un’abitudine quotidiana: sul tram “diretto” da Carate a Milano delle 7.20, per cinquanta minuti mi isolavo dal mondo circostante per cercare sul quotidiano il mondo “universale”. All’inizio “bevevo” editoriali e commenti; la cronaca mi interessava meno. Poi, con l’ingresso in CL, ho cominciato ad essere ben più critico: spesso, infatti, anche indipendentemente dall’orientamento culturale e politico, i giornali parlavano male di noi e le conseguenze sulla nostra già scarsa popolarità negli ambienti di studio e di lavoro non erano da poco, non solo per l’opinione negativa nei nostri confronti, ma anche per le minacce all’incolumità fisica. Insegnando all’università, ed essendo abbastanza noto come ciellino, nei rapporti con i colleghi e quando facevo lezione, percepivo su di me uno sguardo sospettoso che mi faceva sentire come se dovessi dimostrare di non essere un pericoloso agente dell’Inquisizione – come spesso noi di CL venivamo presentati.
Conoscendo personalmente moltissimi dei miei correligionari, sapevo che quello che la stampa riportava su di noi non era vero. I giornali – e in quel caso avevo la prova provata visto che la cosa mi riguardava direttamente – dicevano il falso per ignoranza, per superficialità, o per mera propaganda: quale che fosse il motivo per me erano inescusabili, perché non trasmettevano notizie, ma amplificavano calunnie senza alcuna verifica.
Adesso la musica su CL è un po’ più dolce. Viene naturale chiedersi se siano cambiati i giornali, oppure se siamo cambiati noi. La risposta è, come succede di solito, entrambi. I pregressi furori ideologici si sono un po’ calmati e, dopo la morte di Giussani, noi siamo stati meno “provocatori”, pubblicamente intervenendo di meno, o in modo più blando. Tuttavia, ciò non ha eliminato la falsità delle considerazioni nei confronti del profilo del nostro movimento, ma l’ha solo attutita, rendendola più accettabile e quindi anche più pervasiva.
Detto questo, sarò un nostalgico, ma rimango assolutamente convinto della centralità dei giornali nel creare informazione e opinione. Restano, nel bene e nel male, un utilissimo specchio del mondo in cui viviamo. Non credo che i giornalisti siano una categoria professionale “malvagia”, come vengono spesso descritti tra grossolani detrattori. Certo, però, non sono di frequente, come amano invece retoricamente dipingersi, un esercito di idealisti dediti alla battaglia in favore della verità, contro la menzogna e il malaffare. Sono soggetti a influenze potenti della politica, dell’economia e anche della pubblica opinione con tutto ciò che questo comporta in termini di generale uniformazione. Subiscono la tentazione degli scribi, che nel Vangelo sono quasi proverbialmente accomunati ai farisei, come difensori dello status quo, di quello che si sa già e deve essere quasi obbligatoriamente riconosciuto.
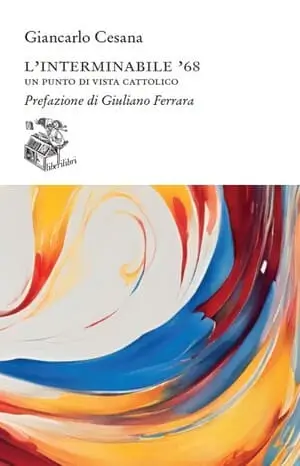
La verità è divisiva?
La verità è diventata problematica. Questa frase icastica potrebbe far sobbalzare sulla sedia, ma tant’è. Qui per verità intendo due principi: sia l’idea che vi sia una Verità ultima delle cose della vita, che per noi credenti è stata rivelata nel cristianesimo; sia l’idea che vi sia una verità oggettiva delle cose del mondo, una realtà effettiva, che non muta in base ai nostri desideri o ai nomi che assegniamo a quel che c’è e succede. Poiché la verità è così problematica, avendo a che fare con il senso della vita e con una sua durezza che non si lascia piegare in base a ciò che vorremmo che fosse, essa diviene qualcosa da accantonare. La verità, paradossalmente, è divenuta un concetto inavvicinabile, roba da fanatici, dogmatici, reazionari. Eppure che cosa dovremmo cercare nella nostra vita se non la verità?
La perdita di fiducia nella possibilità della verità credo stia nel fatto che essa è ritenuta così grande, così complessa, da essere irraggiungibile: chiunque pensi di comunicarla, cioè di averla trovata, farebbe un atto di insopportabile presunzione. «Dio [cioè la verità] se c’è non centra», dice Cornelio Fabro (1911-1995) della mentalità prevalente.
Mi chiedo che cosa questi atei o agnostici pensino del valore di ciò su cui riflettono, parlano o addirittura scrivono, se il concetto di verità viene sostanzialmente accantonato o peggio relativizzato, annacquato, diluito, reso pronto per l’uso in base all’opportunità del momento. Per cosa ci si dà continuamente battaglia nei parlamenti, sui giornali, nei libri, nei talk show politici, e adesso anche sui social media, se non per cercare una qualche forma di verità? Per cosa si muore nelle guerre, che tornano sempre più frequenti a segnare la nostra storia, se non per provare ad affermare una verità, per ricercarla? La verità, oltre a una sua durezza, ha una sua violenza.
La sessualità percepita
Anche i cattolici, ora, pensano che la verità, quella che loro ritengono sia la Verità in quanto rivelata, sia divisiva e che si debba comunicarla con molta prudenza, magari diluendola appunto, perché i molti che non la condividono, o non la capiscono, potrebbero distanziarsene ancora di più, oppure potrebbero fraintenderla. Anzi, alcuni di essi cedono di fatto alla mentalità comune secondo cui debba essere la pura libertà dell’io, senza alcuna interferenza, senza alcuna proposta, senza alcuna educazione, ad arrivare alla verità e a convincersi al riguardo.
Le esitazioni cattoliche a manifestare con decisione quello in cui si crede possono essere giustificate dall’amore per l’altro, che è, in fin dei conti, verità più grande della verità tradizionalmente concepita, con i suoi contenuti dottrinali troppo rigidi a fronte della multiformità culturale ed espressiva del mondo moderno. Per questo si fanno addirittura i sinodi, assemblee attraverso cui in un cammino comune (significato della parola greca sin-odòs) si stabiliscono criteri per andare incontro alle esigenze degli uomini e delle donne di oggi, soprattutto in materia sessuale. Così, per esempio, si dibatte sulla possibilità di benedire le coppie gay, o di valorizzare le istanze della “teoria del gender”, secondo cui la sessualità è percezione soggettiva di sé, a prescindere dall’oggettività della costituzione maschile o femminile. D’altra parte, da quando nelle università e nelle scuole italiane è stata ampiamente riconosciuta la possibilità della “carriera alias” – ovvero la possibilità di essere identificati con un nome maschile o femminile a seconda non dei propri genitali, ma di come ci si percepisce – non si sono udite proteste, o prese di posizione pubblicamente rilevanti da parte di studenti e insegnanti cattolici. Una delle ragioni di tale silenzio è che una persona è più della sua inclinazione sessuale e va dunque amata, o come si suole dire “inclusa”, accolta come tale, perché Dio ama tutti.

La soggettività è tutto
Mi soffermo sulla relazione tra verità e sessualità perché essa è esistenzialmente decisiva. Il sesso, proprio in quanto possibilità di soddisfazione, felicità e generazione, se vissuto in modo superficiale e trasgressivo può dar luogo a esperienze traumatiche, di frustrazione e violenza. Ciò in particolare nei giovani, dato il tumulto emotivo e l’incertezza che segnano il loro sviluppo. Si pensi alla marcia indietro imposta dalla scienza e dalla legislazione sulle richieste di intervento medico o chirurgico per i cambiamenti di sesso nei bambini e negli adolescenti. Si parla tanto di postmodernità come superamento dei modelli chiusi dettati dalle grandi verità della tradizione e come crollo delle evidenze, intese come manifestazioni della realtà così chiare da non dover essere dimostrate. Tuttavia, proprio per queste caratteristiche, le evidenze rimangono anche se possono perdere di significato: ciò che prima valeva, adesso non vale più – o addirittura vale il contrario – non perché scompare, ma perché cambia il giudizio su di esso. Questo è successo esemplarmente nell’ambito della sessualità, in quanto fenomeno non di pochi, ma di massa.
Per quel che concerne la diffusione di tale mentalità nel nostro Paese, vale la pena di ricordare la sentenza n. 221 del 2015, con cui la Corte costituzionale, dando un’interpretazione della legge 164 del 1982, ribadisce che «il trattamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari non costituisce prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione del sesso anagrafico funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico». La soggettività è tutto.
Realtà e ragione
Torniamo a quanto detto sopra circa la verità che è innanzitutto “amore”. L’affermazione non è sbagliata, si rifà al comandamento biblico, e soprattutto cristiano, secondo cui amare il prossimo come se stessi è equivalente ad amare Dio, la Verità. Ci si deve allora chiedere in che cosa consiste l’amore, come amore della verità, in termini soggettivi (amore che io ho per la verità) e oggettivi (amore che proviene dalla verità). La definizione più convincente di verità è per me quella di san Tommaso, «adaequatio rei et intellectus», corrispondenza di ciò che accade (realtà) e ragione (intesa anche come desiderio, o meglio speranza). Corrispondenza non è solo ciò che piace ma ciò che è per te, come la medicina amara per l’ammalato o la correzione per chi sbaglia, da cui la definizione di moralità come amore per la verità più che per se stessi (ciò che piace), perché non possediamo la verità, ma dipendiamo da essa.
Così l’amore per l’altro non è semplicemente un’emozione o una carezza, ma anche un giudizio che impegna a cercare insieme il destino comune, appunto, la verità per cui siamo fatti. Questo giudizio può essere affascinante, ma anche duro «come mordere il sasso». Di certo non è una clava per abbattere l’altro, ma una proposta per la libertà. È un atto di fiducia nella libertà, data da Dio per riconoscere e scegliere la verità, per cercare e comprendere il significato di cose e persone. Non dire all’altro la verità per timore che si allontani è considerarlo in uno stato di inferiorità, ossia incapace di capire quel che lo circonda. D’altra parte, è esperienza comune che si può accogliere ed essere amici con chi non è d’accordo. È anche esperienza comune che la verità può dividere, ma ciò non viene fatto per metterla da parte e sospenderla, bensì per richiamare chi la propone a diventarne più cosciente e chi la rifiuta a essere più aperto e disponibile. C’è sempre una ragione che va riconquistata, magari con tempo, sofferenza e sacrificio, ma lì sta il sale della vita. Non bisogna avere paura della verità. È ciò di cui noi, e tutti, abbiamo più bisogno.

Guerra o pace?
Seconda questione legata a quella precedente: la guerra è inevitabile? Difficile trattare un tema del genere in poche righe, visto che si tratta di un tema eterno, di un tema che fa tutt’uno con l’essere stesso dell’uomo. Tuttavia, è un interrogativo che riguarda direttamente ciò di cui sto parlando. La guerra, infatti, tira in causa la verità, perché si tratta del ricorso alla violenza sistematica e organizzata per affermare le proprie ragioni, uccidendo e rischiando di essere uccisi. Nel ’68 la guerra l’avevamo cancellata dalle nostre prospettive: eravamo tendenzialmente pacifisti a oltranza. Venne il terrorismo e vennero conflitti rilevanti (tra tutti quello del Vietnam) ma distanti, non sentivamo l’orrore e il pericolo della guerra realmente possibile – che era diventata fredda – ma solo le sue ricadute politico-ideologiche.
Denunciando oggi una «guerra mondiale a pezzi», papa Francesco descrive efficacemente l’aspetto più drammatico del nostro presente: una serie numerosa e sanguinosa di conflitti sparsi nel mondo. Solo per citare i principali: in Ucraina; in Israele; in Azerbaigian (dove è stato fatto fuori il Nagorno Karabakh, enclave armena della resistenza cristiana in Medio Oriente); in Africa (dove ci sono almeno una decina di guerre dimenticate da tutti). È difficile, dunque, negare che ci sia una guerra mondiale a pezzi, cioè una tensione diffusa e permanente, il cui carico di morti, feriti, fuggiaschi e rifugiati coinvolge Paesi vicini e lontani. A ciò si aggiunge il grande esodo dei migranti: scappando dalla loro patria, combattono la battaglia per un benessere che – almeno in tempi brevi, dati gli ostacoli posti dalle società affluenti, che si sentono invase e in pericolo – è più immaginario che reale.
Più o meno “cannoneggiate”, tutte le guerre suggeriscono pessime profezie e confermano che il nostro non è un mondo tranquillo, se mai lo è stato. Se dunque – come già profetizzava Giobbe, togliendo ogni illusione irenica – la vita dell’uomo sulla Terra è una guerra, noi cosa possiamo fare? Come reagire? La politica appare impotente, anzi, sembra aizzare lo scontro e la nostra influenza su di essa è, se non insignificante, assai limitata. Possiamo manifestare, sgolarci, scrivere, sostenere chi sta, secondo noi, dalla parte della ragione, ma ciò non smuove chi ha torto e, anzi, sembra rafforzare la sua ostinazione. La guerra è terribile, mette in gioco tutto quel che si è e si ha, non lascia spazio alla considerazione della motivazione altrui e nemmeno agli scrupoli nell’affermare la propria. Ci sono accuse e controaccuse, che costituiscono il pane della propaganda, in cui – senza generalizzare superficialmente – le parti opposte hanno entrambe qualche torto, che sarà definito alla fine da chi vince, a massacro avvenuto. Ciò non è evidentemente giusto, ma sembra inevitabile.
Dov’eri? Dimmelo, se sei intelligente
In questo contesto, apparentemente disperato, in occasione della guerra in Ucraina, il papa ha lanciato la proposta di penitenza e preghiera. Lo stesso ha fatto il cardinale Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, in occasione della guerra tra Hamas e Israele. Lo stesso hanno fatto i papi prima di Francesco di fronte alle guerre del Novecento. Lo stesso ripetono tutti i pastori della Chiesa al popolo provato, che chiede una luce per percorrere una strada quanto mai oscura. Tale proposta, ieri come oggi, convince i semplici, ma fa sorridere i più. Che cosa possono fare penitenza e preghiera a chi è determinato a fare la guerra? Come possono smuovere un Dio che sembra assente, o perché stufo dei guasti prodotti dagli uomini, o perché più semplicemente non c’è? D’altra parte, cosa potrebbe fare lo stesso Dio per fermare la guerra? Paralizzare le mani di chi spara? Fermare con un muro invisibile proiettili e missili prima che arrivino ai destinatari? Influenzare le menti dei cattivi perché diventino buoni, o le anime di tutti perché da guerrafondai diventino pacifisti? Dio dovrebbe togliere la libertà e i suoi effetti, non a questo o a quello, ma a tutti; perché se togliesse la libertà solo a qualcuno, i molti rimanenti potrebbero prevaricare. Di fronte alle guerre e alle distruzioni, la domanda «dove è Dio» non può consistere nell’attribuzione a Lui di responsabilità o colpe che sono di altri o nostre. Il problema, quindi, non è dove sia Dio, ma dove sia l’uomo.
«Quando ponevo le fondamenta della Terra, tu dov’eri? Dimmelo, se sei tanto intelligente!», così si rivolge Dio avvolto nel turbine della tempesta a Giobbe, che nella Bibbia rappresenta l’innocente ingiustamente colpito e che giustamente si lamenta con Dio. Cosa ne sappiamo noi della vita, della morte, di tutto ciò che esiste? Dove possiamo andare a cercare la risposta al male se non in Dio, nel suo Figlio risorto dopo aver dato la vita per noi, soffrendo sulla croce, come e più di quanto possiamo soffrire noi? Si è caricato dei nostri peccati, che sono all’origine della guerra e della morte, per mostrare l’unica forza che può vincerli: l’amore per l’uomo, per tutti gli uomini, anche per i nemici.
Un punto di vista più largo
Penitenza e preghiera, dunque, non per indurre Dio a bloccare magicamente quello che nel mondo non va, ma per cambiare il nostro cuore, così che questo desideri incontrarlo e imparare da Lui. Il primo effetto della preghiera è su noi stessi: con l’assunzione di parole e pensieri solitamente non praticati; e con l’introduzione a un punto di vista infinitamente più largo di quello della mera giustizia retributiva (ho fatto una cosa buona, merito un premio; hai fatto una cosa cattiva, meriti una punizione) in cui rinchiudiamo l’esistenza. Tutto ciò che è nostro, reale e in potenza, ci è stato dato gratuitamente con la vita; anche quello che abbiamo guadagnato con la nostra azione proviene dalla vita e dal mondo che ci sono stati dati.
Con questi sentimenti di gratuità ci si apre all’altro, alla verità dell’altro, alla verità che è l’altro, invece di pretendere di imporre una propria verità soggettiva attraverso una delle tante forme che può prendere la violenza. Nel tempo e senza perdere la speranza, virtù quanto mai necessaria, si possono così anche scorgere i segni di pace che sorprendentemente Dio mette davanti a cuori resi più semplici e decisi. Così da poter dire finalmente con Giobbe: «Io ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno veduto. Perciò mi ricredo e mi pento sopra polvere e cenere». L’umiltà e la consapevolezza dei propri limiti ed errori sono parte integrante, e spesso dimenticata, della verità e della pace.
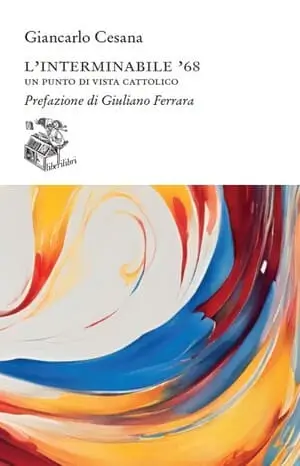
L’interminabile ’68, Giancarlo Cesana, Liberilibri, 120 pagine,
15 euro
* * *
Una versione di questo articolo è pubblicata nel numero di aprile 2025 di Tempi. Il contenuto è riservato agli abbonati: grazie al tuo abbonamento puoi scegliere se sfogliare la versione digitale del mensile o accedere online ai singoli contenuti del numero.



0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!