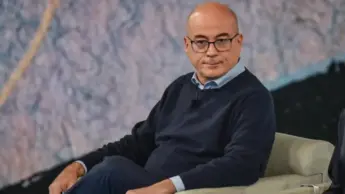

Ascolti la mattina Nathalie Tocci a Omnibus su La7, e capisci subito perché la maggioranza degli italiani continui ad essere contraria all’invio di armi in Ucraina, nonostante si tratti di paese aggredito dalle forze armate russe quasi un anno fa. Il Direttore dell’Istituto Affari Internazionali (Iai) di Roma ha il raro dono di far perdere la pazienza a chi vorrebbe avere dagli esperti un quadro della situazione che permetta di capire se ci sono spiragli per un cessate il fuoco e magari per un negoziato di pace.
Non certo per simpatia verso le posizioni russe (con rare eccezioni): semplicemente, tutti i sondaggi mostrano che l’opinione pubblica non è affatto convinta delle rassicurazioni secondo cui l’escalation militare in corso non sfocerà in una Terza Guerra mondiale o in un conflitto nucleare. Invece la Tocci continua ad argomentare sulla necessità di proseguire la guerra fino alla vittoria ucraina, unica strada per schiacciare definitivamente le velleità egemoniche di Putin. Con argomentazioni che farebbero perdere la pazienza a un santo, figuriamoci a chi santo non lo è nemmeno lontanamente.
La Tocci e il rischio di conflitto nucleare in Ucraina
Lunedì mattina il direttore dello Iai ha cercato di ribaltare l’argomento relativo al rischio di conflitto nucleare. Secondo lei l’unico rischio della situazione attuale consiste nel fatto che se la Russia non viene costretta manu militari a ritirarsi da tutti i territori ucraini, e anzi le si fanno delle concessioni in nome della preoccupazione di evitare una guerra atomica, questo alimenterà la proliferazione nucleare. Cioè qualunque stato con ambizioni espansionistiche si doterà il prima possibile di armi di distruzione di massa, confidando che poi potrà aggredire le sue vittime pressoché impunemente, dal momento che nessuno interverrà in difesa dell’aggredito, per timore di ritorsioni atomiche.
Il “dettaglio” che la Tocci dimentica
La Tocci dimentica un dettaglio da niente, e cioè che molto prima della crisi russo-ucraina (prima anche del suo esordio nel 2014) c’è stato il caso di due paesi che hanno rinunciato ai loro programmi di armamenti non convenzionali, e poco dopo i loro regimi sono stati abbattuti col contributo determinante delle potenze occidentali: i due paesi sono l’Iraq e la Libia, e i due leader che ci hanno rimesso l’osso del collo per essersi fidati degli accordi firmati con noi o con l’Onu si chiamano Saddam Hussein e Muammar Gheddafi. Cattivissimi entrambi, meritevoli entrambi (secondo le loro vittime) di non concludere i loro giorni nel proprio letto.
Sta di fatto che la ragione per cui vari regimi hanno deciso di procurarsi quell’assicurazione sulla vita che sono le armi di distruzione di massa (la Corea del Nord lo ha già fatto, l’Iran sta per arrivarci, probabilmente qualche paese arabo sta brigando dietro le quinte) non è collocata nel futuro di concessioni fatte a Putin perché smetta di bombardare l’Ucraina, ma nel passato di quello che è stato fatto all’Iraq e alla Libia che avevano rinunciato alla proliferazione. Un esperto di geopolitica che dimentica dettagli del genere dà più l’idea di un propagandista della causa atlantista che quella dell’analista rigoroso.
I conflitti che la Tocci dimentica
La Tocci ha avuto anche l’ardire di sostenere che con l’aggressione russa all’Ucraina ci troviamo per la prima volta dopo molto tempo davanti a una guerra condotta da uno stato contro un altro, mentre finora al massimo avevamo avuto stati che si intromettevano nella guerra civile di qualche stato fallito.
A parte che anche il conflitto russo-ucraino potrebbe essere letto in questa ottica (nel Donbass indubbiamente alcuni gruppi locali hanno preso le armi contro il governo centrale), come si fa a dimenticare l’aggressione anglo-americana all’Iraq nel 2003, la seconda guerra del Congo fra il 1998 e il 2003 che coinvolse ben otto stati africani (Repubblica Democratica del Congo, Angola, Zimbabwe, Ciad, Namibia, Ruanda, Burundi, Uganda), la guerra fra Russia e Georgia del 2008 per l’Ossezia del Sud, l’occupazione di varie regioni della Siria settentrionale da parte della Turchia (2016, 2018 e 2019), la guerra fra Azerbaigian e Armenia per il Nagorno Karabakh, appena due anni fa! Ecco, anche in questo caso si ha l’impressione che per aggravare il capo d’accusa contro la Russia di Putin si fa il falò con tutta la legna che si trova in giro, compresa quella fradicia che fa solo fumo.
Da dove nascono i problemi della Russia
L’ultima (almeno nella mia memoria) prodezza argomentativa del direttore dello Iai è stata quella con cui ha ribadito che i problemi della Russia non nascono dalle politiche di altri paesi (che so: un’alleanza militare a guida Stati Uniti che si espande anno dopo anno intorno ai confini russi), ma in una mancata evoluzione interna: «la Russia non ha compiuto il passaggio da stato imperiale a stato nazione, come gli altri stati europei», evento storico-politico che trasformerebbe ipso facto Mosca in un pacifico partner internazionale. Mi spiace, ma questi sono discorsi dilettantistici, nonostante il corposo curriculum della Tocci che si può trovare sul sito dell’Eni e il fatto che la politologa sia consulente dell’Alto rappresentante per la politica estera della Ue Josep Borrell (era già stata consulente di Federica Mogherini, altro Alto rappresentante Ue in quota socialista).
Uno stato erede di un impero
La Russia è uno stato erede di un impero (anzi di due: quello formale zarista e quello informale sovietico) che presenta due caratteristiche peculiari: il suo assetto politico non è liberal-democratico ma piuttosto autocratico e la sua dotazione militare comprende la disponibilità di 5.977 testate nucleari, più un programma per la produzione di armi chimiche e un programma per la produzione di armi batteriologiche dei quali non si conoscono i dati quantitativi. In epoca contemporanea la storia testimonia il passaggio relativamente tranquillo dallo status di stato imperiale a quello di stato nazione per la Francia e per il Regno Unito, che hanno rinunciato non del tutto pacificamente (vedi la guerra d’Algeria per la prima e la rivolta dei mau-mau in Kenya per la seconda) ai loro imperi coloniali.
Si trattava, però, di stati dotati di un sistema politico pienamente liberal-democratico al momento della dissoluzione dell’impero. Quando a decomporsi sono stati imperi scarsamente o per nulla democratici (l’Impero austro-ungarico, l’Impero ottomano, l’Impero tedesco di Guglielmo II), le conseguenze interne e internazionali sono state catastrofiche, con l’avvento dei totalitarismi che sono stati protagonisti della Seconda Guerra mondiale e di genocidi.
Le conseguenze di una “evoluzione” della Russia
La ”evoluzione” dell’autocratica e imperiale Russia putiniana in stato nazione comporterebbe sicuramente conseguenze catastrofiche interne e internazionali analoghe, potenzialmente apocalittiche a causa della presenza di armi di distruzione di massa destinate a cadere nelle mani dei gruppi locali che si impadronirebbero del potere in una Russia disgregata in chissà quanti staterelli. Né si può immaginare un percorso che veda la Russia optare per la liberal-democrazia e poi per la metamorfosi da stato imperiale a stato nazione, magari lasciando andare un’altra mezza dozzina di repubbliche della Federazione Russa, dopo quelle già lasciate andare al tempo della dissoluzione dell’Unione Sovietica.
Per due motivi. Primo, i russi hanno già sperimentato i “benefici” della liberal-democrazia ai tempi della presidenza Eltsin, e ne conservano un ricordo talmente buono che dopo di allora hanno sempre manifestato un consenso maggioritario (persino oggi) per l’autocrate persecutore di dissidenti Putin, l’uomo che ha evitato il collasso della Russia a cavallo fra secondo e terzo millennio.
Secondo: una Russia liberal-democratica sarebbe sicuramente revanscista tanto quanto una Russia sotto dittatura; la libera opinione pubblica eleggerebbe liberamente esponenti di sicura fede nazionalista non meno decisi di Putin a recuperare o conservare influenza sui territori perduti dell’impero. Basta guardare al caso della Serbia col Kosovo e con la Bosnia: a Belgrado non comanda più Milosevic, il sistema politico è di impronta liberal-democratica, il partenariato con la Ue è solido, ma il revanscismo è più vivo che mai.
Bisognerebbe anche parlare degli Stati Uniti…
Dunque, l’equazione per la trasformazione della Russia da stato imperiale aggressivo perché in decadenza a stato nazione con confini e ambizioni più ridotti non l’ha ancora risolta nessuno, meno che mai Nathalie Tocci. Ci sarebbe poi da discutere lo strano caso dello stato nazione liberal-democratico che da tre quarti di secolo esercita non solo funzioni ma anche poteri di impronta imperiale – gli Stati Uniti -, ma dai politologi non si può pretendere un’opinione su tutto, nemmeno se sono consiglieri o consulenti speciali di Eni, Ue, ecc.



0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!