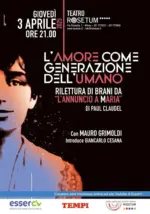
Una mostra per ascoltare la voce di Lagerkvist
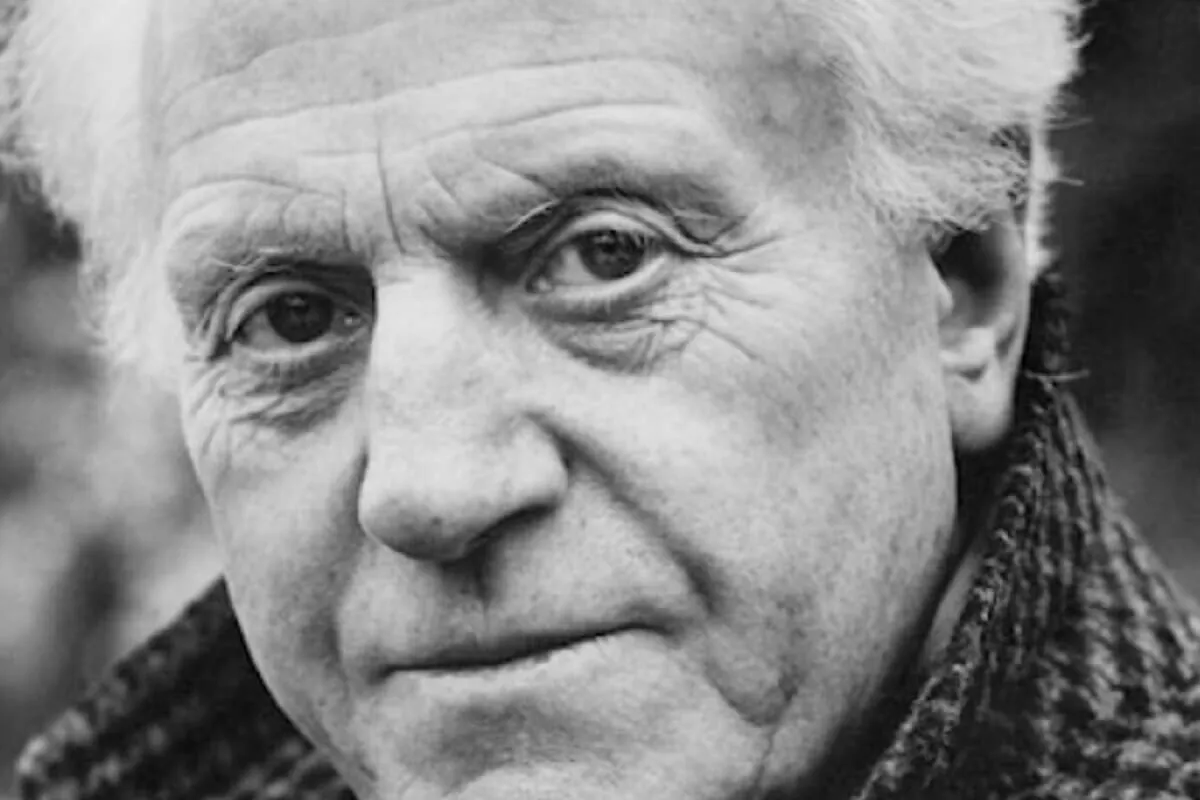
Ricorre nel 2024 il 50esimo anniversario della morte del poeta e romanziere svedese Pär Lagerkvist, insignito del premio Nobel per la Letteratura nel 1951. La ricorrenza corrobora l’urgenza di recuperare la voce di questo autore che mise in parole e versi un confronto molto poco pacifico con l’essenziale che l’edizione del Meeting esplora.
“Se credi in Dio e nessun Dio esiste”, il titolo della mostra dedicata a Lagerkvist mette sul tavolo l’ipotesi di una contraddizione che non è uno sprofondare nel non senso, ma semmai una necessità indomita di domandare quello che più scotta, fa male e insieme innamora. Mistero è una parola troppo delicata per quest’autore, ebbe modo di notare don Giussani che amava e conosceva profondamente l’opera di Lagerkvist. Enigma è già più vicino a suggerire il suo rapporto con un mondo che offre occasioni di contemplazione meravigliata, ma anche di buio pesto.
Ascoltare la voce di Lagerkvist
«L’intento della mostra – ci spiega Michele Colombo che è tra i curatori insieme a Edoardo Barbieri e Simone Pregnolato – è molto consonante con l’idea di letteratura che papa Francesco ha proposto nella lettera sul ruolo della letteratura che è stata pubblicata nel luglio del 2024. Il Papa riprende le parole di Borges invitando ad “ascoltare la voce di qualcuno”. Nel pensare e allestire questa mostra abbiamo voluto far ascoltare la voce di Lagerkvist attraverso i suoi testi, perciò la sezione dedicata ai commenti è ridotta al minimo».
E la voce che investe il visitatore è quella del suo Barabba, protagonista del romanzo che gli meritò il Nobel, e attraverso il cui travaglio umano si ricapitola il senso di parole “essenziali”, a cui sono dedicate altrettante sezioni: incontro, desiderio, solitudine, male, amore, natura, tu. Non c’è da capire né da spiegare, piuttosto da immedesimarsi. Ed è un’esperienza costantemente atrofizzata dall’eccesso di discorsi da cui siamo assediati, mentre la letteratura può essere occasione di risveglio muscolare dell’anima.
«Uno sconosciuto è mio amico»
Fa un po’ tremare, eppure tonifica, essere disponibili a ripartire dalla semioscurità di un condannato come Barabba che mette al fuoco il volto di uno muore per lui, quel Dio che non esiste. Lo incontra? Lo intravede, non lo afferra. Poi lo rifiuta, poi lo desidera. «Gli sembrava di non aver visto mai, prima d’allora, un uomo come quello. Certo ciò avveniva perché egli allora usciva diritto dalla segreta del carcere e i suoi occhi non erano ancora assuefatti alla luce. Perciò, a tutta prima, lo aveva visto come circonfuso di uno splendore abbagliante. Subito dopo, s’intende, quello splendore era svanito e la sua vista era tornata come prima e aveva afferrato tutte le cose e non soltanto quell’uomo che se ne stava solitario nel cortile del Castello».
È una sintesi che vale a raccontare duemila anni di storia e, insieme, ogni nostra normale giornata. A un certo punto capita che la folgorante presenza del volto di Dio ci colpisca, ne riconosciamo qualcosa di abbagliante, poi sparisce dalla superficie delle cose ma non abbandona la scena completamente. «Uno sconosciuto è mio amico», è senz’altro uno dei versi più noti di Lagerkvist tra quelli che hanno imparato a leggerlo attraverso l’entusiasmo di don Giussani. E se la tentazione emotiva ci spinge a calcare la voce – a chiudere in fretta il cerchio – sulla parola «amico», è invece ancora più necessario abitare lo «sconosciuto».
«Nulla è invano»
Lagerkvist abbandonò la fede in età adolescenziale e non la recuperò, eppure è un autore in cui la tematica religiosa è presentissima, nella forma molto scomoda di un dramma continuamente richiamato e irrisolto.
Entrando dalla porta della mostra si abita per un po’ di tempo nel disagio benedetto dello «sconosciuto», di una realtà guardata intera nella bellezza che fa dire «nulla è invano» e che pure è così sconfinata da far precipitare il grido dell’uomo nel vuoto. Se Barabba è la voce protagonista di questo percorso scabroso e a tratti violento, lo affiancano altre voci raccolte dalle altre opere narrative di Lagerkvist e anche dalle sue poesie che sono presenti al Meeting in una nuova traduzione eseguita dai curatori della mostra.
«Sembrava come se l’amore non fosse qualcosa di ovvio»
Originale e inedita è anche la traduzione del discorso-racconto che l’autore lesse in occasione della consegna del Nobel: «C’era una volta» è l’inizio di una breve trama in cui due esseri umani fanno sosta in un pianeta in cui «sembrava come se l’amore non fosse qualcosa di ovvio». C’è da ringraziare chi usa le parole e ne fa storie per cancellare la lavagna del nostre certezze intorpidite. In fondo ogni mattina, svegliandoci, precipitiamo in questo pianeta alieno che è duro da amare, che ci scatena paura e violenza, che custodisce tenerezze infinite e che ci ostiniamo a chiamare casa, in cui preferiamo il bene. Perché?
Quel volto intravisto nell’oscurità chi è? Esiste? Non è nichilismo stare al passo di chi come, Lagerkvist, osa amplificare le contraddizioni che ci attraversano. «All’umanità non piace essere violentata da Dio», afferma il nano dell’omonimo romanzo. Sì, Dio è penetrato fino in fondo nella carne dell’umanità, ma non comincia a fecondare la terra se non quando ogni uomo sceglie di fare un passo di libertà verso di Lui. E questa libertà è ancora più sacra e amabile proprio quando ogni uomo fa i conti fino in fondo con tutto il grumo di male che lo attraversa e lo spinge a rifiutare l’ipotesi di una paternità, e però a continuare a gridare come un orfano.
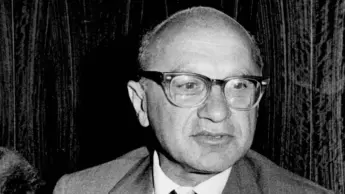


0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!