
Il Deserto dei Tartari
Monsieur Lazhar, lo scandalo della morte
La prima volta che ho visto Monsieur Lazhar è stato settimana scorsa in aereo tornando dalla Nigeria, dove avevo fatto il reportage sulle violenze contro i cristiani. Era la versione originale recitata in francese, con sottotitoli in inglese. Alla fine ho pianto a tutta forza, riparato dal ronzìo dell’aereo, dalle luci spente per il volo notturno, dall’assenza di vicini di poltroncina. Perché anch’io, come nella finzione cinematografica del signor Lazhar e dei ragazzini della scuola di Montreal, ero reduce dall’incontro con una morte ingiusta e assurda. Per i protagonisti della pellicola si tratta rispettivamente dell’assassinio di moglie e figlie in un rogo terroristico ad Algeri e del suicidio della maestra che si è impiccata in classe, per me si trattava delle mamme e dei bambini berom massacrati nottetempo dai nomadi fulani: i superstiti degli attacchi mi avevano mostrato le foto sconvolgenti che avevano preso dentro alle case assalite prima di ricomporre le salme e di inumarle in una fossa comune dopo un necessariamente frettoloso funerale. Ho raccontato questa e altre storie su Tempi che sarà in edicola giovedì.
Ad avermi gettato nell’angoscia non era solo il fatto del delitto, ma le sue modalità e le sue circostanze: un’irruzione nel cuore della notte di uomini armati e furiosi, le luci delle torce contro donne e bambini spaventati, la gragnuola dei colpi senza pietà coi machete e le armi da fuoco, urla e pianti, i lamenti dell’agonia. Il pensiero più insopportabile, quello che più mi perseguitava, era la domanda intorno alle sensazioni vissute dai bambini: la paura deve averli squassati da cima a fondo, l’orrore di vedere padre e madre colpiti a morte sotto i loro occhi, la sensazione di trovarsi alla mercé di mostri spietati, senza via di scampo, il presentimento dei colpi che stavano per arrivare, il proprio corpo attraversato da quegli stessi colpi… si può immaginare una situazione più terribile e più irrimediabile? La morte per loro è arrivata come un sollievo, come la fine di qualcosa peggiore di un incubo, perché somma di sofferenze psichiche e fisiche insieme.
Da inviato sono stato testimone di una quantità schiacciante di sofferenze umane: il genocidio del Ruanda, lo tsunami in Sri Lanka e a Sumatra, i massacri del Darfur, i cristiani iracheni in fuga davanti alla persecuzione, i cristiani in Turchia trucidati, il terremoto di Haiti, l’Aids in Uganda e in Kenya, e ora i cristiani nigeriani colpiti da Boko Haram e da musulmani fulani e hausa. Non ho mai versato lacrime sul posto, mentre vedevo gli orrori o ascoltavo le storie orribili. Tranne una sola volta, quando ho versato una solitaria lacrima notturna per Surur, una ragazza cristiana irachena di 16 anni stuprata e sgozzata dentro casa, nella stanza di fianco a quella dove si trovavano i genitori e un fratello, per essersi ribellata all’imposizione del velo a scuola.
Ma al ritorno dalle missioni, lontano dal teatro operatorio dove come tutti i miei colleghi più bravi di me mi muovo con la lucida freddezza del chirurgo, varie volte ho celebrato i miei lutti con abbondanti lacrime e singhiozzi in volo.
Tornato in Italia sono andato a vedere la versione doppiata in italiano del film, per recuperare tutto quello che mi era sfuggito nella lingua originale. Le tante lezioni che questa bella triste storia ci impartisce. A cominciare da quella principale: per curare le ferite altrui bisogna portare dentro di sé una ferita simile; il modo migliore di curare le nostre ferite è dedicarci alla cura di quelle degli altri; è affermando il bisogno dell’altro che io trovo risposta al mio. Come ha scritto don Luigi Giussani: «Carità vuol dire che nei rapporti la dinamica tende ad affermare l’altro e non se stessi. Perché affermare l’altro è aumentare, crescere».
Questa, che è una verità della vita, assume un aspetto particolare quando la portiamo nell’ambito dell’educazione, nel mondo della scuola, del rapporto fra insegnanti e allievi. Perché mette in crisi quelle che a me sembrano (insegnanti ed educatori, per favore non abbiatevene a male e non malmenatemi con le vostre legittime precisazioni, so bene che nessuno schema esaurisce la ricchezza e la problematicità della realtà) le tre impostazioni sulla carta dominanti: quella progressista che concepisce il rapporto educativo come l’ambito in cui gli studenti sono incoraggiati ad “esprimersi”; quella tradizionalista che concepisce l’educazione in termini di trasmissione del sapere che avviene fra un’autorità che sa e dei discenti che non sanno; e quella tecnocratica, probabilmente oggi prevalente, che rinuncia a qualsiasi ambizione educativa e intende la scuola come il luogo dove si “sviluppano le competenze”.
Nessuna di queste impostazioni ha una risposta convincente di fronte alla vertiginosa domanda: che fare quando un’ingiustizia irrecuperabile come la morte, la morte violenta e improvvisa, viene a visitare la scolaresca? Chiamare lo psicologo, riverniciare le pareti, parlare della cosa solo nei momenti autorizzati non basterà, nemmeno offrire ai ragazzi la possibilità di essere ascoltati quando e come vogliano (il mito della “libertà d’espressione”) basterà. Non può bastare. Perché la guarigione inizia in un rapporto, e un rapporto o lo si suscita, oppure spontaneamente non avviene. Il compito dell’adulto è quello. Ma lo sente suo e lo può assolvere solo se si realizzano due condizioni: che anche lui sia stato lacerato da quella ferita, che anche lui abbia dovuto affrontarla; e che abbia fiducia, per l’esperienza umana di cui è portatore in quanto adulto, nelle risorse con cui ognuno di noi nasce e che la storia della nostra vita aumenta attraverso gli incontri che nel corso dell’esistenza facciamo.
Altro di essenziale non c’è, e questo il film lo sottolinea fortemente: Lazhar non è un vero insegnante, anzi è un bugiardo, è uno che ha mentito alle autorità scolastiche e che ha eretto la reticenza fra i capisaldi del rapporto con i suoi studenti; non confida mai a loro la sua tragedia personale, tanto meno i sotterfugi inventati per occupare la cattedra della defunta Martine. Eppure alla fine è lui che riesce a liberare i cuori, a fare esplodere la rabbia e il pianto di Alice e Simon, a fare accettare ai ragazzi la scandalosa verità sulla quale l’istituzione scolastica voleva fare scendere il tabù: che la morte, soprattutto la morte violenta com’è quella che si manifesta nel suicidio e nell’omicidio, è un’ingiustizia inspiegabile, che un incendio nel bosco può bruciare la crisalide che stava per volare come farfalla nel cielo della vita, e l’albero che la ospitava resterà per sempre testimone ferito di quella perdita. Chi sa comunicare agli altri questa verità, soprattutto chi riesce a farla fare propria alle persone la cui educazione gli è stata affidata, è un adulto compiuto. Chi sa fare questo può anche permettersi di farsi correggere dagli studenti – come fa Lazhar – senza perdere nulla della sua autorità, senza nessuna concessione al progressismo nel senso stantìo e deteriore del termine.
«Ma un credente non dovrebbe avere anche qualcos’altro da dire?», starete pensando voi. Sì, ma non nei termini di una spiegazione, di una giustificazione, di un’esorcizzazione della morte: la morte è scandalo, è ingiustizia inspiegabile nel paragone con la positività del reale e con la bontà di Dio. Il giudizio che va oltre l’elaborazione del lutto e l’accettazione della perdita è semplicemente quello che, di fronte all’immagine dei corpi straziati dei bambini berom, mi ha fatto dire: «Vieni, Signore Gesù. Affretta il Tuo ritorno!».
Articoli correlati
1 commento
I commenti sono chiusi.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!

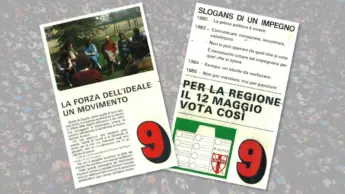

grazie