
Good Bye, Lenin!
Non dite ai parlamentari Pd che il Monopoli nella Germania dell’Est era un gioco che metteva alla berlina il potere
Alzi la mano chi non ha mai giocato a Monopoli, chi non ha mai sperato sadicamente che il fiaschetto o la candela finissero sul nostro Parco della Vittoria… Un gioco «che da generazioni alfabetizza i giovani sui meccanismi del libero mercato», come scrivono i sette deputati del PD autori della lettera all’ambasciatore americano in cui chiedono di fermare la nuova versione del Monopoli «perché inneggia alla finanza irresponsabile», dato che sostituisce case e alberghi con azioni e obbligazioni.
L’iniziativa non stupisce più di tanto: se in Occidente il Monopoli ha «alfabetizzato i giovani», per i paesi del socialismo duro e puro e per i loro fan è sempre stato un gioco sospetto, sconveniente, da vietare. Perciò al cittadino del blocco orientale, privo di giochi di società altrettanto coinvolgenti, non rimaneva che l’imitazione. Prendiamo ad esempio la Germania Est: qui il Monopoli è stato uno dei giochi più imitati e riprodotti in copie «fai da te». Molte di esse sono finite al macero, altre invece sono state salvate e raccolte da appassionati del genere, come Martin Thiele e Richard Geithner che le hanno messe a disposizione di diversi musei. Il loro progetto on-line «Imitazioni – Giochi copiati dalla Germania Est» si è concretizzato anche in un libro uscito di recente.
Nel paese «degli operai, dei contadini e degli scienziati» il Monopoli era una rarità, ne era proibita la fabbricazione e l’importazione, e veniva regolarmente sequestrato o rispedito al mittente se trovato in un «pacco occidentale» (gli invii dai parenti che vivevano in Germania Ovest).
Andreas nell’81 era un soldato che prestava servizio in una caserma centrale dove aveva a disposizione materiali e utensili di ogni tipo per rifare il Monopoli: disegnò la plancia di gioco sul retro di un quadro, mentre le carte degli imprevisti e delle probabilità furono offerte dalla telescrivente dell’esercito… Un altro commilitone, costretto anch’egli alla lunga leva caratterizzata da disciplina, noia e sensazione di assurdità, aveva avuto in regalo un Monopoli vero e proprio dalla morosa ma era stato «beccato» con altri durante un’interminabile partita notturna, così diede libero sfogo alla creatività ricostruendosi il gioco. «Nel ‘77 – racconta un altro – giocai per la prima volta a Monopoli, all’epoca ero un giovane ufficiale e sapevo che non si doveva», tuttavia si appassionò al punto da farsene prestare una copia sotto banco e, provetto fotografo, ricreò il percorso scatto dopo scatto. Più o meno allo stesso modo l’ex-poliziotto Harald se ne era costruito uno utilizzando i materiali fotografici sul gioco conservati negli archivi della polizia. Per ricostruire il tabellone si usavano persino ante di frigorifero o parti delle Trabant, mentre i soldi erano riciclati da altri giochi o stampati con la tecnica degli stampini con le patate; per gli edifici chi adoperava i Lego, chi la plastilina o il legno, e i segnalini erano ricavati anche dai pedoni degli scacchi.
Qualche storico ha fatto notare che la stessa idea di utilizzare oggetti per un uso diverso da quello cui erano destinati, per il regime tedesco-orientale era un potenziale segno di «sovversione». Del resto queste imitazioni non solo ci presentano vicende private, ma danno anche uno spaccato della situazione socio-politica dell’epoca. Come succedeva già per le versioni localizzate del gioco, tanto più in questi casi di «plagio creativo» venivano rimodellati, a seconda della situazione e della creatività personale, l’aspetto esteriore, il contenuto e le regole. Altro che «Viale dei Giardini»: erano le case di via Cranach a Bernburg, dove abitava il creativo di turno, quelle che costavano di più!
Per non parlare della personalizzazione delle probabilità e degli imprevisti: «Hai rubato al supermercato! Paga una multa di 2000 marchi»; «Hai comprato le banane al mercato nero! Paga una multa di 400 marchi»; «La polizia ha riscontrato problemi al tuo veicolo. Vai all’officina e paga 30 marchi», fino a riletture che sfociavano pericolosamente nella politica: «Riceverai un’area fabbricabile solo quando avrai passato una bustarella di 50 marchi al sindaco»; «Imprevisto: Honecker torna al potere»; «Hai raccontato una barzelletta politica: vai per tre anni a lavorare alla Z3», una cementeria dove facevano lavorare i detenuti politici. «Un mio conoscente – racconta Hartmut Göpner, autore della copia in questione – è stato veramente arrestato per aver raccontato una barzelletta su Honecker», come quella del sole ne Le vite degli altri…
J. Peter Lemcke, promotore del Museo dei giochi di Chemnitz, ha affermato che in Germania Est non esistevano passatempi particolarmente complessi o innovativi, mentre una caratteristica del gioco è proprio l’imprevedibilità, il disordine, l’incertezza, che per un sistema dove tutto è controllato e predeterminato rappresentano una minaccia: il gioco insomma mette in discussione il potere, e benché non sia un’«arma controrivoluzionaria» offre pur sempre la possibilità di esercitare critica e irrisione. I tedeschi amano sprofondarsi in riflessioni filosofiche: Quanto può essere sovversivo un gioco dal punto di vista politico? – si sono chiesti in un convegno organizzato l’anno scorso. Conclusione spicciola per gli italiani: in Germania Est è stato sempre come un gioco, quello del gatto (la Stasi) col topo (i cittadini «creativi»).

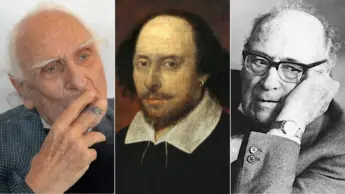

0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!