
Macché allucinazioni, i miracoli sono l’eterno che entra nel tempo

Articolo tratto dal numero di luglio 2020 di Tempi. Questo contenuto è riservato agli abbonati: grazie al tuo abbonamento puoi scegliere se sfogliare la versione digitale del mensile o accedere online ai singoli contenuti del numero.
Forzando i confini, come d’abitudine secolare di noi molokani, dopo aver attraversato catene montuose e pianure verdi e dorate, e osservato facce desolate di anziani e altre innaturalmente esaltate di ragazzi (ma come capisco entrambe le categorie!), mi sono ritrovato a Roma. Spinto da una mano invisibile, eccomi nella piccola basilica di Sant’Andrea delle Fratte, vicino a piazza di Spagna. Qui, come dice la lapide posta sopra il busto di un uomo dalla imponente barba, entrò proprio come me, senza sapere perché, l’«ebreo ostinato» Alphonse Ratisbonne, avvocato di Strasburgo. Gli apparve la Vergine, cadde in ginocchio e «si rialzò cristiano». Anzi cattolico, apostolico, romano. Era il mattino del 20 gennaio 1842.
Com’è possibile che accadano queste cose? Allucinazioni? “Misticismi” pagani? C’era gente inginocchiata, naturalmente con la mascherina, e tutti si ripassavano le mani con il disinfettante, dunque accettando le disposizioni igieniche, presumibilmente basate sulla scienza, e cioè sull’esperienza critica di virologi provetti. E poi però costoro, balzando fuori dal campo dell’igiene e della sanità, baciavano la “medaglia miracolosa” della Vergine, la cui forma e i cui simboli erano stati mostrati nel 1830 a Parigi, in Rue du Bac 140, a una contadina appena fattasi suora di San Vincenzo, (santa) Caterina Labouré.
L’apertura di Jean Guitton
Una ragazza chiedeva con occhi lucidi a Maria «concepita senza peccato» lì presente in effigie, tal quale l’avevano vista la contadina Caterina e l’avvocato ebreo-alsaziano, la guarigione di una persona cara. «Una grazia, un miracolo», mi ha detto. La “medaglia miracolosa” che lei si teneva stretta tra le mani si chiama appunto così, e questo nome non è mai stato rinnegato dai papi. Da quelle mani aperte della “Donna eterna” si dipartono raggi di luce, e i pellegrini li accolgono anch’essi aprendo le mani.
Poi leggo che alcuni sacerdoti cattolici hanno censurato la «tentazione del miracolo». Penso intendessero la tentazione di ritenere Dio e sua madre obbligati a fare miracoli, quasi costretti da una magia.
Eppure io so che queste cose accadono. E uno scienziato, se davvero è devoto alla ragione, è consapevole di sapere pochissimo, e deve piegarsi all’esperienza, accettare ciò che non riesce a imbrigliare con le redini del già saputo. E qui abbiamo due persone, diversissime, colpite da una presenza che non avevano nessuna aspettativa capitasse davanti ai loro occhi e penetrasse il loro cuore.

Ho recuperato, misteriosamente, al punto che posso dire che è stato lui a recuperare me, il libro di Jean Guitton dedicato a questi eventi, e intitolato appunto La medaglia miracolosa al di là della superstizione. Guitton – filosofo, amico profondo di Paolo VI – ricostruisce le due storie di suor Caterina e di Ratisbonne. Ma raccoglie anche quelle di conversioni sorprendenti e improvvise, come quella di san Paolo, e nel secolo scorso di Paul Claudel e di André Frossard. Hanno un carattere comune. L’eterno che entra nel tempo in modo ineffabile, impossibile da descrivere a parole. Entra, ma non come idea, bensì con il corpo trasfigurato di Cristo o di Maria.
La scienza dovrebbe dedicarsi, secondo Guitton, ad essere davvero se stessa, e ad aprirsi a questa possibilità. Non è superstizione. La superstizione è il modo con cui chi non crede chiama il culto o la liturgia dell’altro. La superstizione non è baciare la medaglietta miracolosa, ma trasformarla da segno e mezzo in amuleto e fine in se stessa.
Ciascuno di noi ha devozioni particolari, le quali non vanno ostentate, ma sono il modo con cui la nostra fede entra negli interstizi tra l’anima e il corpo. Sono le devozioni private, le preghiere particolari, le novene, che non sono procedimenti magici dall’esito meccanico, ma il modo umano, carnale, di mendicare. La superstizione semmai è quella di chi adora la propria purezza, che ritiene trascurabili carnevalate le vesti sacerdotali e lo spruzzare acqua benedetta, concentrandosi invece sulla “parola”, il “Libro”, adorato come un feticcio intellettuale a prescindere dalla fisicità di Gesù e della Sacra famiglia. È quello che Guitton chiama «il fariseismo del pubblicano», «il trionfalismo dell’anti-trionfalismo».
Mi sono scoperto a crederci
Mi sono scoperto anch’io a chiedere la grazia della guarigione. Di alcune persone care, di masse brasiliane che non conosco, ma sono gremite di volti. E la guarigione mia, da certe malattie interiori ed esteriori. Non sono appendici un po’ populiste della Rivelazione. In Armenia, vicino al lago Sevan, dov’è il mio villaggio, avevo potuto ascoltare l’omelia di un cardinale, forse Scala o Scola, non ho compreso bene, in cui veniva commentato il capitolo del Vangelo dove Gesù, a Cafarnao, prima guarisce la suocera di Pietro, la quale immediatamente è risanata dalla sua febbre e balza dal letto. E poi, verso sera, dona la salute agli infermi che gli erano stati condotti con la richiesta della salute. Il cardinale sosteneva che Gesù taumaturgo, che opera guarigioni prodigiose, appartiene all’“essenza”, non è una escrescenza, un carattere minore della sua persona, destinato agli spiriti deboli e inclini al magico, qualcosa che la religiosità demitizzata considera uno scarto culturale. Se no non sarebbe rimasto nel Vangelo. Sono segni che dimostrano l’amore di Cristo per gli uomini. Chiedere il miracolo – ho riscoperto – è una cosa bellissima, umanissima, cristiana.


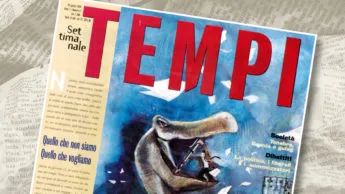
0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!