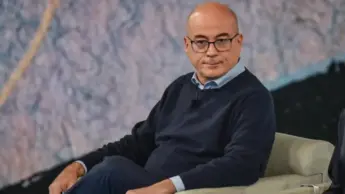
Il Deserto dei Tartari
L’Unione Europea merita il Nobel per la Pace (ma solo per metà)
Anche il meno leghista, il meno britannico, il meno berlusconiano, il meno euroscettico degli osservatori non potrebbe non restare perplesso alla lettura delle motivazioni che hanno spinto ad assegnare all’Unione Europea il premio Nobel per la pace 2012, che oggi è stato consegnato al terzetto costituito dal presidente del Parlamento Europeo Martin Schulz, dal presidente della Comissione José Manuel Durao Barroso e dal presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy.
Le parole “pace” e “riconciliazione” si inseguono e si susseguono nel testo a esprimere il concetto che l’Unione Europea ha reso possibile la pace in Europa dopo secoli di guerre attraverso la riconciliazione dei paesi che erano stati nemici. La crisi odierna, imperniata sull’insostenibilità dei debiti sovrani, è esorcizzata in poche parole: «L’Ue sta affrontando una difficile crisi economica e forti tensioni sociali. Il Comitato per il Nobel vuole concentrarsi su quello che considera il più importante risultato dell’Ue: l’impegno coronato da successo per la pace, la riconciliazione e per la democrazia e i diritti umani».
Che dire? Siamo di fronte a un falso storico. È certamente vero che i padri fondatori di quello che allora si chiamava modestamente Mercato comune europeo (Mec) – Alcide De Gasperi, Konrad Adenaur, Robert Schuman – presero l’iniziativa mossi dal desiderio di liberare l’Europa dalle guerre che puntualmente dal 1871 si erano ripresentate a intervalli sempre più brevi. Ma non c’è il minimo dubbio che né essi, né i loro più modesti successori avrebbero visto coronati da successo i loro sforzi senza la creazione della Nato, il patto politico-militare che dal 1949 lega un elenco crescente di paesi europei agli Stati Uniti e al Canada. Come disse il generale britannico lord Hastings Lionel Ismay, primo segretario generale della Nato, dal punto di vista europeo lo scopo dell’organizzazione era «tenere i russi fuori, gli americani dentro e i tedeschi sotto».
Senza l’ombrello nucleare americano aperto sull’Europa occidentale e mediterranea nel contesto degli obblighi di reciproca difesa Nato, i russi sovietici avrebbero prima o poi mandato i loro carri armati a danneggiare l’asfalto delle ricostruite città europee, o avrebbero suscitato qua e là guerre civili fra comunisti e anticomunisti, o avrebbero costretto col loro ricatto nucleare le capitali europee a “finlandizzarsi” (così, in un tempo non molto lontano, si definiva la benevola neutralità verso Mosca di Helsinki, che nel 1980 giunse al punto di astenersi nel voto di condanna dell’invasione sovietica dell’Afghanistan all’Onu). All’ombra delle atomiche americane la Ue ha potuto condurre il suo esperimento di realizzazione dell’ideale kantiano della pace perpetua e costruirsi la prestigiosa immagine di club delle democrazie, al quale poteva accedere solo chi aveva le carte in regola in materia di libertà politica e di rispetto dei diritti umani fondamentali. Mentre alla Nato i democratici paesi della Ue condividevano il tavolo delle decisioni con il Portogallo della dittatura di Salazar, la Turchia dei regimi militari in successione e la Grecia che non fu certo allontanata durante il regime dei colonnelli (1967-1974).
Anche dopo la fine della Guerra fredda la Nato ha continuato a svolgere un ruolo decisivo nell’integrazione europea e nel suo volto pacifico: senza la contemporanea o antecedente adesione ad essa i paesi ex comunisti dell’Est europeo non avrebbero mai accettato di entrare a far parte di un’entità economicamente e demograficamente dominata dalla Germania unificata come la Ue. Ed è merito o colpa sempre della Nato, e non di un impalpabile soft power idealista europeo, se è stata posta fine alle guerre post-jugoslave del periodo 1991-1999, decidendo di volta in volta chi doveva vincere e chi doveva perdere. Se oggi la Ue può continuare a sfoggiare il suo altissimo profilo morale, condizionando l’accesso degli stati post-jugoslavi alla consegna dei criminali di guerra o presunti tali al tribunale dell’Aja, è sempre e soltanto in ragione del lavoro sporco compiuto a suo tempo dalla Nato.
Dunque, anche prendendo per buone le motivazioni del Comitato di Oslo, il Nobel per la pace dovrebbe essere come minimo diviso a metà fra la Ue e la Nato. Quanto alla motivazione che sottolinea il servizio reso dall’Unione Europea alla diffusione della democrazia come sistema politico, anche in questo caso il premio andrebbe dimezzato: è vero che la Ue ha contribuito all’evoluzione verso la democrazia e lo Stato di diritto ponendo specifiche condizioni ai paesi che facevano domanda di adesione; ma è altrettanto vero che la democrazia è poco praticata per quel che riguarda gli affari interni dell’Unione: ogni volta che un popolo europeo ha respinto tramite referendum un trattato d’integrazione (Francia e Olanda 2005, Irlanda 2008), i governi e le istituzioni europee non hanno fatto altro che redigere un altro trattato, con gli stessi contenuti di quello bocciato, e firmarlo a qualche tempo di distanza dai referendum che lo avevano respinto.
Anche sui diritti umani ci sarebbe da ridire. Uno dei diritti che l’Europa unita intendeva tutelare era ed è il diritto alla differenza. Il nostro continente è ricchissimo di differenze linguistiche, istituzionali (sia a livello locale che nei rapporti fra i territori e il potere centrale), religiose dentro alla comune eredità greco-romana e giudaico-cristiana. Dal 2000 la Ue ha voluto sottolineare questo aspetto introducendo il motto “Unita nella diversità” (poi modificato in “Uniti nella diversità”). Dove le diversità non erano solo quelle linguistiche che rendono inevitabili ricchi capitoli di spesa nel bilancio europeo per le traduzioni incrociate. Ma quelle prodotte dal fatto che la tradizione, il clima culturale e il dibattito nelle diverse civitas portano a decisioni politiche opposte su materie di grande rilevanza per la convivenza. Nell’Unione Europea si trovano i cinque-sei paesi che hanno introdotto il matrimonio fra persone dello stesso sesso a cominciare dall’Olanda nel 2001 ma anche Malta, dove fino all’ottobre dell’anno scorso non era nemmeno ammesso il divorzio; c’è posto per l’Irlanda dove l’aborto è proibito quasi in ogni circostanza e il Regno Unito dove è permesso fino alla 24esima settimana di gravidanza per qualsiasi motivazione; ci sono paesi come la Francia dove la religione è tenuta ai margini della vita pubblica in nome della laicità e paesi come la Grecia dove il governo è chiamato a professare e difendere il cristianesimo ortodosso. Tanta diversità potrebbe essere considerata una ricchezza, nella misura in cui ciascuno può confrontare le sue soluzioni con quelle dei vicini e paragonare conseguenze ed effetti sul tessuto sociale. Tuttavia da alcuni anni la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo (che oltre ai paesi della Ue riunisce quelli del Consiglio d’Europa) sta imponendo con le sue sentenze una visione omologata, fondata sul relativismo morale e tentata da un laicismo radicale. La Corte ha deciso che le legislazioni europee debbano obbligatoriamente fare largo alle pratiche eugenetiche e indebolire la paternità per far prevalere i desideri degli aspiranti genitori contro gli interessi dei figli: ha bocciato infatti leggi che proibivano la selezione degli embrioni nel contesto della fecondazione assistita e leggi che proibivano la donazione eterologa. In primo grado avevano obbligato l’Italia a rimuovere i crocefissi dalle pareti delle scuole, e c’è voluta una sentenza d’appello non unanime della Grande Chambre per ribaltare il verdetto iniziale.
Resta poi il fatto che i più accaniti fautori del processo di integrazione europea oggi non sono, come all’indomani della Seconda Guerra mondiale, i politici di estrazione cristiana, come i tre che abbiamo canonicamente elencato all’inziio del commento. Ma quelli anticristiani, che delle radici giudaico-cristiane del continente non nutrono alcun rispetto. Come si appura nel recente libro Per l’Europa! Manifesto per una rivoluzione unitaria, scritto insieme dal liberale laicista belga Guy Verhofstadt e dal Verde tedesco Daniel Cohn-Bendit. Sulla questione se gli europei siano legati dal cristianesimo il primo risponde: «Per niente. I bosniaci e gli albanesi sono europei e non sono cristiani. (…) Gli ottomani, che hanno occupato i Balcani per quattrocentocinquant’anni, hanno giocato un ruolo fondamentale nella nostra cultura». E il secondo concede poco di più: «È evidente che la religione cristiana gioca un ruolo nella storia eureopea. Ma, in parallelo, la lotta contro l’influenza della religione, la separazione fra Chiesa e Stato, o almeno della sfera privata e pubblica». La “lotta contro l’influenza della religione”: un’espressione da lezione di ateismo scientifico in una scuola sovietica. È per un’integrazione che si compiace di idee come questa che l’Europa merita il Nobel? E che noialtri dobbiamo fare sacrifici?



0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!