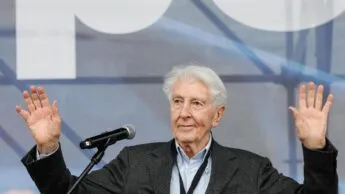
L’invisibile che ci ha messi al tappeto e la domanda che dobbiamo porci

Articolo tratto dal numero di aprile 2020 di Tempi. Questo contenuto è riservato agli abbonati: grazie al tuo abbonamento puoi scegliere se sfogliare la versione digitale del mensile o accedere online ai singoli contenuti del numero.
Difficile per un medico, igienista e universitario per giunta, non parlare della pandemia. Ancora più difficile se si ha a disposizione una rubrica su un giornale. D’altra parte, i contagi sembrano diminuire di intensità, ma le parole dette e scritte aumentano. E ancora di più aumenteranno perché la paura, comunque sempre incombente, ha necessità di essere contenuta, spiegata e possibilmente vinta. Così abbondano le prediche, i proclami, le lamentazioni, le rivendicazioni e le proposte di soluzione, molto poche per la verità. Per fortuna non si sente molto “io l’avevo detto”, ma temo che anche questo non ci verrà risparmiato.
I primi predicatori, di gran lunga i più invadenti e continui, sono i giornalisti, quelli che scrivono e soprattutto quelli che parlano. Presenza praticamente h24, su tutto e il contrario di tutto: se leggi il giornale, in una pagina puoi trovare la celebrazione dell’Italia, delle prodezze del suo governo e dei suoi tecnici, in un’altra, le critiche alle incertezze, all’impreparazione alla superficialità di politici e amministratori. Naturalmente il giornale, soprattutto se è grande, apparentemente non si schiera, lascia al lettore di decidere in mezzo alla confusione che esso stesso induce. Dietro le cronache e i commenti c’è l’opzione politica, che, per quanto fantasmatica, sempre spinge da una parte o dall’altra.
Dopo i giornalisti, vengono gli scienziati, le cui prediche per la verità sono indotte dai giornalisti stessi, che cercano conforto o spunto tecnico per le loro tesi. Gli scienziati non si fanno desiderare, sono pronti e si lanciano in spiegazioni, interpretazioni e previsioni sulla base di numeri, che quando non sono quelli ufficiali, sono semplicemente ipotetici. I loro interventi si fondano spesso sulla presunzione che “ci salverà la scienza”, l’oggetto di fede più diffuso in questa società che fa così fatica a credere in Dio. Viene in mente Chesterton, quando diceva che gli atei non sono quelli che non credono in niente, ma quelli che credono in tutto.
In effetti, se c’è un’evidenza della epidemia in corso è che la scienza ha dimostrato di sapere tante cose dei virus, ma poche e non centrali di questo virus. La raccomandazione fondamentale su cui tutti gli esperti si sono attestati è “state a casa”, più o meno la stessa degli Uffici di Sanità medioevali. Scopriranno vaccini e terapie, ma in un futuro che non farà rivivere i morti attuali e che sarà messo alla prova da un nuovo virus.
E qui intervengono i leader e gli intellettuali religiosi, preti o laici che siano. I primi, dopo un momento di sbigottimento, dovuto alla chiusura di chiese e funzioni, si stanno attrezzando con liturgie e sermoni televisivi o via internet. Uno ha celebrato Messa su un tetto con i fedeli sui balconi dei caseggiati circostanti. I preti fanno bene, perché noi fedeli abbiamo bisogno che venga sostenuta la speranza e per questo siamo disposti a pagare il prezzo di discorsi a volte un po’ ridondanti.
Gli intellettuali cattolici sono stati in genere alquanto discreti: hanno reclamato l’intervento dei loro pastori e hanno denunciato le presunzioni e le insufficienze della modernità, o post-modernità. A proposito di tali insufficienze c’è tuttavia un gruppo terribile, che indica in quello che sta succedendo la punizione di Dio per tutti i misfatti che “gli altri” fanno. È possibile che Dio sia un po’ stufo degli uomini, ma dobbiamo pregare che sia Lui alla fine a giudicarci e non quelli che si pretendono suoi interpreti.
Uscirne non sarà facile
I proclami sono il modo in cui siamo oggi governati con l’occhio competitivo a chi proclama più forte. I Dpcm, o decreti della presidenza del Consiglio dei ministri, vengono emessi in genere a fine settimana, anche nelle ore più impensate della notte, magari per il giorno dopo. Data la pressione con cui vengono formulati, presentano passaggi non sempre chiari, se non all’interno di un indirizzo generale di cessazione delle attività e di punizione per chi non ubbidisce. Non hanno forza di legge – non sono votati dal Parlamento e la loro legittimità costituzionale viene messa in discussione – sono atti amministrativi per dare attuazione a norme o varare regolamenti. Si impongono per la situazione obiettivamente drammatica, che ha la sua immagine emblematica nella colonna di camion impiegati a Bergamo per trasportare il gran numero di bare. Dal punto di vista dei contenuti, non hanno purtroppo prospettiva costruttiva se non quella di fermare a tutti costi il contagio.
Di fronte al vuoto di futuro e alle incertezze del presente nello sforzo di sostenere la vita civile, la sua economia e i suoi servizi, soprattutto quelli sanitari, sull’orlo dell’esaurimento, c’è un sobollimento, come il gorgoglio della pancia di un vulcano che potrebbe esplodere da un momento all’altro.
Medici e infermieri hanno molto lavoro da fare – sono i nostri “eroi” – e non hanno tempo per lamentarsi e recriminare. Tuttavia i loro rappresentanti di categoria, corporazione o sindacato, hanno molto meno da fare e si sentono in dovere, appunto, di rappresentare le disfunzioni, le rivendicazioni e soluzioni alternative a quelle in corso. C’è online un Quotidiano Sanità, molto letto per informazione dagli addetti ai lavori (tra cui anch’io), pieno di dichiarazioni, denunce e prese di posizioni più o meno ultimative.
Come accennavo sopra, le proposte concrete e possibili di soluzione sono poche. In genere si chiede qualcosa di più – mascherine, ventilatori, letti, soldi – ma con quali mezzi e in quali modi non è chiaro. Il problema dei vaccini e delle terapie, cui si sta lavorando in tutto il mondo, è per noi minore di quello organizzativo. Abbiamo un sistema sanitario sottofinanziato, diseguale nelle diverse regioni, in un paese in grave difficoltà economica.
Certamente in futuro ci ritroveremo davanti a emergenze simili all’attuale – è la terza epidemia da coronavirus in quindici anni – che non perdoneranno l’impreparazione. Man mano che l’epidemia si attenuerà insorgerà il dibattito, che potrà essere furioso, sulle mancanze sanitarie e quelle soggiacenti politiche. Uscirne non sarà facile.
A questo punto, dato il mio ruolo reiterato di Cassandra quando parlo della società italiana, mi si può chiedere o rimproverare: “Tu che critichi tanto e tutti che cosa dici di alternativo?”.
Non ho tale presunzione. Innanzitutto dico che anch’io mi sono trovato in mezzo a una situazione inaspettata, che mi ha costretto a imparare, nonostante la competenza in cose sanitarie.
In secondo luogo devo riconoscere che tutti quelli che ho criticato hanno le loro ragioni e tanto più ne hanno quanta più responsabilità si sono assunti.
La risposta “deve” esserci
Se tutti o tanti hanno le loro ragioni, magari l’una contro l’altra armata, bisogna cercare una ragione sostanziale che le unifichi determinando un atteggiamento non di belligeranza, ma di collaborazione. Questa ragione sta nel rendersi conto che non siamo potenti o, peggio ancora, onnipotenti.
Possiamo fare molte cose, molte più che in passato, ma un organismo invisibile può metterci al tappeto, come se fossimo più piccoli di lui. C’è un destino, di cui non siamo padroni e che ultimamente ci vince.
Se siamo piccoli, l’atteggiamento giusto da avere non è la pretesa, ma la domanda, o se si vuole, dato il tema, la ricerca della risposta alla vita e al suo senso biologico ed esistenziale. Certo per trovare una risposta bisogna ipotizzare e credere che la risposta che c’è; nessun ricercatore si metterebbe a cercare qualcosa che non c’è, anche se invisibile “deve” esserci. E come sanno tutti i ricercatori le risposte vengono dalle domande giuste.
La nostra domanda giusta deve essere di collaborazione e unità, nel nostro popolo – si propone un governo di unità nazionale e potrebbe essere un’idea – e tra i popoli, innanzitutto quelli dell’Europa. Non siamo in grado di affrontare il nostro futuro da soli. Abbiamo troppa zavorra che ci pesa; le pretese di autosufficienza sono ridicole e ci hanno portato al declino attuale.
Il passato non ritorna, ma le sue lezioni sono utili. Dopo la distruzione della Seconda guerra mondiale, la fede e la lungimiranza di statisti, per lo più cattolici, ha dato vita a quella che è ancora inadeguatamente realizzata come Unione Europea. Magari la tragedia che stiamo vivendo in questi giorni può essere l’occasione, se non per compiere, per migliorare l’opera.
Foto Ansa



0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!