
L’impressionismo, o della peggior cantonata della critica militante
Era esattamente il 15 aprile del 1874. A Parigi, boulevard des Capucines è deserto. Verso le dieci soltanto pare si muova qualcosa. Al numero 35 sorge una struttura in metallo e vetro, molto moderna nelle fredde linee verticali che incorniciano la facciata. Qui campeggia la scritta “Nadar”, pseudonimo di Gàspard-Felix Tournachon, pioniere della nuova arte della fotografia. Una piccola schiera di curiosi è accalcata davanti alla porta d’ingresso. All’esterno, un banchetto vende, per cinquanta centesimi, un sottile catalogo. Il prezzo d’ingresso è un franco. Solo pochi dei visitatori, arrivati all’inaugurazione della Prima mostra degli Impressionisti, rimarrà soddisfatto delle 163 opere esposte. Nessuno prevede che questa data segnerà uno spartiacque con l’arte precedente, e definirà l’inizio della pittura moderna e contemporanea.
Centotrentotto anni fa la pittura impressionista si esponeva al pubblico ludribio di un pubblico colto, raffinato e parecchio snob. L’aristocrazia artistica della capitale francese aveva come perno i salon, che ispiravano la propria poetica attorno a un certo neoclassicismo di maniera, ai pensieri – un po’ retro – dell’esteta Johann Joachim Winckelmann. Le proposte della Societè anonyme des artistes, peintres, sculpteurs, graveurs erano, invece, talmente attuali da anticipare il gusto e le convenzioni sociali. Una rivoluzione annunciata già dalla letteratura francese decadente di Charles Baudelaire e Arthur Rimbaud, entrambi amanti dell’arte. Quest’ultimo pare prevedere l’immediato stravolgimento che colpirà la pittura figurativa, augurandosi la completa evoluzione verso mete altre, sconosciute, irrappresentabili: «Noi strapperemo la pittura alla sua vecchia abitudine di ricopiare e le conferiremo sovranità. Il mondo materiale non sarà nient’altro che un mezzo per evocare impressioni estetiche. I pittori non replicheranno più oggetti».
[internal_gallery gid=26990]
Fra gli espositori vi erano nomi completamente nuovi al panorama parigino. Altri, invece, avevano già fatto sparute apparizioni nei salon accademici, piegando il capo alla moda del momento e accettando di bloccare il polso ogni volta che il pennello voleva uscire dai contorni della rappresentazione fredda e delicatamente patetica. C’erano Felix Braquemond, Jean-Baptiste Guillaumin, Berthe Morisot, Claude Monet, Edgar Degas, Paul Cezanne, Camille Pissarro, Pierre August Renoir, Alfred Sisley e altri. Tutti uniti, seppur con poetiche personali non sempre sovrapponibili, nel tentativo di rappresentare gli oggetti senza l’ausilio delle linee ma solo attraverso tocchi di colore, spesso non trattato e forte, pennellate brevi e veloci, giochi di sfumature che non prevedono l’uso del nero, ma variazioni di colore. Si vuole catturare – en plein air – l’impressione luministica dell’attimo della rappresentazione. Cosa che avvicina l’impressionismo – ben più d’un astratto e ideale neoclassicismo – alla rappresentazione realistica del mondo.
I critici storsero il naso, e inchiostrarono le pagine delle rubriche di considerazioni crudeli verso quel gruppo di artisti. Tra tutti, forse quello che ebbe più voce in capitolo fu Léon Bonnat, grande amico – fino a quel momento – di Degas. Autore di scene di genere e ritratti, vincitore del Prix de Rome del 1857 con una Resurrezione di Lazzaro, il pittore cercava ardentemente di entrare nelle grazie dell’Academié des Beaux-Arts di Parigi, e non esitò a farsi promotore di una crociata contro i pittori border-line dell’impressionismo. L’iniziativa gli fece guadagnare una cattedra, salvo poi dedicarsi anch’egli, in vecchiaia, a uno stile più rapido, con maggior trasporto: impressionista, insomma. Ma era il 1920 e la corrente della Societè anonyme si era già spenta, lasciando un lascito fecondo nel pointillisme di Georges Seurat e nel divisionismo di Giovanni Segantini, nel fauvismo (e nel suo ultimo, grande estimatore, Henri Matisse), fino a raggiungere il cubismo di Picasso – mediato dall’opera di Paul Cezanne. Di fatto, l’impressionismo ha anticipato persino le grandi cantonate storiche della critica militante.
@DanieleCiacci

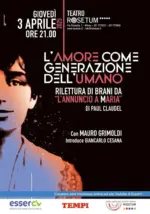
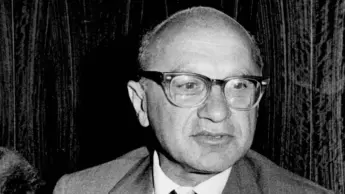
0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!