
Lezioni di sopravvivenza per dhimmi


Articolo tratto dal numero di Tempi in edicola (vai alla pagina degli abbonamenti)
Quest’estate non dimenticate di leggere La storia perduta del cristianesimo di Philip Jenkins. Scoprirete una quantità di fatti storici sorprendenti intorno al cristianesimo dell’Oriente, dagli splendori delle origini al crepuscolo dei giorni nostri passando attraverso terribili persecuzioni di cui quella dell’Isis è solo l’ultimo atto. E avrete abbondante materiale per fare comparazioni con la situazione odierna del cristianesimo e le sue prospettive. A partire da scomode verità storiche, come quella che le religioni si radicano e si espandono solo se il potere politico le sostiene, e viceversa prima o poi scompaiono se il potere si identifica con una religione diversa.
O come quella che le conversioni da una religione a un’altra sono avvenute non a motivo delle virtù misericordiose degli evangelizzatori, ma a causa di miracoli o per opportunismo. O come quella che i musulmani non sono stati affatto i più intolleranti credenti e governanti della storia, ma semplicemente hanno fatto quello che tutti i credenti, quando hanno il potere, fanno; pian pianino, un po’ con le buone e un po’ con le cattive, si sono presi tutto quello che apparteneva alla religione sottomessa: i suoi fedeli, i suoi templi, la sua eredità.
Il bello è che nessuno può attaccare Jenkins, accademico della Baylor University (Texas), con insinuazioni ideologiche: è un ex cattolico, scrive su The Christian Century, rivista di protestanti liberal, è antiputiniano, è un fautore della teologia pluralista, quella cioè che pensa che le religioni sono allo stesso tempo tutte vere e tutte false, che è un peccato quando scompare una religione, non importa quale, perché il mondo spirituale diventa più povero. Non ha pregiudizi sull’islam e sui musulmani, le cui sacre scritture lui dice contengono meno appelli alla violenza sacra di quanti ne contenga l’Antico Testamento. Auspica che i cristiani possano «un giorno accettare che l’islam svolga un ruolo positivo, e che la sua crescita nella storia rappresenti un’altra forma di rivelazione divina che integra, ma non sostituisce, il messaggio cristiano».
Ma Jenkins è anche uno studioso rigoroso, onesto e schietto, e non nasconde mai i fatti storici che potrebbero imbarazzare liberal e cristiani modernisti. Prima però cominciamo coi “forse non tutti sanno che…”. La maggioranza degli europei crede che, col trionfo politico-militare dell’islam nel Vicino Oriente e Nordafrica nella seconda metà del VII secolo, il cristianesimo sia collassato in Asia e in Africa e sia diventato una cosa prettamente europea. Sbagliato: all’indomani dell’anno Mille, quando i califfi regnavano già da tre secoli, un terzo di tutti i cristiani del mondo viveva in Asia e un altro dieci per cento in Africa (Egitto, Nubia ed Etiopia). In Europa vivevano 30 milioni di cristiani, in Oriente fra i 17 e i 20 milioni, in Africa 5. Centinaia di diocesi con vescovi, metropoliti e patriarchi si stendevano lungo 3.500 chilometri fra Alessandria e Samarcanda.
Molti credono che l’evangelizzazione dell’Estremo Oriente sia stata tentata da gesuiti, francescani e saveriani fra il XIII e il XVI secolo. Errore: fra il VI e il XIII secolo nestoriani e giacobiti (cristiani monofisiti mesopotamici e siriani) hanno inviato missioni, tradotto il Vangelo nella lingua locale e creato diocesi in Persia, Afghanistan, India, Cina, Tibet, Uzbekistan, Turkmenistan e altrove.
Le radici “nazarene” dell’islam
Gli europei cristiani ferventi ripetono stentorei, con le parole di Tertulliano, «il sangue dei martiri è il seme dei cristiani». Jenkins fa cinicamente notare che nelle terre dove visse Tertulliano, a cavallo fra le attuali Tunisia e Algeria, i cristiani sono scomparsi completamente in meno di due secoli: «Nel VI secolo, circa 500 vescovi operavano in quella regione; nell’VIII secolo, non ce n’era neanche uno». Gli europei progressisti si piccano di contrapporre la tolleranza islamica nella Spagna dominata dagli arabi all’intolleranza dei regni cristiani successivi che deportarono musulmani ed ebrei. Jenkins ridimensiona gli ardori politicamente corretti: «Quando la Reconquista cominciò sul serio, le autorità musulmane avviarono deportazioni di massa di cristiani ed ebrei. Anche se in seguito la Spagna divenne famosa per l’espulsione delle minoranze religiose, il suo regime non fece nulla di diverso da quello che i suoi predecessori moreschi avevano fatto secoli prima».
Altra grande sorpresa del libro è la descrizione dell’islam come nuova religione imitazione del cristianesimo. Alcuni dei tratti più caratteristici dell’islam sarebbero in realtà elementi importati dal cristianesimo orientale: «La forma delle moschee deriva da quella delle chiese cristiane orientali nei primi tempi dell’islam. Allo stesso modo, la maggior parte delle pratiche religiose dei musulmani all’interno delle moschee deriva dall’esempio dei cristiani d’Oriente, comprese le prostrazioni, che sembrano così strane agli occidentali moderni. Il rigore del Ramadan si basava originariamente sulla pratica orientale della Quaresima. Il Corano presenta spesso analogie sorprendenti con gli scritti, i testi devozionali e gli inni cristiani orientali, e alcuni studiosi hanno sostenuto addirittura che la maggior parte del testo tragga origine da lezionari siriaci, o collezioni di letture per uso ecclesiastico. (…) Dopo la morte, gli adepti sufi continuano ad attirare devoti alle loro tombe, in modo che i venerati sceicchi svolgono per i musulmani esattamente lo stesso ruolo che i santi cristiani svolgevano nell’epoca precedente».
Il cuore del libro è la drammatica vicenda delle Chiese orientali, non meno ricche di spiritualità, vita monastica e spirito missionario di quelle cattoliche e ortodosse, anzi in molti casi superiori. Sfortuna però ha voluto che non riuscissero a convertire se non temporaneamente re e governanti dei popoli che cercavano di evangelizzare, che si siano imbattute in antiche e nuove religioni molto organizzate (buddhismo e islam), che si siano ritrovate in balìa di sovrani e maggioranze di popolazione di religione diversa.
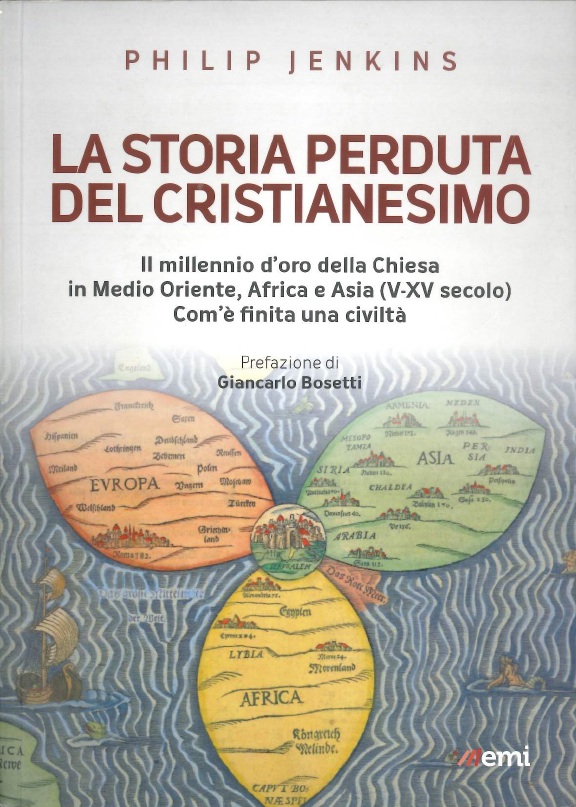 Fine di una presenza pubblica
Fine di una presenza pubblica
Schematicamente: all’inizio i musulmani non impongono conversioni forzate, ma presto iniziano le discriminazioni e pressioni sociali per spingere i cristiani alla conversione; vengono trattati come dhimmi secondo il Corano: devono pagare una tassa e subire pubblica umiliazione in cambio della protezione da parte dello Stato musulmano. Si lasciano costruire nuove chiese, anche se la dhimmitudine non lo permetterebbe, ma si verificano sommosse popolari dei musulmani contro i cristiani che le autorità reprimono a fatica. I musulmani ci mettono due-tre secoli a diventare maggioranza nelle terre conquistate. Attorno al 1300 le cose per i cristiani precipitano: nel 1258 i mongoli invadono Mesopotamia, Siria e Asia minore e uccidono milioni di persone. Le Crociate dei due secoli precedenti al confronto sono punture di vespa. Alcuni loro capi sono cristiani, e per un breve momento i cristiani locali sognano un ribaltamento del rapporto coi musulmani. Il sogno dura poco perché la maggior parte dei mongoli si fa musulmana e incomincia a perseguitare furiosamente i cristiani.
I mongoli non arrivano in Egitto, ma i mamelucchi scatenano la persecuzione contro i cristiani temendo che si schiereranno con gli invasori. Distruggono pure i regni cristiani di Armenia e Georgia. Per il profilo pubblico del cristianesimo è la fine: «I dhimmi furono licenziati da qualsiasi incarico pubblico e costretti a indossare indumenti particolari per distinguersi: turbanti blu per i cristiani, gialli per gli ebrei. Gli effetti di tale crisi perdurano fino ai giorni nostri, perché il rigoroso legalismo islamico che emerse intorno al 1300 ha plasmato gran parte dei moderni movimenti fondamentalisti. Dagli anni Novanta del XIII secolo i giuristi musulmani produssero interpretazioni sempre più dure delle leggi che governano le minoranze. (…) Intorno alla metà del secolo gli scrittori musulmani disponevano di un intero catalogo di accuse contro i cristiani, che assomigliava moltissimo ai vergognosi pamphlet antiebraici del primo Novecento come i Protocolli dei Savi di Sion».
Sotto l’Impero ottomano i cristiani d’Oriente si assestano, ma con l’avvento del XX secolo le cose precipitano di nuovo, per ragioni simili ai fatti del 1300: sospettando che i cristiani diventeranno le quinte colonne delle potenze europee, i turchi organizzano lo sterminio degli armeni e degli assiri, e la cacciata dei greci dall’Anatolia. In un secolo i cristiani scendono dall’11 al 3 per cento del totale della popolazione del Medio Oriente. E si arriva ai giorni nostri.
Alla fine di tutta questa storia Jenkins, che pure non è per nulla un simpatizzante dell’alleanza fra trono e altare, spiega chiaramente che a fare la differenza fra il destino delle Chiese d’Occidente e quello delle Chiese d’Oriente sono state le vicende militari e politiche. «I cristiani possono deplorare la persistenza di legami fra gli stati e le chiese, ma senza tali alleanze oggi forse non ci sarebbero più cristiani in grado di lamentarsi. Se non ci fossero stati quei legami, il cristianesimo forse non sarebbe niente di più che una nota a piè di pagina nei manuali di storia islamici o cinesi, come il manicheismo». «Nel corso del tempo, il fatto che una data religione detenesse il potere in uno stato le garantiva maggiori probabilità di essere sempre più maggioritaria. Così la posizione dominante diventava sempre più dominante». È quello che i musulmani hanno fatto in Oriente, mentre i cristiani lo facevano in Europa: «A prescindere dal tema della violenza e della costrizione, i regimi musulmani attraverso i secoli sono riusciti benissimo a creare società e culture che esercitavano una pressione schiacciante verso il conformismo religioso, stabilendo la fede di Muhammad come religione naturalmente priva di alternative, tale da permeare tutta la cultura. La piena appartenenza alla società era possibile solo ai musulmani, mentre tutti gli altri sostenevano oneri di varia intensità». Se gli arabi fossero riusciti a occupare l’Europa, Jenkins non ha dubbi: «Con ogni probabilità il cristianesimo avrebbe dovuto affrontare un triste futuro».
La conversione del re
I copti, però, dimostrano che si può resistere per tredici secoli in ambiente ostile, anche se il prezzo è scendere dal 100 al 10 per cento della popolazione. Non per merito delle qualità morali e della bellezza della vita cristiana di cui si dà testimonianza: spiega Jenkins che le conversioni al cristianesimo nell’antichità nascevano da miracoli e guarigioni di re da parte di monaci. Un re attribuiva un fatto miracoloso al cristianesimo, si convertiva e sulla sua scia tutto il popolo si faceva battezzare. Fra i cristiani generici sorgevano nel tempo esperienze individuali o monastiche di profonda fede e santità, ma queste erano esposte alla estinzione come la fede superficiale delle masse: vedi l’Africa di Agostino e Tertulliano. Perché l’Egitto cristiano ha resistito mentre lo splendido cristianesimo africano si è estinto? Perché il secondo era fatto solo di coloni romani urbanizzati che sono fuggiti all’arrivo degli invasori, mentre il primo aveva tradotto in lingua locale libri sacri e liturgia e aveva evangelizzato anche le campagne: «Le Chiese hanno successo quando raccolgono fedeli da tutti i settori della società e rendono la loro religione parte della normale vita vissuta di una vasta gamma di comunità. Se un individuo può accettare, sotto costrizione, di cambiare un’etichetta religiosa un po’ consunta, è molto improbabile che tale mutamento si verifichi quando la fedeltà religiosa è intimamente legata alle tradizioni e alla visione del mondo della comunità più ampia».
Foto Ansa
Articoli correlati
1 commento
I commenti sono chiusi.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!



Mi dispiace, ma non ci riusciranno: dovranno ammazzarmi, perché io non sarò mai schiavo, né dei radical né degli islamici. E con me tanti altri, perché liberi in Cristo.