
Memoria popolare
Le tesi per il Movimento Popolare
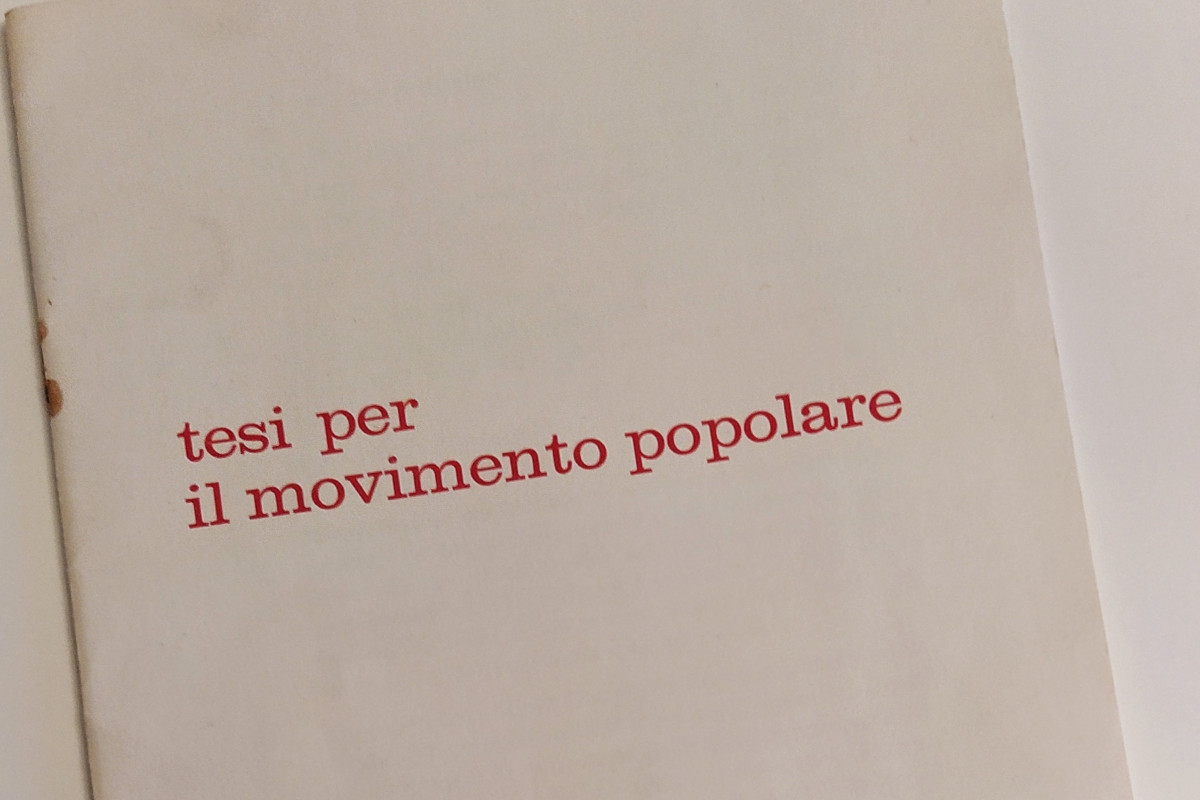
Il 21 dicembre 1975 nasceva ufficialmente a Milano il Movimento Popolare, con l’obiettivo di rinverdire la tradizione di impegno nella società a partire dall’identità cristiana che era stata caratteristica di quell’insieme di iniziative e associazioni appoggiate dalla Chiesa, note col nome collettivo di Movimento Cattolico, nell’Italia post-unitaria a cavallo fra il XIX e il XX secolo. In quell’occasione veniva diffuso un opuscolo di 24 pagine dal titolo (tutto in lettere minuscole) tesi per il movimento popolare. Nella seconda di copertina si precisava: «Non si tratta di un documento esaustivo, ma soltanto indicativo, quale è richiesto dalla natura di un movimento aperto che intende crescere e darsi forma mediante i contributi di teoria e di azione di tutti coloro che liberamente decideranno di aderirvi». In realtà si tratta di un’analisi della realtà politica e del clima culturale dominante in Italia negli anni Settanta, accompagnata dalla proposta di un impegno unitario del mondo cattolico a tutti i livelli della società in un’ottica democratica e popolare. Le “tesi” sono articolate in 8 punti e una conclusione.
Un volto preciso
Al punto 1 viene richiamato “un fatto nuovo”, e cioè che nel 1975
«si è potuto constatare nella base popolare del nostro paese una larga volontà di ritrovare la propria identità cristiana. Molti cattolici hanno mostrato il desiderio e la capacità di partecipare alla costruzione della società con un volto preciso […]. Segni visibili di tale volontà sono stati i fatti verificatisi nella scuola, nell’università e nei quartieri […] fino ad esplicitarsi in concrete proposte sociali e politiche».
L’allusione è alle liste cattoliche promosse dagli studenti nelle scuole medie superiori e nelle università, alle cooperative di vario genere (librarie, edilizie, alimentari) che erano state create in quel periodo, e ad alcune centinaia di candidature indipendenti nelle liste della Democrazia Cristiana alle elezioni amministrative del 15-16 giugno: iniziative riconducibili a persone che si riconoscevano nel movimento di Comunione e Liberazione o a simpatizzanti di tale movimento ecclesiale, a quel tempo ancora privo di riconoscimento ufficiale.
Contro l’emarginazione del cristianesimo
Al punto 2 si lancia l’allarme sulla “emarginazione del cristianesimo” nella società italiana, la cui responsabilità viene attribuita ai cristiani stessi e alla mentalità borghese che si è impadronita anche dei partiti di sinistra (echeggia qui la denuncia di Pier Paolo Pasolini, ucciso poche settimane prima, contro l’omologazione della società italiana):
«Infatti la maggioranza dei cristiani vive oggi una separazione tra la propria fede e le proprie responsabilità sociali e politiche. Inoltre i sintomi di ripresa di una identità cristiana incidente socialmente hanno reso più espliciti i disegni posti in atto da varie parti di emarginare […] la dimensione sociale e civile dell’esperienza cristiana. La mentalità laicista e borghese, che permea ormai larghi strati dei partiti di sinistra, tende obiettivamente a ridurre la vita di fede a un puro atto di culto e a una pratica di morale individuale».
Dimenticanza e egemonia borghese
Il punto 3 cerca di analizzare le ragioni di questa crisi, e le individua in due fatti: “La dimenticanza dei cristiani” e “L’egemonia borghese sulla Dc e sulla società”. Ciò che i cristiani avrebbero dimenticato è l’originalità della loro proposta, ridotta a formalismo associativo:
«Nell’azione politica i cristiani hanno lentamente smarrito una loro autentica originalità […]. Nonostante il proliferare di molteplici forme di associazionismo poste in atto dai cattolici, diventava sempre più difficile trovare nelle fabbriche, nelle scuole, nei quartieri e negli altri settori sociali una presenza culturale e un impegno sociale e politico visibilmente mossi da un’esperienza cristiana».
Ciò avrebbe anche motivazioni storiche, legate al fatto che dopo la Seconda Guerra mondiale i cattolici si sono trovati ad assumere la responsabilità principale nel governo dell’Italia senza essere pronti; il testo non chiarisce i motivi di tale impreparazione, che si potrebbero individuare nel “non expedit” che ha tenuto fuori dal governo del regno d’Italia le generazioni cattoliche post-unitarie e nel fascismo che aveva avocato a sé la gestione totalitaria della sfera politica. Conclude che
«le esigenze espresse dalla mentalità borghese finirono col determinare gran parte dell’impegno sociale e politico dei cattolici italiani. […] Le scelte economiche e sociali che la Dc propose o consentì che si realizzassero nel paese furono in gran parte mutuate dalla dottrina liberale. E questo fu un errore grave, anche se risulta maggiormente comprensibile alla luce della situazione internazionale e della posizione del Pci, allora totalmente stalinista».
Il Pci non è più interamente stalinista, mira a mettersi alla guida di un blocco storico formato da ceti differenti, ma la sua cultura di riferimento non è affatto popolare. In Italia infatti
«si sviluppa una forma di egemonia culturale posta in atto dalla convergenza della cultura marxista e di quella laicista-radicale e favorita dalla maggior parte degli strumenti di informazione. Tale egemonia culturale teorizza l’illegittimità di ogni significato sociale del cristianesimo e tende ad emarginare se non addirittura a soffocare ogni qualificata presenza politica dei cristiani e ogni loro creativa esperienza».
La responsabilità dei cristiani
Di fronte a questa nuova egemonia culturale si impone (titolo del punto 4 delle tesi) la “Responsabilità culturale e storica dei cristiani in Italia”. Qui si trovano le affermazioni più caratteristiche del Movimento Popolare, evidentemente mutuate dalla riflessione di Comunione e Liberazione. Il punto 4.1 recita: “Il cristianesimo è un fatto globale”. Svolgimento:
«La vita che la comunità cristiana, cioè la Chiesa, propone ai suoi membri coinvolge la totalità dell’esistenza e dell’azione umana nei suoi aspetti religiosi, culturali e materiali. Quando un uomo o una donna accolgono l’invito a seguire il Cristo e sviluppano compiutamente le potenzialità che il battesimo ha offerto loro, vengono coinvolti in […] una comunione di vita che tende a permeare tutti i livelli della loro esistenza, la globalità della vita».
Di conseguenza (4.2) “Il cristianesimo è un fatto sociale”. Da cui la necessità che «dei cristiani riprendano a vivere con responsabilità la loro identità nell’impegno sociale e politico accanto e insieme con altri». Se ci si dimentica la globalità e la socialità del cristianesimo, due sono le conseguenze negative (4.2.4): «l’integrismo e il cristianesimo anonimo». Il Movimento Popolare dice “no” a entrambi. Al primo in nome della storicità del cristianesimo:
«L’integrismo è la pretesa di dedurre in modo meccanico dalla fede e dalla parola di Dio il modello di società da rendere operante attraverso leggi e strutture civili. […] Al contrario, il cristianesimo è la pienezza di una vita che si incarna nella storia e perciò si esprime entro determinate condizioni sociali in continua evoluzione. È in questo impatto con le condizioni di un dato momento storico che il cristianesimo, globalmente vissuto, attua una sua espressione sociale e tende ad operare un cambiamento nella società stessa».
Il “no” al cristianesimo anonimo (teorizzato dal teologo tedesco Karl Rahner, che non viene citato) è motivato dal suo presupposto dualistico, che svaluta, anzi “dimentica”, «l’esperienza cristiana come fatto globale e sociale». Infatti:
«Il cristianesimo anonimo è quello di coloro che concepiscono la religione come un fatto puramente interiore. Costoro non ammettono che l’esperienza cristiana abbia un suo spessore storico e sociale, che si realizza in una vita vissuta comunitariamente da quanti si riconoscono come popolo di Dio in cammino nella storia entro la società civile. Il cristianesimo anonimo tende ad operare una separazione tra esperienza personale di fede e la propria esperienza nel sociale con il conseguente impegno politico. […] Alcuni cristiani paiono illudersi di poter esercitare un impegno politico progressista solo rendendo anonima la loro identità religiosa. In realtà essi, forse inconsapevolmente, accettano l’ipotesi più reazionaria dell’ideologia illuministico-liberale, secondo cui ogni fede e ogni cultura sono valori appartenenti alla pura sfera privata».
Il dovere di tendere all’unità
Seguono due sottopunti del punto 4: “L’unità carattere fondamentale dell’esperienza di fede” (4.5) e “La tendenza all’unità nel sociale” (4.6). La prima è illustrata piuttosto schematicamente, in appena quattordici righe, dove ci si limita a rimarcare che «nessuno potrebbe dirsi cristiano se questa parola avesse significati diversi o opposti tra loro senza esprimere […] un’unica esperienza originaria». La seconda tematica prende uno spazio doppio, che serve ad affermare che l’unità anche politica dei cristiani è irrinunciabile, ma non può essere perseguita con metodi disciplinari: piuttosto attraverso il dialogo e la carità. Premessa:
«Se l’esprimere in maniera concreta, con segni riconoscibili, l’unità di Dio che si manifesta nella pluralità delle esperienze cristiane è un’esigenza imprescindibile della fede, la tensione a cercare e a testimoniare l’unità anche nell’impegno sociale e politico, pur nel legittimo pluralismo delle forme associative, ne è un doveroso corollario».
Però «si tratta di una tensione, che va resa operante attraverso il metodo della comunione e del dialogo. È del tutto scontato che non tocca alla gerarchia ecclesiastica unificare i cattolici attorno a una linea politica». È solo attraverso il metodo del dialogo «intessuto di libertà e di carità paziente, che può essere favorita l’unità di un ritrovato “soggetto popolare cristiano” che tende a manifestarsi e a incidere socialmente».
(1. continua)



0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!