
L’amicizia operativa di un sindacato sui generis

Quelli della Birreria Finisterre – Una compagnia atipica nel lavoro e nel sindacato (Itaca Edizioni 2021) è la storia di un gruppo di lavoratori di Milano e dintorni accomunati dall’esperienza ecclesiale di Comunione e Liberazione che vivono con tale pienezza la sfida che la realtà porta alla loro fede da impegnarsi direttamente nel sindacato e da partecipare da protagonisti ad alcuni dei più importanti eventi che hanno segnato la storia delle relazioni sindacali, della tutela dei diritti e della promozione dell’occupazione in Italia nell’ultimo mezzo secolo.
Non si tratta di memorialistica, ma della documentazione di come una storia iniziata cinquant’anni fa è riaccaduta giorno per giorno fino ad oggi. Ovvero del racconto di come una presenza cristiana sul posto di lavoro senza dualismi è stata capace di produrre del bene per tutti e di incontrare, risvegliare e coinvolgere l’umanità di tanti.
I tazebao degli anni 70
La storia comincia nei terribili anni Settanta, quando alcune delle persone che danno il titolo al libro entrano a lavorare in fabbrica e si trovano a condividere la realtà di un mondo attraversato da tensioni fortissime, dove il lavoratore è alienato nel ruolo di operaio massa, il lavoro è visto esclusivamente come schiavitù al servizio del capitale e la presenza cristiana è assolutamente impalpabile, in quanto i cristiani presenti praticano una strana forma di maritainismo che prevede l’invisibilità del cristiano in quanto tale.
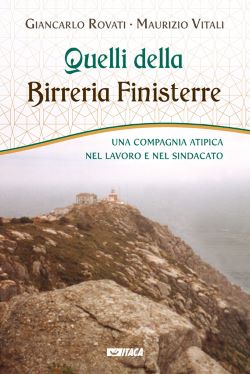
Invece i ciellini cercano gli altri cristiani per stabilire rapporti e agire insieme: «Abbiamo sempre portato avanti la nostra amicizia e abbiamo insieme speso la faccia in azienda come cristiani, intervenendo su tanti temi a tutto campo», racconta Adalberto Canavesi, operaio all’Alfa Romeo negli anni in cui la fabbrica era infiltrata di elementi delle Brigate Rosse.
«I cattolici che incontravamo erano tutta gente che lo erano come singoli, privatamente; noi eravamo una presenza un po’ diversa, comunitaria e riconoscibile. Ci facevamo sentire. I volantini venivano stampati e diffusi mediamente in quindicimila copie, ed era anche una bella spesa, dovevamo ingegnarci per trovare i soldi per pagarli».
Lo stesso stile lo si ritrova dieci anni dopo, per esempio nella persona del bancario e sindacalista Cisl Claudio Bottini, che ogni mattina affiggeva un tazebao con un intervento del Papa o un giudizio di Cl all’ingresso della sua filiale:
«La cosa funzionava, e accendeva sempre discussioni, rapporti nuovi, iniziative. Questo non piaceva ai capi, e a un certo momento dalla direzione arrivo l’altolà: divieto di affissione sulle colonne esterne. (…) Il mattino che mi trovai “la grida” con la proibizione montai su tutte le furie e mi precipitai dal direttore e gliene dissi di tutti i colori…».
Le politiche attive di Marco Biagi
Lo stesso coraggio di sfidare l’egemonia altrui e il pensiero dominante lo si ritrova puntualmente più tardi, quando si tratta di aiutare tutti a riscoprire il senso del lavoro come dimensione organica alla realizzazione della persona (facendo propria e riproponendo l’esperienza di Solidarnosc in Polonia e la lezione della Laborem Exercens di Giovanni Paolo II); quando si creano i Centri di Solidarietà per aiutare i giovani a trovare lavoro secondo una modalità personalizzata e non massificata come quella degli Uffici di collocamento che la Cgil voleva fosse l’unica; quando ci si impegna in politiche attive del lavoro approvate dal compianto Marco Biagi che portano all’istituzione di Lombardia Lavoro, del Patto di Milano, ecc.; quando si promuove prima un’associazione e poi un vero e proprio sindacato dei lavoratori atipici (il Felsa), anche in questo caso andando contro le rigidità ideologiche e lo scetticismo di tanti.
Lo sciopero contro Amazon
Nel frattempo quelli della birreria Finisterre di Dergano (quartiere milanese) sono diventati quelli del Circolo Ettore Calvi, famoso sindacalista cattolico del dopoguerra: i ciellini che in fabbrica proponevano una stabile presenza comunitaria in polemica con l’idea che l’unico modo di rendere testimonianza cristiana sul posto di lavoro fosse quello di fare sindacalismo, sono diventati quasi tutti sindacalisti, alcuni di alto livello (su tutti i nomi di Ivan Guizzardi, Fiorenzo Colombo e Angelo Colombini).
Ma la cosa più bella non è che hanno fatto carriera, ma che hanno affascinato sufficientemente una sfilza di giovani cattolici che a loro volta hanno deciso di impegnarsi nel sindacato sulla stessa linea dei loro maestri.
Due di loro, Mattia Pirulli e Daniel Zanda, rispettivamente segretario generale e segretario nazionale del Felsa, sono all’origine del famoso sciopero dei lavoratori somministrati e atipici di Amazon, il primo nella storia della multinazionale, proclamato nel novembre del 2017 nel megacentro di smistamento di Castel San Giovanni (Piacenza) e dilagato in mezza Europa.
Un sindacato atipico
Il racconto e le testimonianze personali raccolte nel libro sono perfettamente cucite con la narrazione della vicenda storica italiana fra il Sessantotto e i giorni nostri sulla base di chiavi di lettura che ne rendono il senso – con particolare attenzione alle lotte sindacali e alle epocali trasformazioni dei modi di produzione -, dalle capacità analitiche e cronachistiche dei due autori: Giancarlo Rovati, docente di sociologia all’Università Cattolica di Milano, e Maurizio Vitali, giornalista di lungo corso, fra le varie cose capo servizio di politica interna a Il Giorno e direttore di Lombardia Notizie.
Che riescono benissimo a spiegare perché i protagonisti del libro non vogliano essere chiamati “lavoratori”, ma “uomini del lavoro”, e non vogliano essere definiti “sindacalisti cattolici”, ma “un’amicizia operativa”.
Foto Ansa



0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!