
La sindrome della felicità

«Signora, va tutto bene?». Erano passate solo due ore da che Elena aveva scritto alla sua amica «ok, dai pure al giudice il nostro numero», e ora era lui, dall’altra parte del telefono. Elena si era presa qualche secondo per rispondere, in preda alle vertigini: «Mi scusi, avevamo dato quasi per scontato che un bimbo così piccolo venisse affidato a un’altra famiglia già inserita in un percorso di affido o adozione…». «Ci pensi bene allora, perché la possibilità che venga dato a voi è molto concreta».
Suo marito si trovava in macchina col vivavoce inserito e i bambini sul sedile posteriore quando lei lo chiamò. «Ci hanno chiesto di accogliere un piccolino con la Sindrome di Down», aveva spiegato l’uomo rivolgendosi ai ragazzi, e dalla macchina si era levato un immediato «embè, facciamolo papà». Anche il loro amatissimo zio aveva la trisomia 21, anche il fratellino dei loro più cari amici; e poi la loro casa era sempre piena di bambini e ragazzi accolti da mamma infermiera, papà educatore, e dai nonni vicini. Per questo Elena si era convinta che il tribunale avrebbe scelto una famiglia meno “affollata”, magari una coppia senza bambini. E invece era stato proprio “questo” a convincere il giudice che per quel piccino, appena partorito e abbandonato in ospedale, non potesse esistere un “villaggio” migliore.
L’intuizione di un giovane medico
Bologna, 1978. Il giovane medico Guido Cocchi li guardava uscire dall’ospedale con la morte nel cuore, madri e padri che ascoltando un professore a proposito del loro figlio appena nato avevano sentito morire il loro figlio “sano” immaginario, il suo posto usurpato da un figlio con un cromosoma in più. Non era compito di chi indossava il camice aiutarli a “elaborare il lutto”, tanto meno mutarlo in serena accettazione: i genitori ascoltavano inermi lo specialista parlare di divisione cellulare, cromosoma 21 soprannumerario, segni, sintomi, difetti e complicanze a cui poteva andare incontro il loro bambino, cardiopatie congenite, malformazioni a carico dell’apparato gastroenterico, disabilità intellettiva, invecchiamento precoce, ipotiroidismo, celiachia, cataratta. In teoria non mancava nulla alla feroce narrazione dogmatica che di lì a pochi anni, con la legalizzazione dell’aborto e l’affinarsi dei test di screening non invasivi per la diagnosi prenatale, avrebbe portato a migliaia di interruzioni di gravidanza. Eppure per Cocchi, fresco di laurea e specializzazione in clinica pediatrica, che spesso assisteva impotente a quei colloqui, mancava tutto, cioè una verità autoevidente: «Perché? Questi genitori andranno pure incoraggiati invece che demoliti, aiutati a capire che la Sindrome di Down non è una categoria artificiale e infernale ma una condizione umanissima e affrontabile. E che un figlio, così come ciascun figlio che potrebbe andare incontro alle stesse complicazioni senza alcun cromosoma in più, dà alla vita di un padre e una madre una gioia e uno scopo che non si misura con le indagini di laboratorio».
Insomma, quando la porta si chiudeva alle spalle di questi genitori, Cocchi pensava spesso a Enrico. Da bambini giocavano nel cortile: poi, a fine pomeriggio, Enrico lo salutava sudato e contento, e la porta di casa si chiudeva alle sue spalle. L’inclusione scolastica era ancora di là da venire e dietro quella porta cominciava la vita, isolata e rassegnata alle scuole speciali (abolite in Italia nel 1977), di un bambino con la trisomia 21. Così come dietro la porta del genetista cominciava quella di una mamma e di un papà rassegnati a una diagnosi comunicata come un verdetto fatale sulle loro esistenze. Così, un giorno del 1978, Cocchi andò a Genova. «Qui nel 1974 era nata la Cepim, un’associazione a sostegno delle persone Down che seguiva grandi e piccoli “dietro quella porta”, i primi a intuire che lavorando sulla riabilitazione precoce e l’integrazione (sociale, sportiva, scolastica e lavorativa) dei bambini la vita cambiava, eccome. In quegli anni a Bologna nascevano fino a 8 bambini all’anno con la trisomia 21, e una volta dimessi tanti saluti alla famiglia. Perché non provare a seguirli anche qui?».
«Prima si comincia, meglio è»
Sono passati 43 anni da allora, Cocchi è diventato una istituzione a Bologna, docente, autore di centinaia di pubblicazioni, socio delle più importanti società scientifiche di pediatria, neonatologia, malattie rare, genetiche e disabilità congenite del paese. Soprattutto – è in questi termini che ne hanno parlato a Tempi madri, padri, medici e studenti – è stato e continua ad essere un padre buono per centinaia e centinaia di genitori che dal 1978 sciamano qui da tutta Italia per essere seguiti nell’ambulatorio di malattie rare dell’unità operativa di Neonatologia del policlinico Sant’Orsola-Malpighi, diretto da Cocchi fino all’anno scorso. Un reparto straordinario: solo qui, dallo stupore dei medici per le 19 ore di vita di un piccolo con una malattia rara, poteva nascere il “percorso Giacomo”, protocollo di comfort care per bimbi venuti al mondo con malattie incompatibili con la vita e abbracciati fino all’ultimo respiro da mamma e papà, ideato dalla neonatologa Chiara Locatelli, allieva di Cocchi (ma questa è un’altra storia e ne parleremo presto); solo qui medici come Locatelli potevano mettersi al seguito della realizzazione di un ambulatorio speciale per accompagnare i genitori e i bambini con la trisomia 21 “oltre quella porta”.
«Un medico non sa solo ciò che viene snocciolato ai genitori sotto forma di informazioni circa la patologia o la compromissione dell’autonomia e dell’indipendenza che il bambino causerà a tutta la famiglia: queste informazioni note non fanno che rendere più ignoto il destino cui andrà incontro un intero nucleo famigliare. Un medico sa anche che è possibile raggiungere un elevato livello di autonomia e indipendenza sviluppando al massimo le potenzialità di questi bambini. E prima si comincia meglio è», racconta Cocchi a Tempi. Per capirci: oggi a Bologna nascono in media 3 bimbi con la Sindrome di Down ogni anno, la metà di quanti ne nascevano negli anni Settanta (oggi fino all’80 per cento delle gravidanze di bimbi con la trisomia 21 vengono interrotte), che diventano 6-8 se si conta anche la Provincia. E sono 320 le famiglie italiane che oggi hanno fatto del Sant’Orsola il loro punto di riferimento: qui follow up longitudinali, una équipe di logopedisti, psicomotricisti, psicologi lavora con neonatologi, pediatri e specialisti di ogni apparato per intervenire sulle complicanze (rarissimamente sono presenti nel bambino tutte quelle elencate dai medici alle mamme incinte) di ciascun piccolo dagli 0 ai 6 anni, e allo stesso tempo aiutarlo a esprimere e liberare tutte le sue possibilità.
Detta spiccia, a Bologna è stata costruita una rete tra famiglie, ospedale, università e servizi territoriali per seguirli e accompagnarli fino all’inclusione scolastica. Ma detta come si deve, a Bologna, in uno scampolo di ospedale, persona e bisogno sono stati strappati alle categorie, queste sì artificiali, dell’individualismo radicale, della salute come senso della vita, della solidarietà come attivismo titanico, liberate da un incidente cromosomico. Qui, nella fitta trama di rapporti e amicizie scaturite da una porta spalancata e non chiusa alle loro spalle, ogni genitore si è riconosciuto nel bisogno del suo bimbo disabile, ha rivisto se stesso, spezzato e amato, il proprio bisogno. E ha ricevuto in cambio tutto quello che ciascun uomo vuole dalla vita: essere amato, incondizionatamente, sulla faccia della terra.
Il comitato e il progetto
«Non avevamo bisogno di niente. Due figlie grandi, due brillanti carriere, una grande casa: avevamo tutto. Poi è arrivata Anna e quando Cocchi me l’ha messa tra le braccia mi ha detto: “È una vita che lavoro perché non siate soli. Non restate da soli”». Matteo Mele non sapeva nulla di quella paziente di Cocchi abbandonata dal marito perché non voleva abortire, una mamma straniera e indigente rimasta sola col suo piccolo con la trisomia 21, entrambi bisognosi di tutto. No, Matteo Mele aveva tutto: una compagnia di amici gagliarda e la fede tremante di chi era pronto ad accogliere questa piccola con la Sindrome di Down. Sarebbe stato facile per Mele pensare che fosse tutto in mano sua. Invece è arrivata Anna. Un petardo di vita. Un regalo al giorno.
A momenti era svenuto quando gli amici medici gli avevano mandano la foto della piccola urlante in sala parto con la pancia aperta della moglie sullo sfondo. Quanto all’umanissima paura del futuro, sua figlia più grande, Maria, che allora aveva 14 anni, l’aveva tramutata in attesa commossa quel giorno che lui l’aveva portata fuori a camminare – «vedi, ci hanno detto che Anna ha la Sindrome di Down», e già si aspettava da padre di dover aggiungere qualcosa per “consolarla” quando la ragazza lo aveva abbracciato: «Papà, ma tu e la mamma non siete soli», e subito era tornata a casa per fare posto ad Anna nella sua camera. Perfino i nonni, i nipoti, avevano inziato ad affollare la loro casa, «la verità era che Anna era diventata figlia di tutti, e che non saremmo mai stati soli». Poteva non badare a nient’altro, Mele. Anna – e qui va detto: si tratta di una bambina portentosa, ma anche questa è davvero un’altra, incredibile, storia – calamitava tutti, la famiglia non era mai stata così felice. Poi, arrivò lo Stato.
Lo Stato compagno dei genitori disabili, che fissa appuntamenti, organizza visite. «È a quel punto che ho scoperto che fuori dalla mia “bolla” non veniva offerto, prima dell’età scolare, alcun percorso di logopedia o abilitazione, né alcuna attività di potenziamento cognitivo, o di autonomia personale; in quell’età in cui, lo sapevo bene grazie a Cocchi e Locatelli, era cruciale lavorare in modo precoce sullo sviluppo e l’apprendimento, in preparazione al contesto scolastico». Poteva fregarsene, Mele, ad Anna non sarebbero mancate risorse e amici in grado di aiutarla.
Poi accadde che nacque un altro bambino con la trisomia, Renzo, figlio del suo amico Pierluigi Sforza. «Sarebbe stato più comodo, restare tra di noi. Invece io e Pierluigi siamo andati a Firenze a conoscere l’associazione Trisomia 21, riferimento di eccellenza in Italia col loro centro abilitativo e sanitario riconosciuto dalla Regione, nato per supportare le famiglie dei bambini con disabilità intellettive dalla nascita fino all’inserimento a scuola e nel mondo del lavoro. Siamo tornati in Emilia-Romagna con la ferma idea di portare quanto possibile del modello toscano anche da noi».
Meno di dieci all’anno: è il numero dei bambini con la Sindrome di Down che nascono tra città e provincia, troppo pochi perché l’iniziativa pubblica strutturi iniziative abilitative efficaci, gratuite e per tutti. Afferma Mele: «Ci siamo trovati in una situazione simile a quella dei farmaci orfani, vedevamo la necessità di attività abilitative indispensabili ma impossibili da ottenere». E anche qui, con una porta chiusa, si spalancò un portone: i due, insieme all’amica Antonella Misuraca, diedero vita al Comitato Amici di Lejeune, dal grande Jérôme Lejeune, padre della genetica moderna che scoprì la trisomia 21 e tenacemente accompagnò la ricerca alla pratica clinica, per cercare di guarire i suoi piccoli pazienti (oggi il Papa ha autorizzato la congregazione per le Cause dei santi a promulgare il decreto che ne riconosce le virtù eroiche, oggi sulle tracce di Lejeune è in corso una ricerca rivoluzionaria che coinvolge i bambini del Sant’Orsola).
Iniziarono con un convegno, nel 2017, aperto a genitori e insegnanti, finirono per restare travolti dalla partecipazione di oltre 500 tra professori, maestri, studenti di scienze dell’educazione, mamme e papà. Seguirono decine di incontri, corsi, attività formative destinate a medici, insegnanti, operatori sociali, familiari, amici e persone con Sindrome di Down, partnership, l’individuazione di un elenco “indipendente” di risorse presenti sul territorio (ce ne erano numerose), raccolte fondi per finanziare accesso e realizzazione delle attività necessarie, fino al progetto sperimentale “Guarda come cresco”, e soprattutto mettere a fattore comune le esperienze di tante famiglie che vivevano da sole la propria condizione, «come dice il Papa, Mettendo in comune quello che abbiamo». Poteva non fare nulla, Mele. Ma non era solo e da una compagnia scaturita dalla portentosa Anna Mele s’era invece inventato in Emilia-Romagna la sussidiarietà per tutti.
Fratelli e sorelle. E Sami
Maria rideva con la mamma in cucina quando Anna le era saltata in braccio. «Io sono felice se tu sei felice!», aveva esclamato, e in quel momento Maria si era chiesta se sarebbe mai stata capace di voler bene come sua sorella. Maria aveva bisogno di Anna. Non si era iscritta a medicina perché Anna aveva la Sindrome di Down, ma perché aveva visto i medici del Sant’Orsola alle prese con Anna, le visite, i suoi «evviva» ogni volta che scopriva di stare bene, benissimo. La gratitudine aveva disposto il suo cuore di ragazza e aveva reso più pronta e adeguata al bisogno la sua iniziativa: nulla di quella terza sorella le era estraneo, neanche il desiderio di amare genitori, fidanzato e amici proprio come Anna amava tutti. Il lockdown li aveva stretti in casa e attorno a quel canale di grazia che andava completando e perfezionando la loro stessa natura: tutto quello di cui aveva bisogno Anna era la stessa cosa di cui aveva bisogno lei, qualcuno che le volesse bene.
I fratelli e le sorelle: non c’è medico che non racconti che il primo pensiero di due genitori che ricevono una diagnosi di Sindrome di Down è per gli altri figli a casa. E che il desiderio di proteggerli, non caricarli di un fardello sproporzionato alla loro età e per il futuro, spesso decide il destino di un bambino in pancia. E poi c’è il fratello di Sami. Un giorno la maestra affida alla classe un compito, raccontare l’insegnamento più importante ricevuto e da chi: dopo qualche riga su babbo e mamma che certo quando era troppo piccolo per ricordarsene gli avranno pur insegnato qualcosa di molto importante, come imparare a camminare, il piccolo scrive: «Ma mio fratello… oh, lui me ne ha impartito uno molto importante, quasi senza volerlo. Nella sua semplicità Sami – azzardo – potrebbe impartire un insegnamento a ciascuno di noi. Beh, a me ha insegnato ad essere felice. Però lui mi serve come strumento. Sami è un gigante che è passato per caso sulla Terra. Quando sono triste e arrabbiato nello stesso momento, soprattutto con i miei genitori, Sami mette una barra alla disperazione. Come l’entità soprannaturale che fa ordine nel caos Sami ci zittisce. La situazione si capovolge in due modi: il primo, il mio preferito, è quando dice qualcosa di divertente sul nostro litigio: se è piccolo, ridiamo, e nessuno ne parla più; se è grosso, gli animi si placano, anche se dovrò riflettere su quello che ho fatto. Il secondo è quando dice “smettetela di litigare”. Se vede che non è bastato aggiunge: “Ti prego!”, facendo la faccina dolce. Noi lo coccoliamo, lo abbracciamo, poi susseguono sempre le due possibilità elencate prima. Sono stracontento di avere Sami come fratello».
Un nuovo focolare
Cinque giorni di fusione, pelle a pelle, una coperta viva per il bambino. Non c’era una cellula di Elena che non provasse quello che suo marito esclamò appena il giudice (finiti i colloqui d’ordinanza e verificata la disponibilità e serenità dei bambini) lì munì di decreto per andare a incontrare il piccolo in ospedale e cominciare la canguroterapia: «Cucciolo indifeso, figlio subito. Come Mowgli nel libro della giungla». Elena sapeva che non si trovava in ospedale perché era stata capace di un “sì”, ma perché questa volta «non ero riuscita a dire “no” alla terza proposta di accoglienza della mia amica, al bisogno così urgente di questo piccolo per cui bisognava trovare una casa. E poi l’ho incontrato, un fagotto palpitante. Figlio subito, me lo sono fuso addosso».
Dopo cinque giorni, Elena venne dimessa e la casa si accese di nuova luce. «Questo bambino è diventato il focolare a cui tutti si sono radunati, ha scaldato le nostre famiglie, quella dei miei genitori che ci hanno insegnato per primi la gratuità, degli amici che hanno portato a galla le lacrime e si sono immediatamente messi a disposizione, appena ci hanno incontrato con una carrozzina e hanno conosciuto questo bambino. La sua presenza ha ridato vita a un intero villaggio, quello che i detrattori di speranza infarciti di preconcetti, previsioni e paura non sanno immaginare, non sanno prevedere. Ricordo quando qualcuno mi ha detto che i nostri figli avrebbero “subìto per tutta la vita” la nostra scelta. I nostri figli subiranno solo quello che sceglieranno di non affrontare, avevo risposto di getto e ora che ogni incombenza era travolta dalla gratitudine ne avevo la certezza».
Elena era tornata ad essere una madre con una carrozzina a cui i passanti avrebbero ceduto il passo, una madre come tante con un bambino come pochi: un bambino che spalanca ogni giorno a uomini e donne il mistero del bisogno, che vissuto nella carità per altri uomini e altre donne porta al rinnovarsi, continuo, del miracolo della speranza, dell’amicizia, da Bologna a Genova, dalla Toscana alla casa di Elena. «Non c’è giorno che io non pensi alla sua mamma. Quella mamma segreta che ha scelto il parto in anonimato invece dell’interruzione di gravidanza. Penso a questa donna con gratitudine immensa per il dono di suo figlio nelle nostre vite. E non c’è giorno che non rinnovi il nostro “sì”, non c’è nulla di cui abbia paura».
* * *

Che cos’è il progetto “Guarda come cresco”
“Guarda come cresco”: è il nome del progetto sviluppato dalla Fondazione Sant’Orsola e dagli Amici di Lejeune, insieme ai medici e alla fitta rete di famiglie e associazioni che animano l’ambulatorio del Sant’Orsola di Bologna dedicato alla presa in carico dei bambini che nascono con trisomia 21. Un progetto che supporta i piccoli con trisomia 21 tramite attività precoci di logopedia, musicoterapia, psicomotricità fin dal primo anno di vita (il servizio sanitario aspetta invece almeno i 5-6 anni per intervenire). Un progetto tra gli otto che la Fondazione Sant’Orsola, motore no profit dell’ospedale, otto imprese e un istituto di credito che si sono uniti per supportare la cura del policlinico, ha deciso di promuovere e sostenere attraverso il suo bando aperto alle iniziative per rispondere all’emergenza sanitaria. Non importa se i bimbi con la trisomia sono pochi. Il “whatever it takes” a Bologna non è una teoria.

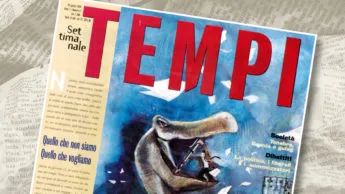

0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!