
La Pasqua in galera di Dostoevskij. E Maréj, il redentore dei briganti

Proponiamo stralci di un racconto autobiografico di Fëdor Dostoevskij, pubblicato in Diario di uno scrittore (1876) e in numerose altre raccolte con il titolo “Il contadino Marej”. Un bellissimo affondo sull’incontro, il peccato e la salvezza ambientato nella prigione siberiana dove il grande autore russo trascorse quattro anni per motivi politici circondato da ubriaconi, assassini e bestemmiatori.
Era il secondo giorno di Pasqua. Nell’aria tiepida, nel cielo azzurro, alto, quasi caldo, luminoso splendeva il sole; ma l’anima mia era buia e come spenta. Erravo dietro le caserme, osservavo, contandoli, i pali massicci della palizzata che chiudeva il carcere, ma non avevo voglia di contarli, sebbene per me fosse un’abitudine.
Era il secondo giorno di «festa» nella prigione: i forzati non venivano condotti ai lavori, v’era una quantità di ubriachi, e s’udivano bestemmie e uno schiamazzo di liti in ogni angolo. Canzonacce oscene, capannelli di giocatori d’azzardo tra le brande, alcuni forzati già battuti quasi a morte, per i loro eccessi, da un tribunale speciale dei compagni e abbandonati sulle brande sotto i loro gabbani di pecora, finché ritornassero in se stessi, i coltelli già alcune volte snudati: tutto questo, in quei due giorni di festa, mi tormentava fino allo strazio, fino a rendermi malato. Mai avevo potuto sopportare senza ribrezzo l’ebbra baldoria popolare, soprattutto lì, in quel luogo.
In quei giorni perfino l’autorità chiudeva un occhio, non perquisiva, non ricercava il vino nascosto, comprendendo che bisognava dare uno sfogo, una volta all’anno, perfino a quei reprobi, e che altrimenti sarebbe stato peggio.
Ma infine l’ira mi traboccò dal cuore. Mi ero imbattuto nel polacco M., un condannato politico: egli mi guardò cupo, i suoi occhi lampeggiarono e le labbra ebbero un tremito: «Je hais ces brigands!» («Come odio questi delinquenti!», ndr), stridette sottovoce, allontanandosi.
Ritornai nella caserma, sebbene un quarto d’ora prima ne fossi fuggito come un pazzo, quando sei robusti contadini s’erano gettati, tutti insieme, sul tartaro Hazin, ubriaco, e per calmarlo s’erano messi a picchiare: lo picchiarono in modo spaventoso, e botte simili avrebbero finito un cammello; ma essi sapevano che era difficile uccidere quell’Ercole, e battevano senza riguardo.
Ora, ritornando, vidi, a un estremo della camerata, su una branda in un angolo, Hazin svenuto, senza quasi dar segni di vita. Giaceva coperto dal suo gabbano di pecora, e gli altri gli passavano vicino in silenzio: sebbene fossero convinti che il giorno dopo sarebbe ritornato in sé, «però, dopo botte simili, avrebbe potuto anche morire», pareva pensassero.
Aprendomi un varco giunsi alla mia branda, che era contro l’inferriata, e mi coricai supino, intrecciando le mani sotto il capo e chiudendo gli occhi. Mi piaceva rimaner coricato a quel modo: non mi si molestava, e potevo sognare e pensare. Però non v’erano sogni in me: il cuore mi batteva inquieto e negli orecchi mi risuonavano le parole di M.: «Je hais ces brigands!».
[…] Mi venne all’improvviso in mente un istante della mia infanzia, quando avevo nove anni. Quell’istante pareva affatto dimenticato: ma io allora prediligevo proprio i ricordi appunto della mia infanzia.
Mi venne in mente l’agosto nel nostro villaggio: una giornata asciutta e chiara, ma alquanto fredda e ventosa. L’estate era sul finire e presto avrei dovuto partire per Mosca, per rinnovare il tedio invernale delle lezioni di francese; e a me dispiaceva tanto di abbandonare il villaggio.
[…] A un tratto, nella quiete profonda, udii chiaro e distinto il grido: «Il lupo!». Urlando, fuori di me dal terrore, corsi nella radura dal contadino che arava.
Era il nostro contadino Maréj. Non so se esista un nome simile, ma tutti lo chiamavano Maréj: un contadino di cinquant’anni, robusto, dall’ampia e folta barba biondo-scura fortemente brizzolata. Lo conoscevo, ma fino a quel giorno quasi mai mi era capitato di parlargli.
Egli fermò il suo cavalluccio, all’udire il mio grido, e quando io, infine, afferrai con una mano l’aratro e con l’altro la sua manica, si rese conto del mio terrore.
«Il lupo!», gridai, ansando.
Egli alzò la testa e si guardò in giro, per un istante quasi credendomi.
«Dov’è, il lupo?».
«Hanno gridato… qualcuno ha gridato un momento fa: il lupo…», balbettai.
«Ma che dici, che lupo! Ti sarà parso… che lupi dovrebbero esserci, qui…», borbottava, cercando di calmarmi.
Ma io, tremando tutto, mi strinsi ancor più forte al suo gabbano, e dovevo essere molto pallido. Egli mi guardò con una sorriso inquieto, certo temendo e agitandosi per me.
«Guarda come s’è spaventato! – diceva scuotendo il capo. – Basta, caro, basta, dunque!».
Stese una mano e improvvisamente mi accarezzò una guancia.
«Be’, basta, dunque, basta; Cristo sia con te, segnati».
Ma io non mi segnai; gli angoli delle mie labbra avevano dei tremiti e questo, sembra, lo colpì in modo particolare. Egli allungò con cautela il suo grosso dito, sudicio di terra, dall’unghia nera, e con cautela sfiorò le mie labbra sussultanti.
«Guardate – sorrise, di uno strano, lungo, paterno sorriso. – Signore Iddio, ma perché?».
Capii infine che non c’era nessun lupo e che m’era solo parso di sentire il grido: «Il lupo!». È vero, quel grido era così chiaro e distinto, ma gridi simili (e non solo «il lupo») m’era parso d’udirli già più di una volta, e io lo sapevo.
«Ebbene, ora vado», dissi, guardandolo in viso con timida domanda.
«Va’ pure, va’ pure, io ti seguirò con gli occhi. Non ti lascerò mangiar dal lupo, io! – aggiunse, sorridendomi sempre paternamente. – Ebbene, Cristo sia con te, va’ pure» e mi segnò con la mano e si segnò egli stesso.
[…] Dunque, quel ricordo s’era posato nella mia anima, da solo, senza la mia volontà, ed era riaffiorato improvviso, al momento giusto.
Ricordai il tenero materno sorriso del povero mugík asservito, i suoi segni di croce, il suo scuoter la testa: «Guarda come s’è spaventato!», soprattutto quel suo grosso dito, sudicio di terra, con egli con cauta e timida tenerezza aveva sfiorato le mie labbra sussultanti.
Certo, ognuno avrebbe fatto coraggio a un bambino spaventato, ma lì, in quell’incontro solitario, si racchiudeva qualcosa di particolare, di affatto diverso, e se io fossi stato suo figlio, non avrebbe potuto guardarmi con occhi raggianti di più chiaro amore.
Chi lo costringeva? Egli era un nostro contadino asservito, io il figlio del suo padrone: nessuno avrebbe saputo come mi aveva consolato, e nessuno l’avrebbe ricompensato per questo.
Dunque, amava tanto i bambini? Ci sono persone simili.
L’incontro era solitario, in un campo deserto, e solo Iddio, forse, vedeva dall’alto di quale luminoso, profondo umano sentimento e di quale sottile, quasi femminea tenerezza può esser pieno il cuore di un grossolano, ignorantissimo contadino russo asservito, che nulla sa – e allora nulla sapeva – della propria imminente liberazione.
Forse non pensava a questo Konstantín Aksakov, parlando dell’alta cultura del nostro popolo?
Ed ecco, quando scesi dalla branda e mi guardai attorno, ricordo, sentii all’improvviso che potevo considerare quei disgraziati con tutt’altro sguardo, e che d’un tratto, per una specie di miracolo, era scomparso ogni odio, ogni ira dal mio cuore.
Mi mossi, osservando in viso chi incontravo. Quel contadino dall’aria furfantesca e la testa rasata, col marchio impresso nel viso e che, ubriaco, sbraita roco una canzone, egli pure potrebbe essere Maréj: io non posso vedere nel suo cuore.
Quella sera incontrai ancora M. il polacco.
Infelice!
Egli non poteva ricordare, nella sua vita, nessun Maréj e nessun altro pensiero su di loro egli poteva avere all’infuori del suo: «Je hais ces brigands!».
No, i polacchi allora soffrirono molto più di noi.


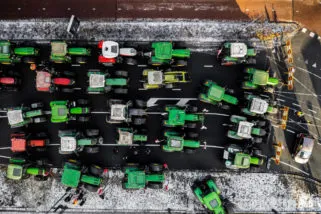
0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!