
Good Bye, Lenin!
«La parola chiave di Péguy è “carnale”». Il grande poeta visto dai russi
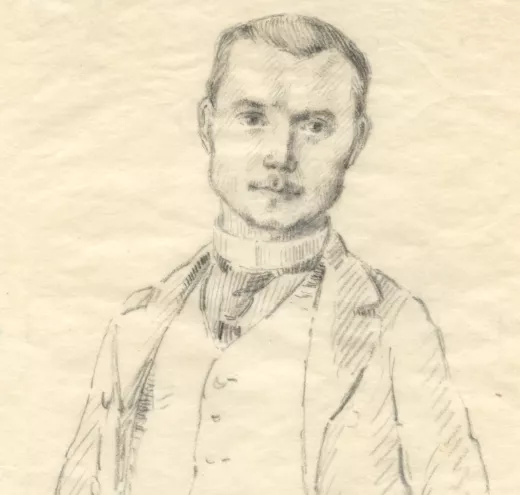 Nel 1926 la rivista Put’, «organo del pensiero religioso» dell’emigrazione russa a Parigi, ospitò una lunga e appassionata recensione che lo storico e pubblicista Georgij Fedotov scrisse sul libro dei fratelli Tharaud intitolato Notre cher Péguy. Fedotov, emigrato in Francia nel ’25 e amico di Berdjaev, è fra i primi russi a tracciare un «profilo religioso» dello scrittore francese morto nel ’14. «Il libro dei fratelli Tharaud sembra scritto per noi russi: il suo eroe, l’ambito di pensiero in cui ha vissuto, e la sua stessa religiosità ci sono così vicini». Charles Péguy – osserva Fedotov – non assomiglia tanto «a un piccolo tolstojano» come aveva scritto qualcuno, quanto piuttosto «ricorda un vecchio rivoluzionario russo che agisce però nella cultura classica, vicino al popolo».
Nel 1926 la rivista Put’, «organo del pensiero religioso» dell’emigrazione russa a Parigi, ospitò una lunga e appassionata recensione che lo storico e pubblicista Georgij Fedotov scrisse sul libro dei fratelli Tharaud intitolato Notre cher Péguy. Fedotov, emigrato in Francia nel ’25 e amico di Berdjaev, è fra i primi russi a tracciare un «profilo religioso» dello scrittore francese morto nel ’14. «Il libro dei fratelli Tharaud sembra scritto per noi russi: il suo eroe, l’ambito di pensiero in cui ha vissuto, e la sua stessa religiosità ci sono così vicini». Charles Péguy – osserva Fedotov – non assomiglia tanto «a un piccolo tolstojano» come aveva scritto qualcuno, quanto piuttosto «ricorda un vecchio rivoluzionario russo che agisce però nella cultura classica, vicino al popolo».
 La sua religiosità «non era uno spiritualismo parziale, egli stimò la pienezza del cattolicesimo; aveva una devozione particolare verso i santi (…) e prima di tutto verso Maria». Quando Péguy fece il pellegrinaggio a Chartres non fu «per implorare la guarigione di un bimbo, ma per consegnare i suoi figli alla Vergine, per porli nelle Sue mani. Il bambino guarì. “Beh, era ovvio”, disse lui. (…). “Battezzare i miei figli – diceva – è una cosa che non mi riguarda. Li ho consegnati alla Vergine, ne faccia Lei quello che vuole!”». L’idea fondamentale della sua religiosità – conclude Fedotov – è l’azione della grazia.
La sua religiosità «non era uno spiritualismo parziale, egli stimò la pienezza del cattolicesimo; aveva una devozione particolare verso i santi (…) e prima di tutto verso Maria». Quando Péguy fece il pellegrinaggio a Chartres non fu «per implorare la guarigione di un bimbo, ma per consegnare i suoi figli alla Vergine, per porli nelle Sue mani. Il bambino guarì. “Beh, era ovvio”, disse lui. (…). “Battezzare i miei figli – diceva – è una cosa che non mi riguarda. Li ho consegnati alla Vergine, ne faccia Lei quello che vuole!”». L’idea fondamentale della sua religiosità – conclude Fedotov – è l’azione della grazia.
Prima di Fedotov, Il’ja Erenburg (giornalista e scrittore che con il suo romanzo Il disgelo avrebbe dato il nome a un’epoca) era andato a far visita di persona alla redazione dei Cahiers: «Forse – gli aveva detto Péguy – i russi saranno i primi a rovesciare il potere del denaro». Erenburg tradusse alcune parti di Eva e abbozzò dei versi dedicati alla morte di Péguy, finiti poi nell’oblio.
Verso la fine degli anni ’20 tra i russi dell’emigrazione Péguy era un autore conosciuto e apprezzato, e molti – soprattutto la nuova generazione – conoscevano personalmente suo figlio Marcel che frequentava la parrocchia ortodossa di Parigi dove celebrava padre Lev Gillet, importante figura dell’ortodossia.
In Russia poco prima della Rivoluzione erano usciti alcuni brani in prosa di Péguy sulla rivista Russkaja Mysl’, ma dopo il ‘17 la sua figura cominciò ad essere guardata con sospetto. Inizialmente fu tollerato solo perché ne aveva scritto Romain Rolland, il quale era apprezzato in URSS per essere stato un sostenitore della Rivoluzione e amico personale di Gor’kij. Ma già nelle traduzioni sovietiche delle opere di Rolland molte pagine sul suo allievo «troppo cattolico» scomparvero. La Grande Enciclopedia sovietica del ‘55 scrive che Péguy «criticò con forza il capitalismo», ma vi contrappose solo «atteggiamenti pseudoborghesi». Se nelle sue opere «è presente l’idea del sacrificio di sé per amor di patria – osservano i critici sovietici, – questi temi sono affrontati con toni cattolici e talvolta si uniscono a posizioni scioviniste». Pochissimo fu tradotto, e il suo nome non comparve nemmeno nelle antologie dei poeti francesi del ‘900; unica eccezione di rilievo, la splendida traduzione di alcune pagine del Portico del mistero della seconda virtù ad opera del filosofo Sergej Averincev, uscita su «Novyj Mir». Averincev – uno dei maggiori intellettuali «nascosti» dell’epoca sovietica – descrive Péguy come un «ragazzino ampolloso, sconveniente e sincero», al quale sono estranee «banalità e cinismo» e che, «incontrandolo, può arrossire o di vergogna o per l’ira, perché il suo cuore puro non sopporta doppiezze».
 Fu nell’emigrazione che Péguy continuò ad essere familiare a molti teologi e pensatori russi. Lo slavista Nikita Struve ha sottolineato che è soprattutto il cristianesimo di Péguy ad aver affascinato l’intelligencija russa: la «continuità dell’incarnazione, Dio che si fa uomo, l’affacciarsi dell’eterno nel tempo, Cristo vero uomo e vero Dio che partecipa pienamente alla storia. La parola chiave di Péguy è carnale». Péguy – continua Struve – teme soprattutto un cristianesimo disincarnato, un monofisismo occulto: «Nelle sue linee teologiche fondamentali – la penetrazione reciproca di due nature in Cristo, quella umana e quella divina, l’antinomicità della concezione dei misteri della fede e il rifiuto del clericalismo – Péguy tocca da vicino la concezione del mondo ortodossa, sia pur senza conoscerla». Anche nello stile particolare, fatto di «temi e variazioni», egli restituisce alla lingua la sua forza primigenia, e l’uso delle ripetizioni conferisce ai testi una sfumatura religiosa, paragonabile agli akatisti, gli antichi inni alla Vergine della liturgia orientale. In questo – conclude Struve – sta la sacralità del Péguy poeta.
Fu nell’emigrazione che Péguy continuò ad essere familiare a molti teologi e pensatori russi. Lo slavista Nikita Struve ha sottolineato che è soprattutto il cristianesimo di Péguy ad aver affascinato l’intelligencija russa: la «continuità dell’incarnazione, Dio che si fa uomo, l’affacciarsi dell’eterno nel tempo, Cristo vero uomo e vero Dio che partecipa pienamente alla storia. La parola chiave di Péguy è carnale». Péguy – continua Struve – teme soprattutto un cristianesimo disincarnato, un monofisismo occulto: «Nelle sue linee teologiche fondamentali – la penetrazione reciproca di due nature in Cristo, quella umana e quella divina, l’antinomicità della concezione dei misteri della fede e il rifiuto del clericalismo – Péguy tocca da vicino la concezione del mondo ortodossa, sia pur senza conoscerla». Anche nello stile particolare, fatto di «temi e variazioni», egli restituisce alla lingua la sua forza primigenia, e l’uso delle ripetizioni conferisce ai testi una sfumatura religiosa, paragonabile agli akatisti, gli antichi inni alla Vergine della liturgia orientale. In questo – conclude Struve – sta la sacralità del Péguy poeta.



0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!