
La neolingua che ci fa parlare di “disagio dei lavoratori”


Articolo tratto dal numero di Tempi in edicola (vai alla pagina degli abbonamenti) – Con l’avvento della neolingua neoliberale si sono eclissati dal vocabolario gli stessi lemmi “sfruttamento” e “ingiustizia”, sostituiti dalla nuova figura semantica anodina del “disagio”. A differenza dello sfruttamento e dell’ingiustizia, che alludono a una relazione conflittuale obiettiva, nella quale vi è un polo che sfrutta e l’altro che è sfruttato, una parte che commette l’ingiustizia e l’altra che la subisce, il disagio riguarda sempre e solo l’io individuale nel suo rapporto con sé e con il mondo, in uno scenario falsamente raffigurato come privo di legami sociali e di conflittualità immanenti. Secondo le grammatiche egemoniche, lo sfruttamento classista dei precari è ridefinito asetticamente come “disagio dei lavoratori”, proprio come lo svuotamento desovranizzante e finanziario della democrazia viene ribattezzato come “disagio della democrazia”.
Sentimento di angoscia e di inadeguatezza scaturente dall’incapacità del soggetto di adattarsi alla situazione, il disagio è forma espressiva coerente dei processi di deresponsabilizzazione tipici della mondializzazione. In forza di tali processi, i fallimenti e le ingiustizie non vengono mai fatti dipendere da ciò da cui realmente dipendono, ossia dai rapporti di forza reali e dalle prosaiche logiche del capitale, bensì sempre e solo dall’incapacità degli io individuali – gravitanti senza peso e senza identità nel sistema dell’atomistica concorrenziale – di fare fronte al mondo oggettivo, di adeguarsi alle situazioni, di modellare adattivamente la propria soggettività in coerenza con le condizioni date.
Gli unici possibili guaritori
Le contraddizioni reali di un paesaggio intessuto di violenza economica e di sfruttamento, di alienazione e di miseria, cessano di essere anche solo nominate. In loro luogo, subentrano i “disagi” soggettivi di chi non sa adattarsi. La prospettiva della rivoluzione come via corale per superare le contraddizioni oggettive cede, allora, il passo alle figure dello psicologo e del counselor come unici possibili guaritori dei disagi dell’individuo, senza che l’oggettività dei rapporti della produzione sia anche solo scalfita o nominata.
Dogmaticamente immodificabile
Da parte integrante della realtà oggettiva, la contraddizione è stata trasfigurata in parte dell’individuo non adattato; con la conseguenza per cui si è indotti, con la sintassi di Ulrich Beck, il sismografo della Risikogesellschaft, a cercare soluzioni biografiche a contraddizioni sistemiche, cambiando se stessi più che l’oggettività contraddittoria dei rapporti sociali.
La ragione rivoluzionaria che mira, alla maniera fichtiana, a conformare prassisticamente l’oggetto al soggetto viene sostituita dalla ragion cinica rassegnata, che prescrive al soggetto l’adattamento disincantato all’oggetto assunto dogmaticamente come immodificabile.
Risulta quanto meno difficile immaginare che possa essere risolto come mero disagio individuale quello, tra gli altri, avvertito dai lavoratori precari di alcune manifatture inglesi, costretti a lavorare a ritmi accelerati per intere ore stando in piedi, privati perfino della possibilità di recarsi in bagno; o quello subito dalle lavoratrici in gravidanza delle medesime manifatture, successivamente costrette ad abortire per via dei turni di lavoro di sedici ore, con intervalli di due ore tra un turno e l’altro.
I nostri corpi e i nostri abiti
E, non di meno, la neolingua e le sue funzioni espressive sono riuscite nel loro obiettivo mistificante, scaricando sulle spalle e sulla coscienza dei singoli sfruttati le cause della loro sofferenza. Ne scaturisce una condizione che, a tratti, ricorda quella delineata da Brecht nel suo componimento Discorso di un lavoratore a un medico:
«Quando veniamo da te/ ci strappiamo di dosso i nostri cenci. E tu ascolti qua e là sul nostro corpo nudo. Sulla causa della nostra malattia/ un solo sguardo ai nostri cenci ti direbbe di più. Una stessa causa fa a pezzi i nostri corpi e i nostri abiti».
Con questa chiave ermeneutica si spiega, oltretutto, la sempre più in auge pratica della psichiatrizzazione di quella sofferenza sociale che è legata indissolubilmente alle contraddizioni reali del modo della produzione e la cui responsabilità viene falsamente attribuita ai singoli lavoratori e ai loro “disagi”.
Foto Ansa
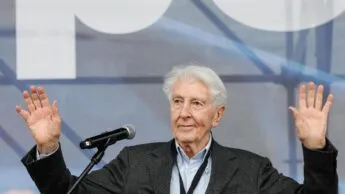


1 commento
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono chiusi.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!