
La morte moderna. Quando l’eutanasia ci renderà tutti uguali


Articolo tratto dal numero di Tempi in edicola (vai alla pagina degli abbonamenti).
I personaggi de La morte moderna di Carl-Henning Wijkmark hanno tutto per piacerci. È gente raffinata ma pragmatica, elegante senza spocchia, intelligente senza presunzione. Soprattutto, è gente che è seriamente impegnata nel risolvere un problema senza troppe fantasticherie per il capo e dedita a trovare soluzioni razionali, plausibili ed efficaci ad un dilemma di ostica soluzione. Ci sarebbe quasi da ringraziarli.
Quando nel 1978 Wijkmark diede alle stampe il suo volume immaginò un simposio a porte chiuse dove eruditi di varie discipline si ritrovavano per discutere della «fase terminale della vita umana». Convocati dagli esperti del comitato ministeriale Fater in un centro congressi sullo stretto di Oresund in Svezia, filosofi, teologi, biologi e chimici dovevano fornire suggerimenti e soluzioni per uscire dalla crisi economica che ormai durava «da dodici anni». Una crisi che già sul finire degli anni Settanta, Wijkmark descriveva con sagace capacità profetica: al mondo c’erano troppi anziani e pochi bambini, ergo la piramide demografica tendeva verso la figura del fungo con una percentuale di popolazione attiva infinitamente inferiore a quella inattiva, composta da pensionati e non autosufficienti. In più, essendo reduci ormai da anni di martellamento mediatico sulla necessità di vivere secondo modelli di fitness, i cosiddetti vecchi erano persone in gamba e in salute con prospettive di vita che superavano gli ottant’anni. Conseguenze? Disoccupazione, spesa per il welfare fuori controllo, tassazione alle stelle.
Così, dicono gli esperti del romanzo, non si può più andare avanti. Occorre una riforma radicale che metta in ordine le cose. Occorre abbattere un «vecchio tabù che si chiama rispetto della vita umana» e far sì che «il concetto di qualità della vita» sia interpretato «nel senso che vite diverse hanno diverso valore. Il valore di una vita dev’essere calcolato in primo luogo in termini economici e sociali». In altre parole, «abbiamo bisogno di più morti, per dirla in maniera brutale». Ma poiché «morire è considerato innaturale» ed esiste ancora l’ostinata idea della sacralità della vita, occorre trovare una strategia comunicativa che presenti l’eutanasia non come qualcosa di traumatico, ma come l’ordinaria, ovvia e naturale conclusione dell’esistenza. In fondo, se «nasciamo tutti alla stessa età, perché non dovremmo morire tutti alla stessa età?».
Come addormentarsi
Quando Wijkmark immaginò il suo congresso di luminari le faccende umane non andavano molto diversamente da oggi. Anche oggi, come allora, essendo passata l’età delle «norme assolute, quando non c’è più nessun dio che le possa garantire», si tratta di essere seri, pragmatici, efficaci. È un imperativo che si pone per chi si occupi dello Stato: far quadrare i conti. Dunque nel fu paradiso svedese si trattava di continuare a occuparsi dei propri cittadini dalla culla alla tomba, solo anticipando la tomba di qualche anno. Per il bene di tutti, beninteso.
Nel romanzo gli esperti di Fater prendono la parola animati dalla stella polare dell’utilità, avendo ormai constatato che antiche parole come “sacralità”, “assoluto”, “intangibilità” sono retaggi del passato, inadatti a fare i conti (letteralmente, economicamente) col presente. «Ciò che si vuole è produzione, non civiltà. Cose, non esseri umani», dice un personaggio. D’altronde, se si è riusciti a far accettare la pianificazione delle nascite attraverso l’aborto, cosa osta alla pianificazione dei decessi? L’unico problema è “comunicare” adeguatamente l’idea della morte moderna.
Essa non deve apparire come un’imposizione, ma come una libera scelta. La soppressione del malato cronico, dell’incurabile, dell’improduttivo, del down non deve essere vista come la liquidazione dell’innocente, ma come l’inevitabile sacrificio dell’uno inutile per il bene dei molti sani: «La società assume o completa la funzione rassicurante della religione». Morire deve diventare «come addormentarsi dopo una lunga giornata di lavoro».
I vantaggi? Straordinari, e sotto molteplici punti di vista. Con l’«obbligo volontario» a morire si troverebbe il punto di equilibrio tra giovani e vecchi, il paese tornerebbe a prosperare, ci sarebbe lavoro per tutti. Ma per farlo, premettono i luminari del Fater, bisognerebbe abbandonare la vecchia strategia di alcuni gruppi che hanno presentato la dolce morte come una decisione individuale e personale, limitandone l’accesso a uno sparuto gruppo. Occorre, invece, che sia l’ente statale a pianificare una “fine democratica” uguale per tutti (esclusi gli handicappati, ovvio, essendo unanime l’opinione che essi sono inutili e basta).
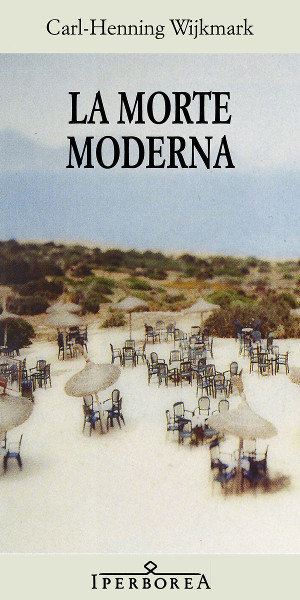 Certo, c’è quel fastidioso paragone storico con il nazismo, ma «per quanto tempo dovremo ancora negare che Hitler aveva pure parecchie buone idee che hanno un ruolo anche nella nostra società? Perché non si dovrebbe poter parlare di controllo dell’età o controllo delle morti, se si vuole, come si parla di controllo delle nascite?».
Certo, c’è quel fastidioso paragone storico con il nazismo, ma «per quanto tempo dovremo ancora negare che Hitler aveva pure parecchie buone idee che hanno un ruolo anche nella nostra società? Perché non si dovrebbe poter parlare di controllo dell’età o controllo delle morti, se si vuole, come si parla di controllo delle nascite?».
Centro di riciclaggio
Non solo. Nella Svezia prospettata da Wijkmark si ha il coraggio di spingersi un po’ più in là. Poiché è ormai accettata l’idea secondo cui è lecito trasferire arti umani da persona a persona attraverso i trapianti, e il sangue attraverso le trasfusioni, perché non organizzare il paese come un enorme centro di riciclaggio? Il corpo del morto di chi è, se non dello Stato? Essendo ormai comune la cremazione ed essendo rimasti solo pochi cattolici («che non saranno un problema») a chiedere l’inumazione, perché non creare una filiera che permetta la raccolta degli organi dei defunti affinché possano tornare utili? Perché non fare in modo che «la morte diventi produttiva» e «crei posti di lavoro», tra l’altro con un ottimo risparmio energetico e basso impatto ambientale? Sarebbe «una vera miniera d’oro per la creazione di medicinali, concimi e mangimi».
Come dice il responsabile di Fater: «Questa morte asettica e inodore nella cella frigorifera della stazione terminale non è forse la morte moderna nel vero senso della parola? E tutti seguiamo lo stesso cammino, non alcuni nelle fiamme e altri nella terra. Macinati, ridotti in polvere fine, saremo sparsi sui vasti campi della società e le daremo nutrimento. Non è una visione più gradevole e più ricca di senso che non la distruzione attraverso il fuoco o la lenta putrefazione?».
Dinamica e flessibile
A quasi quarant’anni dalla sua pubblicazione, la distopia di Wijkmark non si è realizzata. Il discorso intorno all’eutanasia passa ancora oggi attraverso i criteri di scelta “consapevole, libera e individuale”, come ci dicono i suoi sostenitori. Ma, a parte il fatto che permetterla ingenera delle conseguenze (a chiederla non sono solo più i malati terminali, ma anche i depressi e i sani infelici), il punto interessante de La morte moderna è di aver illustrato le basi del ragionamento eutanasico. Che essa sia “individuale” o “sociale”, resta il fatto che la premessa per la sua attuazione è che «l’etica non sia fissa, ma dinamica e flessibile». Se tutto è uguale e niente ha valore – se non un valore calcolabile a seconda della convenienza della maggioranza – è solo una questione di modus operandi. Per il resto, si tratta solo di uccidere qualcuno senza fargli troppo male.
Articoli correlati
1 commento
I commenti sono chiusi.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!



Di libri profetici sull’argomento avevo letto solamente “Il padrone del mondo” di Benson, scritto attorno al 1910, e che descrive una situazione simile a quella attuale in Olanda.
Ne “La morte moderna” si prospetta invece una eutanasia imposta per legge.
Temo che sia molto più facile indurre le persone all’eutanasia volontaria che non obbligarle, basta bombardare la popolazione con l’ansia per l’invecchiamento, il terrore dell’inefficienza, la paura di dover dipendere da un altro … proponendo con l’altra mano una pillolina dolce e accattivante come la Kill Pill.