
La Grecia degli anti-eroi, colpiti più che «dalla crisi economica, da una crisi esistenziale»

Da Atene. Se volete conoscere le conseguenze materiali della crisi greca sui proletari, sottoproletari e piccolissimi borghesi dei quartieri popolari del Pireo, sulla gente di Faliro, di Vula e di Glyfada, leggete Qualcosa capiterà, vedrai di Christos Ikonomou. Se volete scoprire come la crisi economica agiti le anime della gente semplice fino a far venire fuori le domande universali sulla vita, leggete Qualcosa capiterà, vedrai di Christos Ikonomou. E se volete partecipare del mistero della fragilità umana, abbracciare e riconciliarvi con la vostra propria debolezza attraverso la compassione per la debolezza altrui, leggete Qualcosa capiterà, vedrai di Christos Ikonomou.
 Sono storie di licenziati che non ritrovano un lavoro, di case pignorate dalle banche a chi non può rimborsare il mutuo, di bollette che non possono più essere pagate, di tradimenti miserabili per poche centinaia di euro. Di uomini e donne che sprofondano, spaventati e senza più speranza nel domani, ma senza rinunciare a chiedersi che cos’è veramente un essere umano e a tentare di rispondersi. Così gente che colta non è, ma solo turbata e tormentata, finisce per distillare sentenze che paiono pronunciate da Shakespeare o da Cechov. «Mi dici che nella vita vale la pena solo dare e darsi. Ma come si fa se nessuno vuole prendere? Come si fa se non trovi nessuno a cui dare e darsi?».
Sono storie di licenziati che non ritrovano un lavoro, di case pignorate dalle banche a chi non può rimborsare il mutuo, di bollette che non possono più essere pagate, di tradimenti miserabili per poche centinaia di euro. Di uomini e donne che sprofondano, spaventati e senza più speranza nel domani, ma senza rinunciare a chiedersi che cos’è veramente un essere umano e a tentare di rispondersi. Così gente che colta non è, ma solo turbata e tormentata, finisce per distillare sentenze che paiono pronunciate da Shakespeare o da Cechov. «Mi dici che nella vita vale la pena solo dare e darsi. Ma come si fa se nessuno vuole prendere? Come si fa se non trovi nessuno a cui dare e darsi?».
«La nostalgia. Un cane rognoso con occhi cisposi che si lecca le ferite e si fa beffe di te e che se allunghi la mano per accarezzarlo ti morsica con tutta la sua forza». «La prima vittoria del male è quando comincia a parlare la tua lingua». «In marzo quando fresche sono le notti e la tua testa fa capolino alla finestra e annusi il profumo del melangolo e guardi le stelle in cielo e le sparse nubi e ti dici che qualcosa può succedere – può succedere qualcosa e il mondo può non svanire e gli uomini con lui». Tempi ha incontrato Christos Ikonomou (foto a fianco), premio nazionale per la narrativa breve 2011, nella caffeteria della libreria Ianos ad Atene e parlato con lui per un’ora.
Che rapporto intrattengono con la realtà le sue storie? Le persone reali in Grecia sentono, pensano e si comportano come i suoi personaggi?
Il mio libro è una raccolta di storie brevi che sono fiction. I protagonisti non sono reali, sono il prodotto della mia immaginazione; tuttavia rappresentano la gente che vive nei quartieri popolari, nei sobborghi di Atene. Il punto per me non era di fare un reportage giornalistico o un testo di sociologia, ma narrativa. D’altra parte, non si fa fiction con l’aria fritta: ci deve essere una forte relazione con la realtà. Ho mescolato la mia immaginazione con le cose che ho visto e che ho sperimentato negli ultimi anni.
 I suoi personaggi hanno gravi problemi causati dalla crisi economica, ma si presentano come persone che già da prima erano sull’orlo di un crollo, erano fragili. La debolezza è la condizione normale di questi esseri umani, e la crisi li spinge sull’orlo del precipizio.
I suoi personaggi hanno gravi problemi causati dalla crisi economica, ma si presentano come persone che già da prima erano sull’orlo di un crollo, erano fragili. La debolezza è la condizione normale di questi esseri umani, e la crisi li spinge sull’orlo del precipizio.
È proprio così. Ho cominciato a scrivere nel 2004, l’anno delle Olimpiadi ad Atene, quando tutti pensavano che fosse giunta la prosperità e le cose sarebbero andate sempre meglio. Ma quella era solo la superficie della realtà. Io cercavo di guardare sotto la superficie, alla gente che non aveva parte nella prosperità. Quando nel 2010 è uscito il libro, molte altre persone erano scese a quel livello. Tragica ironia delle circostanze! Debolezza è la parola giusta: le persone deboli sono quelle che mi interessano come scrittore. La debolezza è la condizione umana con cui ha a che fare ogni scrittore. Vedere cosa succede quando qualcuno è debole, cosa fa per superare la debolezza o cosa non fa. È una parte fondamentale della natura umana, e la narrativa deve occuparsene. Il mio libro è stato definito “profetico”, perché è stato scritto fra il 2004 e il 2010, prima che la crisi esplodesse, ma non è così: semplicemente, lo scrittore deve tenere gli occhi e le orecchie aperti, deve andare oltre la superficie delle cose e concentrarsi sui dettagli. Allora le sue storie non sono banali.
I politici di destra e di sinistra tendono a descrivere i greci come un popolo di eroi che affrontano la crisi con coraggio, solidarietà e giustificata rabbia. I suoi personaggi, al contrario, sembrano piuttosto degli anti-eroi. Non sono molto solidali, sono semplicemente depressi, inguaiati, tormentati. Potrebbero trovare posto nelle favole, come lei scrive, ma non nella poesia epica.
Questo è uno dei commenti più intelligenti che ho sentito fare. C’è un grosso gap fra quello che i politici dicono e la realtà. Io non voglio abbellire e non voglio beatificare i miei personaggi, farne degli eroi o dei santi. Lo fanno già i politici e i giornalisti. Certo, molte persone intorno a me sono una specie di eroi, perché ci vuole molta forza morale oggi per vivere. Ma io cerco di rappresentare la gente profondamente afflitta, non sono interessato a quelli che si sentono forti. La debolezza è un grande argomento per la narrativa, purtroppo. Capisco che alcuni cercano di uscirne, ma non sono sicuro che ci sia così tanta solidarietà, che la crisi abbia generato un grande cambiamento nell’avvicinarci gli uni agli altri. Noto invece una forte polarizzazione nella società greca: molti si sono spostati verso gli estremi politici, e questa è una nuova divisione in un paese che è sempre stato diviso. Questo mi spaventa molto: cosa succederà se la divisione si approfondisce? Possiamo trovare qualcosa che ci unisca? Non so se possiamo trovarlo. Vorrei essere ottimista, avere fede. Dobbiamo trovare una nuova forma di unità, perché solo così la società funziona, ma in questi quattro ultimi anni è cresciuta la divisione.
 Nei suoi racconti sembra che la crisi spinga la gente a porsi le vere domande sulla vita, le più profonde. La crisi diventa un momento di verità esistenziale. Ma nessuno sembra trovare le risposte. Come dice un suo personaggio: «Quando scopri che c’è un significato, che c’è una corda che lega tutto insieme e non semplicemente il caos, sei doppiamente spaventato, perché sai che non troverai mai quella corda». Questo mi ricorda il diario di Kafka: «La mèta c’è, ma non c’è nessuna strada per arrivarci».
Nei suoi racconti sembra che la crisi spinga la gente a porsi le vere domande sulla vita, le più profonde. La crisi diventa un momento di verità esistenziale. Ma nessuno sembra trovare le risposte. Come dice un suo personaggio: «Quando scopri che c’è un significato, che c’è una corda che lega tutto insieme e non semplicemente il caos, sei doppiamente spaventato, perché sai che non troverai mai quella corda». Questo mi ricorda il diario di Kafka: «La mèta c’è, ma non c’è nessuna strada per arrivarci».
Mi dà sollievo che qualcuno colga questo nel libro, perché ho dovuto spiegare che al centro dei racconti non c’è la crisi economica, ma quella delle persone: è una crisi esistenziale quella che si vive in Grecia. Tanta gente non ne è consapevole, la sua prima preoccupazione è il denaro, un posto dove vivere. Ma la crisi è esistenziale. Cosa siamo, che paese è questo, che società siamo, che società avevamo e che società avremo? Le risposte a queste domande esistenziali sono 10 milioni, come i greci. Perciò non c’è un terreno comune. Il compito dello scrittore, come scriveva Cechov, è di porre le domande giuste. Se ha anche le risposte, tanto meglio, ma prima di tutto deve porre le domande giuste, quelle che molti non vogliono farsi perché troppo dolorose o troppo difficili.
I greci sono considerati un popolo religioso. Nei suoi racconti i personaggi sfidano Dio, lo irridono, lo rifiutano. Ma a volte cercano ancora forze e stabilità in Dio, e si dicono l’un l’altro: «Non rinunciare alla fede, non farti rubare la tua fede». E sembra trattarsi di una fede insieme umana e soprannaturale. La crisi ha cambiato il senso religioso dei greci?
È vero, molti dei miei personaggi sfidano Dio e hanno una relazione tormentata con lui. Ma non è gente senza Dio. Cercano di non perdere la fede. Forse hanno perso Dio, ma cercano di ritrovarlo: hanno una relazione dinamica con Dio e con la fede. Alcuni di loro sono come una madre che ha perso un figlio: se perdi qualcuno che ami, non smetti di amarlo. L’amore resta. Queste persone hanno perduto Dio ma non l’amore per lui, la devozione. Anche se si fanno beffe di Dio, non sono atei. È vero che dall’esterno i greci appaiono religiosi, ma è una religiosità superficiale. Molti si definiscono cristiani ortodossi, ma io credo che la fede ha bisogno di fatti e non solo di parole. Come dice la lettera di San Giacomo? «La fede senza le opere è morta». In Grecia molti hanno perso la fede, ma altrettanti cercano qualcosa di superiore all’umano in cui credere. Nella risposta che le sto dando lei troverà delle contraddizioni, ma quello che scrivo viene proprio dalle mie domande e dalle mie contraddizioni, che diventano le contraddizioni dei miei personaggi. A volte mi chiedo: se non ho più nulla in cui credere, posso ancora uscire da me stesso e cercare fuori di me qualcosa in cui credere? È quello che fanno molti miei personaggi, perché l’uomo non può stare senza fede: la tua fede è il tuo Dio. Una delle cose belle dello scrivere è che scrivendo scopri che cos’è che ci mantiene uomini. L’arte, inclusa la narrativa, verte intorno a ciò che facciamo per mantenerci umani, riconoscibilmente umani. Oggi si cercano nuove risposte, spesso esotiche, ma le cose più importanti restano la fede, l’amore, la devozione a ciò che è veramente grande. Non accetterei mai di ridurre il mio scrivere a esprimere me stesso, a parlare di me. Troppi, soprattutto i giovani, sono centrati esclusivamente su se stessi.
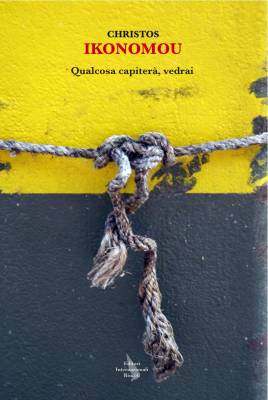 La crisi, oltre che materialmente, ha impoverito i greci antropologicamente?
La crisi, oltre che materialmente, ha impoverito i greci antropologicamente?
Impoverimento antropologico è un’espressione troppo forte. Io direi anzi che la crisi economica ha determinato un arricchimento nel modo di concepire il nostro posto nel mondo, almeno per quelle persone che oggi cercano di aiutare gli altri. Ci sono esempi di volontariato e di solidarietà che prima non c’erano, anche se non sono numerosi come si vuol far credere. Politici e giornalisti tendono a trasformare in uno show questa solidarietà, a enfatizzarla oltre le reali proporzioni, ma non possiamo ignorare il fatto che oggi tanta gente dà gratuitamente e di cuore. Non è una cosa senza importanza.
Che cosa la preoccupa di più delle tendenze che si sono sviluppate nella società greca in questi anni di crisi?
Anzitutto, come dicevo prima, la polarizzazione politica, che da noi è sempre stata forte ma adesso è fuori controllo. Queste faglie che si sono aperte nella nostra società mi spaventano, perché non riesco a immaginare come si potranno richiudere. Poi la facilità con cui alcuni manipolano la sofferenza umana. Mi si spezza il cuore per la tristezza nel vedere come i potenti si prendono gioco dell’umanità ferita con false promesse, come manipolano il popolo. Infine, il fatto che oggi non si ha più fiducia in nessuno: i politici sono tutti ladri, i giornalisti tutti venduti, gli imprenditori avvoltoi che divorano i cadaveri degli operai, gli intellettuali degli smidollati elitari. Niente e nessuno ha più valore, nessuno è degno di guidarci. E allora cosa resta? Non si può svalutare tutto e tutti in una società, perché altrimenti finiremo per essere governati da quelli che mettono le bombe o da quelli che portano la svastica.
Con quali nemici esterni e con quali nemici interiori deve lottare oggi il popolo greco per restare vivo?
In Grecia sono sempre state di moda le teorie cospirative, molti credono a una cospirazione di nemici della Grecia. Io credo che ci siano nemici esterni, ma non ostili specificatamente alla Grecia: c’è un capitalismo senza regole che trova le sue vittime nei lavoratori di tutta l’Europa meridionale. Qui da noi hanno realizzato un grosso esperimento sociale, di cui sono complici le élites interne. Ma il nemico più importante è quello dentro di noi. Ogni volta che siamo riluttanti a rispondere alle domande «chi vogliamo essere?», «che genere di paese, che tipo di società vogliamo essere?», è il nemico dentro di noi che vince.
Articoli correlati
1 commento
I commenti sono chiusi.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!

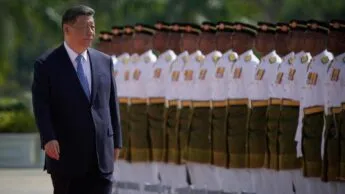

che bell’ARTICOLO