
La felicità, i ragazzi del sabato sera e Leopardi
Il genio di Leopardi descrive molto bene la società contemporanea, che propone la cultura della distrazione, dell’evasione e dell’assopimento dell’io. Ma, come scrive Leopardi, «solo chi non ha smesso di desiderare la propria felicità, può ancora volere la felicità altrui».
Pubblichiamo un capitolo del libro Che cos’è dunque la felicità, mio caro amico? di Giovanni Fighera (qui il suo blog su tempi.it). Il volume, già uscito nel 2008, è stato rieditato dalla casa editrice Ares. Qui trovate la prefazione di monsignor Luigi Negri e uno stralcio del primo capitolo.
Capitolo settimo
Il divertissement e la moltitudine dei piaceri
Nell’operetta morale “Dialogo di Malambruno e Farfarello” Malambruno, dopo aver chiesto la felicità al demone e aver ottenuto una risposta negativa, desidererebbe almeno togliere l’infelicità. Farfarello risponde che ciò è impossibile a meno che non smetta di volersi bene. Per Leopardi la benevolenza per sé presuppone la non saturazione del proprio animo, del proprio cuore, così come è fatto, nel suo desiderio infinito di felicità, nel suo status ontologico, perché altrimenti si rinnegherebbe quel desiderio di amore e di felicità infinito. Se ciò che ci procura tristezza è la domanda che sembra non trovare appagamento, è sufficiente smorzare la tensione di questa attesa, del desiderio per stare, solo apparentemente, meglio.
Ecco perché un assopimento dell’animo è, in generale, piacevole, perché consiste in uno stordimento della ragione, in un annebbiamento delle domande del cuore.
“Il desiderio del piacere diviene una pena, e una specie di travaglio abituale dell’anima. Quindi… un assopimento dell’anima è piacevole. I turchi se lo procurano coll’oppio, ed è grato all’anima perché in quei momenti non è affannata dal desiderio, perché è come un riposo dal desiderio tormentoso, e impossibile a soddisfar pienamente; un intervallo come il sonno nel quale se ben l’anima forse non lascia di pensare, tuttavia non se n’avvede”.
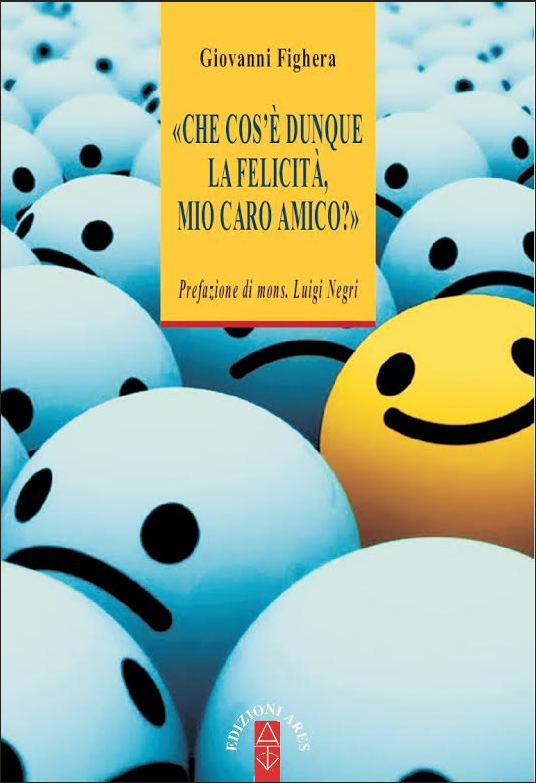 Nell’operetta morale “Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare” il protagonista nella sua solitudine del convento / manicomio di Sant’Anna è sovente allietato dalla presenza di uno spiritello che lui chiama genio familiare, che, come si scoprirà al termine del dialogo, gli appare dopo che lui ha bevuto qualche bicchiere di vino. A un certo punto il Genio spiega a Torquato che la vita dell’uomo è “intessuta” parte di dolore e parte di noia, la quale non è da intendersi se non come “il desiderio puro della felicità; non soddisfatto dal piacere, e non offeso apertamente dal dispiacere”. Tasso chiede allora quali siano i rimedi contro la noia, contro questo pungolo che non ci fa stare tranquilli, ma ci fa sospirare di desiderio, nel senso etimologico del termine (la parola desiderio da de sideribus ha a che fare con le stelle, proviene dalle stelle, come dire che è l’impronta che il Padre creatore ha posto nel cuore perché noi possiamo riconoscerlo, perché il nostro cuore possa palpitare di fronte a Lui). La risposta è “il sonno, l’oppio, il dolore”.
Nell’operetta morale “Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare” il protagonista nella sua solitudine del convento / manicomio di Sant’Anna è sovente allietato dalla presenza di uno spiritello che lui chiama genio familiare, che, come si scoprirà al termine del dialogo, gli appare dopo che lui ha bevuto qualche bicchiere di vino. A un certo punto il Genio spiega a Torquato che la vita dell’uomo è “intessuta” parte di dolore e parte di noia, la quale non è da intendersi se non come “il desiderio puro della felicità; non soddisfatto dal piacere, e non offeso apertamente dal dispiacere”. Tasso chiede allora quali siano i rimedi contro la noia, contro questo pungolo che non ci fa stare tranquilli, ma ci fa sospirare di desiderio, nel senso etimologico del termine (la parola desiderio da de sideribus ha a che fare con le stelle, proviene dalle stelle, come dire che è l’impronta che il Padre creatore ha posto nel cuore perché noi possiamo riconoscerlo, perché il nostro cuore possa palpitare di fronte a Lui). La risposta è “il sonno, l’oppio, il dolore”.
La società contemporanea sembra essere una fabbrica di assopimento dell’animo. L’oppio di cui parla Leopardi è la droga diffusa in tutte le sue forme nel mondo giovanile e anche in quello più adulto, le forme di felicità chimica, ovvero di stordimento e di distruzione graduale della ragione umana e del fisico. La droga sembra diventare abitudinaria accompagnatrice delle serate di chi vuole divertirsi, trattata come amica. A quale stordimento giunge spesso l’uomo!
L’assopimento è, spesso, procacciato attraverso l’alcool, attraverso l’ebbrezza che toglie ogni inibizione e che, nel contempo, stordisce. Molte pagine dello Zibaldone sono proprio dedicate a quella forma di assopimento dell’animo che è l’ebbrezza.
Il genio familiare cita, però, anche un altro espediente, il sonno, che si può intendere nel senso letterale del termine o in quello metaforico di fuga dalla realtà, costruzione di una campana di vetro all’interno della quale ripararsi e non vivere. Quante forme di sonno esistono, quante forme di annichilimento della coscienza vengono sovente adottate! Il sonno è da sempre l’emblema dell’assopimento della ragione tanto che Dante nel I canto dell’Inferno, quando spiega i motivi della sua situazione di difficoltà, di smarrimento, emblematicamente rappresentata dalla selva oscura, scrive:
“Io non so ben ridir com’i’ v’intrai
tant’era pien di sonno a quel punto
che la verace via abbandonai”.
(Inferno, I, 10-12)
Il sonno è la migliore rappresentazione, qui, di chi ha smarrito il senso del vivere, di chi non sa perché alzarsi al mattino: è la situazione che Teilhard De Chardin denuncia come il male più grave che possa temere l’umanità, non già la peste, un disastro naturale, ma una piaga ancor più grave, ovvero la perdita del gusto di vivere. Il sonno è, però, senza ricorrere ad una lettura metaforica, la via immediata cui molti ricorrono per stare meno male. Non a caso chi si sente depresso si rifugia spesso nel dormire.
Eppure, l’animo spesso predilige “forme di assopimento dell’animo” più vitali. Quest’ultima può sembrare un’espressione ossimorica e paradossale, ma non lo è: infatti, l’uomo, spesso, volendosi illudere di vivere e pensando che l’intensità della vita dipenda dalla quantità di attività, si riempie le giornate di occupazioni, satura ogni spazio vuoto, eliminando le occasioni per pensare e per domandarsi.
“La vita continuamente occupata è la più felice, quando anche non sieno occupazioni e sensazioni vive, e varie. L’animo occupato è distratto da quel desiderio innato che non lo lascerebbe in pace, o lo rivolge a quei piccoli fini della giornata (il terminare un lavoro, il provvedere ai suoi bisogni ordinari, ec. ec. ec.) giacché li considera allora come piaceri (essendo piacere tutto quello che l’anima desidera), e conseguitone uno, passa a un altro, così che è distratto da desideri maggiori, e non ha campo di affliggersi della vanità e del vuoto delle cose e la speranza di quei piccoli fini … bastano a riempirlo, e a trattenerlo nel tempo del suo riposo”.
Leopardi è, però, ben cosciente dell’inganno del divertimento e dell’occupazione continua della propria giornata con mille attività. Scrive, infatti, nello Zibaldone:
“Né la occupazione né il divertimento qualunque, non danno veramente agli uomini piacere alcuno. Nondimeno è certo che l’uomo occupato o divertito comunque, è manco (meno) infelice del disoccupato, e di quello che vive vita uniforme senza distrazione alcuna… Occupata o divertita (sottointeso la vita), ella si sente e si conosce meno, e passa, in apparenza più presto, e perciò solo, gli uomini occupati o divertiti, non avendo alcun bene né piacere più degli altri, sono però manco infelici: e gli uomini disoccupati e non divertiti, sono più infelici, non perché abbiano minori beni, ma per maggioranza di male, cioè maggior sentimento, conoscimento, e diuturnità (apparente) della vita,…”.
La frenetica vita di oggi sembra la paradigmatica rappresentazione di una risposta che la società contemporanea ha dato alla questione della felicità, risposta pilotata dal potere che induce falsi bisogni e li pone come esigenze fondamentali dell’io. Siamo bombardati da messaggi che ci inducono a pensare in positivo per la moltitudine dei beni di consumo che l’uomo può ottenere, siamo immersi nella civiltà che ci gestisce il tempo libero ora per ora, come nei villaggi turistici dove il nostro divertimento è sentirci dire cosa fare e come occupare le nostre giornate. Riempire il vuoto, mettere a tacere l’horror vacui, che provoca un senso di vertigine, è la parola d’ordine attuale. I più, nella propria “sperdutezza” e dimenticanza, non si avvedono neppure di non essere liberi in questo modo di agire, presuppongono di stare bene, semplicemente perché non sentono più la domanda. Paradossalmente una montagna di piaceri sommerge il vero desiderio.
È ancora Dante a ben descrivere la situazione antropologica e questa tendenza dell’uomo a distrarsi in falsi e piccoli beni nel primo canto del Paradiso. Il Fiorentino si trova nel Paradiso terrestre. Dopo aver fissato il suo sguardo in quello di Beatrice, che è rivolta verso l’alto, il nostro protagonista inizia a vedere una luce straordinariamente intensa e a sentire una musica non terrena. A lui che chiede come ciò possa accadere Beatrice risponde che lui non si trova più in Terra, ma sta salendo verso l’alto. A questo punto il suo stupore si fa ancor più grande. Lei allora gli spiega che
“… le cose tutte quante
hanno ordine tra loro, e questo è forma
che l’universo a Dio fa simigliante.
Qui veggion l’alte creature l’orma
de l’etterno valore, il qual è fine
al quale è fatta la toccata norma.
Ne l’ordine ch’io dico sono accline
tutte nature, per diverse sorti,
più al principio loro e men vicine…”.
(vv. 103-111)
Ovvero ogni cosa tende ad un ordine, che è l’orma, l’impronta del creatore nella creatura e nel creato. L’uomo tende al bene, perché vuole tornare da Colui da cui deriva, porta impresso il sigillo di Colui che l’ha fatto e questo sigillo è il cuore, che domanda il bene, il bello, il vero, l’amore, il giusto, … Infatti, nella Bibbia c’è scritto che “Dio creò l’uomo a sua immagine” (Genesi 1, 27).
“La provedenza, che cotanto assetta,
del suo lume fa ‘l ciel sempre quieto
nel qual si volge quel c’ha maggior fretta;
e ora lì, come a sito decreto,
cen porta la virtù di quella corda
che ciò che scocca drizza in segno lieto.”
(vv. 121-126)
Il destino dell’uomo è, quindi, buono, positivo, l’uomo tende per natura al bene. Perché allora spesso ci si perde nel divertissement, in beni effimeri e si passa dall’uno all’altro dimenticandoci che siamo fatti per altro? Beatrice per rispondere adduce l’esempio della materia che, talvolta, è restia ad adattarsi alle intenzioni dell’artista.
“Vero è che, come forma non s’accorda
molte fiate a l’intenzion de l’arte,
perch’a risponder la materia è sorda,
così da questo corso si diparte
talor la creatura, c’ha podere
di piegar, così pinta, in altra parte…”.
(127-132)
È il dramma della libertà, per cui “l’impeto primo” (questa naturale tendenza la bene) può indirizzare il nostro sguardo verso dei beni (di piccolo conto), “torto da falso piacere”, ovvero ingannato da un piacere non vero che non può soddisfare il nostro cuore.
Così, passiamo da un piacere all’altro, così come il Don Giovanni, per lo meno quello che tanta letteratura ci ha tramandato, da Tirso da Molina a Moliere, da Mozart a Hoffmann. Come, però, ben ci sottolinea il primo quadro del Miguel Manara di Oscar Milosz (l’unica opera che ci presenta il personaggio nella sua profondità e grandezza e nel contempo ci descrive la sua storia integralmente), Don Giovanni non è contento della vita che conduce. Quando gli amici lo esaltano e lo ritengono fortunato, lui risponde che non lo comprendono perché la sua anima è infelice e lui cambia donna solo perché è insoddisfatto. Come cambia la statura umana quando è cosciente della sproporzione tra ciò che vive e ciò che desidera!
Nei Pensieri Pascal definisce questo atteggiamento umano di distrazione con il termine divertissement. L’espressione nel suo significato etimologico (dal latino divertere cioè volgere qua e là, lontano dalla strada principale, dal solco tracciato) ben designa il tentativo, coscientemente o incoscientemente perpetrato, di strapparci dal nostro cuore originario, sede delle domande più autentiche sul significato e sul senso delle cose, attraverso distrazioni, palliativi, piaceri surrogati della felicità che hanno come conseguenza quella di alienarci, di allontanarci da noi stessi, di renderci estranei a noi stessi, di essere sempre fuori da noi così che “la nostra casa risulta disabitata”.
Per questo Pascal scrive:
“Nulla è tanto insopportabile per l’uomo quanto lo stare in riposo completo, senza passioni, senza preoccupazioni, senza svaghi, senza applicazione. Allora sente il suo nulla, il suo abbandono, la sua insufficienza, la sua dipendenza, la sua impotenza, il suo vuoto. Immediatamente dal fondo della sua anima verranno fuori la noia, la tetraggine, la tristezza, l’affanno, il dispetto, la disperazione”.
Pascal ancora scrive che quasi tutti i pericoli e le pene in cui incorre l’uomo derivano dal “non saper restare tranquilli in una camera. Un uomo che ha abbastanza per vivere, se sapesse restare in casa con piacere, non ne uscirebbe per navigare o per correre all’assedio di una fortezza”. Il Filosofo ci invita a pensare alla condizione del re (“lo stato migliore del mondo”), circondato da tutte le soddisfazioni che possono appagarlo. Se il sovrano è lasciato, però, senza “divertissement” incomincerà a riflettere sulla sua condizione, alle rivolte che possono accadere, alle eventuali guerre, alla morte e alla malattia, cosicché “se egli è privo di quel che si chiama divertimento, diventa infelice e più infelice dell’ultimo dei suoi sudditi, che gioca e si diverte”.
Quindi, spesso, “l’unico bene degli uomini consiste nell’essere distolti dal pensare alla loro condizione mediante una qualsiasi attività, o una piacevole e nuova passione che li afferri, oppure mediante il gioco, la caccia o qualche interessante spettacolo”.
L’uomo passa, così, da un piacere all’altro senza sosta, rimanendo deluso in continuazione, ma sopperendo a questo disinganno con l’immensa varietà dei piaceri. Spesso, non ha tempo di stancarsi dei piaceri, poiché vi si sofferma troppo poco e non ha lo spazio per riflettere sull’incapacità di essi a felicitarci. Ecco perché sovente, invece di approfondire i rapporti, si preferisce passare da un’amicizia all’altra, da un rapporto sentimentale all’altro nella paura che si possa altrimenti cogliere l’inganno di chi affida la felicità ad un bene (come idolo) oppure già nel puro cinismo che fa di ogni cosa un nulla, privo di significato e quindi bene interscambiabile. L’idolatria è l’altra faccia della medaglia su cui è rappresentata la cinica violenza di distruzione dei beni in una spietata iconoclastia: l’idolatria produce la stessa distruzione dell’idolo, quando l’uomo verifica la sua inadeguatezza e, quindi, lo distrugge e lo cambia in un altro idolo.
Come si passa da un bene all’altro, così si passa anche da un luogo all’altro, come i ragazzi al sabato sera, in modo da riempire quelle lunghe ore della notte che si vorrebbero interminabili, ma che non si sa come trascorrere.
Leggendo queste righe, i più di noi saranno tentati di autoescludersi da questi tentativi di assopire il nostro animo, pensando che droghe, alcool, moltitudini di piaceri riguardino forse altri, non noi. Qualora anche la nostra coscienza non ci facesse riconoscere in queste forme di assuefazione, forse non siamo immuni dalla più comune delle smemoratezze, da quella borghesizzazione della vita, da quel desiderio di una “vita tranquilla da divano e televisione” che ci lascia pensare che noi abbiamo già compiuto il nostro dovere, perché abbiamo lavorato ed è, quindi, giusta e meritata la serata di pura dimenticanza, come la vacanza del dolce far niente dopo un anno in cui le giornate sono state saturate dal lavoro e dall’iperattività. È la condizione del gregge, descritta da Leopardi nel “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”, un gregge che può oziare senza sentire il pungolo della noia, senza avvertire che siamo nati per Altro, per una felicità piena. Il Poeta, così, si esprime nei suoi confronti:
“Quanta invidia ti porto!
Non sol perché d’affanno
Quasi libera vai;
Ch’ogni stento, ogni danno,
Ogni estremo timor subito scordi;
Ma più perché giammi tedio non provi.
Quando tu siedi all’ombra, sovra l’erbe,
Tu se’ queta e contenta;
E gran parte dell’anno
Senza noia trascorri in quello stato”.
Il gregge siamo tutti noi quando soffochiamo le domande sulla vita, quando preferiamo il quieto vivere, quando pensiamo nell’intimo del nostro cuore (senza magari osare confessarlo) che tanto la felicità vera non esiste e che convenga, quindi, godersi la tranquillità senza chiedere di più dalla vita, dagli amici, dal rapporto con la moglie o la fidanzata. Il monito dei Dante è, però, severo e risuona nelle nostre orecchie attraverso la voce di Ulisse:
“Fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza”.



1 commento
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono chiusi.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!