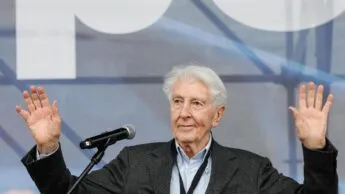
La crisi come condizione stabile nell’epoca del neoliberismo


Articolo tratto dal numero di Tempi in edicola (vai alla pagina degli abbonamenti) – Secondo quanto ricordato da Michel Foucault nella Naissance de la biopolitique, la formula “vivere pericolosamente” (vivre dangereusement) può essere elevata a massima del liberismo o, con le parole stesse del pensatore francese, a «marchio esistenziale interiorizzato dalla soggettività costruita dalla governamentalità liberale». Nel quadro del regime neoliberale, «gli individui sono messi continuamente in stato di pericolo o, meglio, sono posti nella condizione di esperire la loro situazione, la loro vita, il loro presente, il loro avvenire, eccetera, come fattori di pericolo»: il rischio d’impresa si socializza alla società tutta, dà luogo a una sorta di economia del rischio che non conosce nulla di esterno a sé. Tutto diventa a tempo determinato, in una condizione di perenne pericolo.
La crisi economicida scaturita nel 2007, in questo senso, non è che la “pericolosità” politica e sociale analizzata dal punto di vista sistemico della produzione e del mondo della vita. Il pericolo al quale rimanda il sintagma vivre dangereusement coincide non tanto con quello esterno, quanto piuttosto con quello interno del rovescio economico e dello sconvolgimento della vita quotidiana. La liquidità universale del tempo flessibile si caratterizza, appunto, per la pericolosità che ubiquitariamente la innerva. Induce i soggetti a percepire il presente e l’avvenire come stabilmente incerti e a rischio, precari e non soggetti a garanzie di alcun genere.
La destabilizzazione dell’esistenza
Ancora una volta, in accordo con una delle riserve di senso racchiuse nell’etimo greco, la chrisis alludeva, nella medicina antica, al momento decisivo in cui il medico stabiliva se il paziente sarebbe sopravvissuto. Nel senso odierno, invece, la crisi smarrisce il suo carattere di momento decisivo e assume un’inedita permanenza nel tempo. Diventa essa stessa, con l’insicurezza che strutturalmente la connota, stabile condizione dell’esistenza e della produzione, entrambe destabilizzate nella nuova forma della precarietà o, se si preferisce, dell’assestamento sempre differito: va a occupare anche le regioni del futuro, soggette a un’incertezza fisiologica che le rende strutturalmente inabitabili e non colonizzabili mediante progetti. Costringe a vivere l’oggi in forma necessariamente sconnessa rispetto al domani, segmentando la temporalità e spezzando quella continuità che è condizione tanto per la stabilizzazione dell’esistere, quanto per la programmazione progettuale del futuro.
Il momento critico cessa di essere istantaneo e transeunte, com’era per i medici greci, e assume i tratti macabri di una condizione di stabilizzata instabilità e di precarietà a tempo indeterminato, funzionale alla produzione e alle sue logiche politicamente non neutre. Secondo la dinamica propria dell’ideologia, la crisi corrisponde alla naturalizzazione di una dinamica sociale e politica. Più precisamente, permette di naturalizzare, presentandolo come se fosse un processo neutro e irreversibile, dato a prescindere dalla volontà degli attori sociali, quella che, in realtà, è un’aggressione intenzionale dei dominanti ai danni dei dominati: aggressione che, per potersi dispiegare, necessita della destabilizzazione deeticizzante del mondo borghese e proletario, ossia dell’annichilimento programmatico delle strutture stabili che variamente proteggevano le esistenze dalla sussunzione integrale sotto il capitale.
Una sola strada possibile
Coerente con la rivolta delle élite finanziarie plutocratiche, la scelta politica di rimuovere i fondi all’ambito sociale, di ridurre i salari e di precarizzare il lavoro viene naturalizzata mediante il dispositivo della crisi: la si trasforma ideologicamente in una condizione oggettivamente richiesta dalle circostanze emergenziali. Al soggetto non è oggi autoritariamente imposto di agire in un determinato modo. Semplicemente, le leggi dell’economia lo pongono nella condizione di non poter fare altrimenti, secondo la cifra stessa della mano invisibile della violenza immanente. Di più, l’ordine entropico della mondializzazione lascia che gli individui credano di fare liberamente ciò che il sistema stesso li ha messi nelle condizioni di non poter non fare: la libertà diventa il nome illusorio che si attribuisce alla “libera” adesione individuale a ciò che è sistemicamente imposto.
Il controllo oggi non è coercitivo, poiché preordina, tramite l’actio in distans, lo spazio delle possibilità d’azione e di pensiero degli individui. Non impone una direzione con la forza, di modo che gli individui non seguano le altre possibili: semplicemente, nega queste ultime, affinché ne resti una sola.
Foto Ansa



0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!