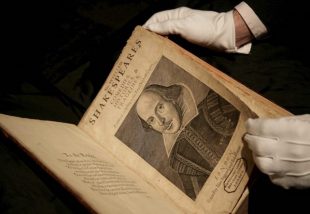
La città de “L’amica geniale” è così tragica che non sembra neanche Napoli

Articolo tratto dal numero di Tempi di aprile 2019
Ho letto i quattro volumi della serie dell’Amica geniale di Elena Ferrante. Un’opera monumentale che abbraccia tutto l’arco storico della mia vita e questo è già un elemento d’interesse. Sullo sfondo c’è l’Italia del miracolo economico, del terrorismo, di Mani pulite fino ai nostri giorni. La Napoli descritta è la mia Napoli, anche quella dei quartieri “difficili” che ho frequentato per tutti gli anni Sessanta percorrendo le strade di Forcella mentre facevamo studiare i ragazzi della zona in un doposcuola che ci metteva in contatto con le problematiche familiari.
Il romanzo, anzi la saga, è avvincente con colpi di scena successivi che lo rendono adatto alla sceneggiatura della serie tv che verrà realizzata, sembra, da Saverio Costanzo, il regista che ha firmato il successo delle prime otto puntate. La penetrazione psicologica della personalità delle due amiche ricorda i grandi romanzi russi e induce a escludere che sotto lo pseudonimo di Elena Ferrante ci sia un uomo. Solo una donna può essere capace di rendere tante sfumature di sentimenti e stati d’animo. In sintesi, un’opera colossale da considerare con rispetto.
Per amore verso Napoli devo rilevare che, anche se si citano zone e storie della città, il romanzo sembra poco napoletano. Non c’è un sorriso, una battuta di spirito, come capita di osservare sempre in città, in qualsiasi quartiere. Non si canta mai, mentre negli anni descritti era inconcepibile che una donna in casa o un operaio al lavoro non cantasse o fischiettasse. Non si mangia niente di sfizioso, in una città dove c’è povertà ma molta fantasia nel mangiare poco ma con gusto. Il romanzo non avrebbe richiesto modifiche se fosse stato ambientato nel retroterra di Reggio Calabria. Un senso tragico, quasi violaceo, accompagna tutta la lettura accentuandosi nel finale. La cultura napoletana, com’è evidente all’osservatore o traspare dalla letteratura, ha la caratteristica di trasformare in farsa anche la più cupa tragedia. Lo testimoniano i gialli di un altro scrittore napoletano contemporaneo, Maurizio di Giovanni, anche lui diventato autore televisivo.
Il punto fondamentale per me è che questa lettura mi ha confortato oltre che coinvolto. Mi ha fatto vedere con chiarezza come una vita vissuta senza alcun riferimento soprannaturale si trasforma in una vita infelice. Tutti proviamo sentimenti, passioni che ci sbatterebbero qui e là se non ci fosse un riferimento, un punto fermo nel Creatore. La creatura sta bene quando è in relazione col Creatore anche se è soggetta a mancanze e deviazioni. Ma il Padre nostro accetta i nostri ritorni e ci conforta. Non sto parlando delle pratiche religiose, di cui ci sono rari riferimenti nel romanzo: battezzare o no un bambino, la Messa domenicale… Alludo alle domande profonde che un essere umano si pone: che senso ha la vita? Cosa ci sarà dopo la morte? Dio esiste o no? Negli anni Sessanta un mio amico militante marxista ripeteva, con disciplina di partito, che queste domande non bisogna nemmeno porsele, vanno eliminate sul nascere. Sembra che la scrittrice si sia formata in questa cultura. L’unica dimensione umana ammessa è quella politica, sociale ed economica con in più la problematica femminista. Finito.
In questo clima le persone si muovono allo sbando dominate dai propri appetiti, sentimenti, tendenze. Lo studiare, tema rilevante nel libro, non è concepito come contemplazione del vero, ma come leva di riscatto sociale oppure evasione dal dramma quotidiano, il che è giusto ma non può essere limitato a questo. C’è come una cappa sull’umanità descritta che impedisce di volgere lo sguardo verso l’alto.
In sostanza il grande racconto conferisce al credente un’arma, la possibilità di dire: “Io so che cos’è la felicità. Non si trova nella vita dei personaggi del libro. Così emerge un messaggio implicito: vale la pena conoscere l’amore conseguente al dono di sé, che porta a tenere a freno la pazza fantasia che cova dentro di me e a rispettare col sorriso gli impegni presi, le responsabilità che derivano dall’amore vero”.
Foto Ansa



0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!