
Il Deserto dei Tartari
La catastrofe delle élite

Oramai nel dibattito politico la contrapposizione decisiva non è più fra destra e sinistra, progressisti e conservatori, liberali e socialisti; non è nemmeno realmente fra sovranisti ed europeisti, popolo ed élite, globalisti e antiglobalisti. La vera contrapposizione è fra chi cerca di capire perché si sia prodotta la contrapposizione fra popolo ed élite, perché la reazione alla globalizzazione sia stata l’ascesa politica del populismo, che oramai non è solo politica, ma riguarda lo stesso senso comune della gente e chi si accontenta di dire che non bisogna votare per i sovranisti perché la globalizzazione economica, l’immigrazione di massa, l’integrazione europea sotto l’egida della Ue sono inevitabili.
La vera contrapposizione è fra chi crede (o più spesso finge di credere) che è tutta colpa delle “fake news”, delle interferenze degli hacker di Mosca, dell’egoismo, dell’ignoranza, del razzismo aperto o latente dei popoli europei, delle “riforme che non sono state fatte”. E chi invece crede che la traiettoria imboccata dall’Occidente all’indomani della fine della Guerra fredda non poteva che portare a questa situazione, dalla quale non sappiamo bene come uscire; senz’altro non ne usciremo seguendo le indicazioni dei politici organici all’establishment: Emma Bonino, Giorgio Napolitano, Mario Monti, il Pd tutto intero.
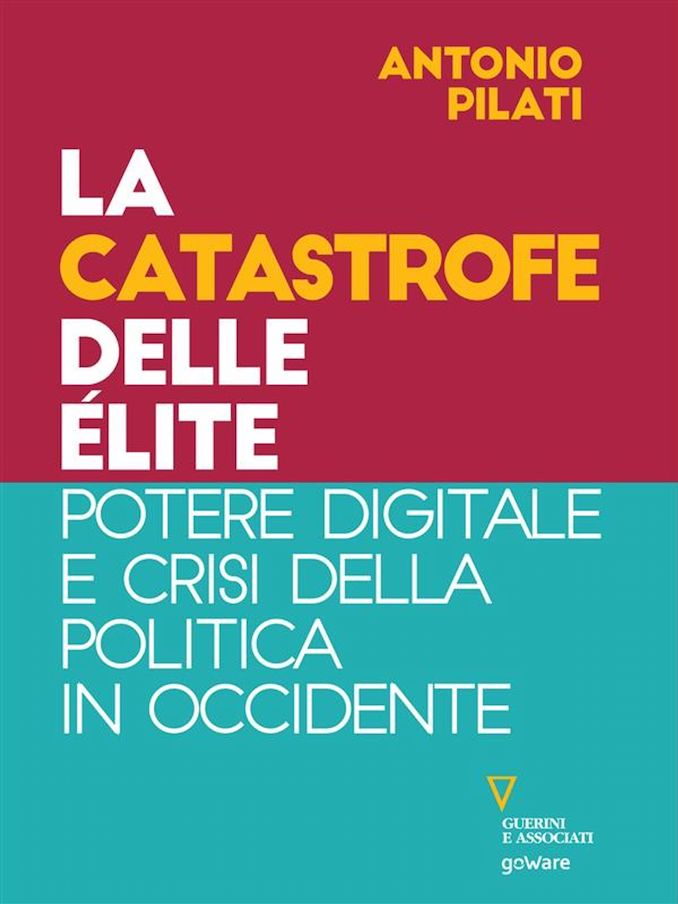 Sull’argomento della frattura fra popolo ed élite stanno uscendo decine di libri in questo momento, molti sono in francese e in inglese e non sono stati ancora tradotti in italiano. Dovendo economizzare tempo e soldi, consiglio di cominciare con La catastrofe delle élite – Potere digitale e crisi della politica in Occidente di Antonio Pilati, edito da Guerini e appena uscito in libreria. Un libretto di sole 144 pagine che ripercorre e sintetizza tutti i passaggi – tecnologici e politici, internazionali e nazionali – che ci hanno portati allo stato di cose presente, che l’autore fotografa col titolo del suo lavoro. Le pagine sul modo in cui le tecnologie informatiche hanno rivoluzionato l’economia, i rapporti umani e la politica sono un po’ ostiche perché sono quelle dove maggiormente si esprimono le competenze professionali dell’autore (che è stato componente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e del Consiglio di Amministrazione della Rai). Ma sono anche quelle che meglio giustificano la tesi del libro.
Sull’argomento della frattura fra popolo ed élite stanno uscendo decine di libri in questo momento, molti sono in francese e in inglese e non sono stati ancora tradotti in italiano. Dovendo economizzare tempo e soldi, consiglio di cominciare con La catastrofe delle élite – Potere digitale e crisi della politica in Occidente di Antonio Pilati, edito da Guerini e appena uscito in libreria. Un libretto di sole 144 pagine che ripercorre e sintetizza tutti i passaggi – tecnologici e politici, internazionali e nazionali – che ci hanno portati allo stato di cose presente, che l’autore fotografa col titolo del suo lavoro. Le pagine sul modo in cui le tecnologie informatiche hanno rivoluzionato l’economia, i rapporti umani e la politica sono un po’ ostiche perché sono quelle dove maggiormente si esprimono le competenze professionali dell’autore (che è stato componente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e del Consiglio di Amministrazione della Rai). Ma sono anche quelle che meglio giustificano la tesi del libro.
Di esso due sottolineature in particolare trattengo: la prima è lo stridente contrasto fra l’ideale del mondo tutto diritti e niente frontiere promosso dalle élite globaliste-europeiste e la realtà di precarietà, insicurezza, diseguaglianza, perdita dei punti di riferimento antropologici che la maggioranza dei cittadini patisce; la seconda è, in Italia, il progressivo affidamento delle politiche di bilancio, monetaria e di governo dell’economia ai vincoli esterni rappresentati dall’Europa, dai mercati finanziari, dalla magistratura e dalle Corti nazionali e internazionali e dalle Authority, col conseguente esautoramento della politica e il trasferimento di potere all’establishment tecnocratico, nazionale ed europeo, che non ha prodotto risultati virtuosi. Sono questi i due fenomeni che hanno generato la cosiddetta ondata populista.
Cosa è successo, in sostanza? Che la fine della Guerra fredda ha liberato le tecnologie informatiche per l’uso civile. Internet, nato come tecnologia militare di sicurezza nazionale poi trasferita alle università, è diventata la spina dorsale di una rivoluzione economica, culturale e politica. Dell’innovazione tecnologica si è appropriato il sistema economico capitalista che ha razionalizzato procedure e incrementato profitti attraverso la disintermediazione, la delocalizzazione e il vantaggio competitivo delle imprese nate digitali rispetto a quelle nate analogiche. Questa trasformazione dei modi di produzione si è giustificata con una nuova ideologia, quella dei diritti che non devono avere frontiere: uomini e merci, migranti e generi sessuali, imprese e finanza, culture e religioni, devono poter muoversi liberamente attraverso il pianeta, insediarsi dove vogliono, aggregarsi come desiderano con pieno riconoscimento giuridico e piena accettazione sociale.
Di ideologia però trattasi; e come il liberalismo è stato l’ideologia con cui la borghesia industriale ha giustificato la propria ascesa economica e politica, così il globalismo e l’europeismo oggi incarnano l’ideologia con cui le élite tecnocratiche giustificano la propria egemonia che cancella il ruolo della politica, interamente sostituita dai vincoli tecnici, finanziari e giuridici gestiti dalle burocrazie della tecno-struttura. Come la borghesia alla fine del XIX secolo, anche le élite tecnocratiche beneficiano una base sociale troppo ristretta: solo una piccola quota di laureati specializzati di materie tecniche e scientifiche trae vantaggio dal nuovo assetto; la maggioranza dei cittadini vede peggiorare le proprie condizioni economiche ma soprattutto esistenziali: il loro futuro appare sempre più cupo, incerto, sradicato. E siccome i partiti socialdemocratici, cristiano-democratici e progressisti si sono gettati fra le braccia di questo pensiero unico, il popolo li abbandona e vota per gli eversori dell’ordine.
Scrive Pilati:
«L’ideologia dei diritti, dominante nelle università e tra chi vive una dimensione cosmopolita, diverge ormai stabilmente dal senso comune della popolazione lontana dalle reti globali. Se l’una accentua la propria forza assertiva e l’altro è sostenuto da eventi eclatanti che cambiano la stessa vita quotidiana, si crea nella società una frattura che in tempi brevi trova sbocco politico. Quando i pronipoti di Maria Antonietta, che hanno messo da parte abbondanti scorte di brioche, non temono di fare la morale ai “deplorables” (Hillary Clinton) o ai “sans dents” (Hollande) che faticano a procurarsi la baguette quotidiana, allora Brexit e Trump sono alle porte». «La radice della trasformazione è, con evidenza, il sentimento di esclusione che colpisce quella parte di elettori impoveriti dalle ricadute dell’espansione globale dei mercati e minacciati nei loro sentimenti dal disordine politico (terrorismo, immigrazione fuori controllo) diffuso ai confini dell’Europa. In ciò si mostra il carattere esistenziale della crisi: la crescente invadenza della burocrazia di Bruxelles, unita a politiche fiscali e monetarie disegnate con ipocrisia dagli Stati del nucleo franco-tedesco a proprio vantaggio, suscita nel resto d’Europa reazioni di autodifesa identitaria. L’Unione monetaria, nata per promuovere la convergenza delle economie nazionali, non solo provoca crescenti divaricazioni nel suo campo d’origine ma scatena processi di divisione strategica e istituzionale. La politica, che gli algoritmi dell’unificazione monetaria pensavano di circoscrivere, rivive in chiave nazionale e accentua, per questa via, le differenze fra gli Stati del continente».
Alla presentazione del libro di Pilati al Teatro Franco Parenti di Milano il 25 febbraio scorso (con la partecipazione del presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri, dello storico Marco Gervasoni, di Alessio Lanzi del Consiglio superiore della magistratura e di Gianmarco Senna consigliere regionale lombardo) l’autore ha sottolineato che il senso del libro è un richiamo al protagonismo della politica nel governo della rivoluzione che le nuove tecnologie producono nell’economia. «In questi ultimi 25 anni le democrazie non hanno guidato il cambiamento e la Unione Europea è diventata palestra di egoismi nazionali. Possiamo affrontare i problemi solo se la politica torna a guidare i processi». Questo evidentemente sottintende che non si può continuare a cedere sovranità ai mercati finanziari, all’Unione Europea a trazione tedesca, alla magistratura nazionale, alle Corti internazionali, all’Onu. Ma di questo – che è il secondo tema del libro che più mi ha colpito, il tema del “vincolo esterno” con cui l’establishment italiano attraverso il Pd e Mario Monti ha cercato di svuotare la politica e sostituirla con la tecnica – parleremo un’altra volta.
Quel che vorrei dire qui è che il ritorno della politica nel ruolo di protagonista del governo delle cose non potrà avere successo se non sarà più radicale di quello che Pilati, i sovranisti e anche i progressisti illuminati alla Federico Rampini dicono, pensano e propongono. Stiamo vedendo coi nostri occhi che il tentativo di riaffermare il potere d’indirizzo della politica nei riguardi dell’economia non miete successi: ora che l’establishment è stato mandato all’opposizione l’economia è alla stagnazione, l’indebitamento cresce e la disoccupazione non diminuisce. Al di là delle ragioni contingenti, il motivo di fondo è che l’economia capitalista globalista si avvale delle opportunità che l’innovazione tecnologica gli offre, e queste sono molto più veloci e pervasive delle decisioni politiche.
Il passaggio epocale, allora, dovrebbe consistere non tanto nella restaurazione della sovranità politica nazionale democratica sull’economia, ma in una rivoluzione democratica e comunitaria dove è lo sviluppo delle tecnologie a ricadere sotto la sovranità popolare. Le nuove tecnologie dovrebbero entrare in produzione solo quando la loro applicazione ha vantaggi per tutta la comunità, e non solo per le élite. Il bene comune, e in particolare la tutela della coesione sociale e delle condizioni di esistenza delle comunità reali, dovrebbe essere il criterio con cui si introduce nel sistema una nuova tecnologia, e non quello che si decide nei consigli di amministrazione di Google, Apple, Facebook, Amazon, Netflix, ecc. Tutti i consigli di amministrazione di tutte le grandi imprese basate sull’innovazione tecnologica dovrebbero integrare per legge rappresentanti degli interessi sociali. La ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica non dovrebbero più essere appannaggio di gruppi ristretti. Consigli di amministrazione politicizzati sarebbero un freno all’innovazione? Meglio un rallentamento dell’innovazione, che permetta di preservare il capitale sociale, piuttosto che le attuali continue accelerazioni che stanno distruggendo il tessuto della società.
Foto Ansa



0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!