
“La caduta di Artù”, il libro incompiuto di Tolkien che narra l’infinita e radicale lotta tra bene e male
Tratto dall’Osservatore Romano – J.R.R. Tolkien è il padre indiscusso della narrativa fantasy moderna. Il suo nome è associato indelebilmente alla trilogia Il Signore degli Anelli e a Lo Hobbit. I piccoli, infaticabili omini della Contea negli ultimi anni sono diventati i beniamini delle nuove generazioni grazie alle fatiche cinematografiche del regista Peter Jackson. Così il nome del professore di Oxford, i suoi nani, i suoi elfi e i suoi Nazgul sono entrati prepotentemente anche nell’immaginario collettivo dei nativi digitali.
Tuttavia, parallelamente a questa encomiabile e produttiva opera di rivitalizzazione dell’opera tolkieniana attraverso cinema e videogiochi, è proseguita instancabile l’azione di analisi e riscoperta filologica dell’opera dell’autore da parte di Christopher Tolkien, il suo ultimogenito, a cui l’autore della trilogia dell’Anello affidò per via testamentaria l’incarico di esecutore letterario. Il più giovane dei Tolkien, ora ultraottantenne, si preoccupò di portare alla luce un particolare aspetto degli studi compiuti in vita dal padre e legato al suo straordinario amore per il verso allitterativo tipico dell’antica letteratura norrena. Conoscendo questo singolare interesse di John Tolkien per la lingua dei popoli celtici non stupisce la cura con cui egli costruì le regole linguistiche dei popoli della Terra di Mezzo forgiate attraverso fantasia e tradizione su un solidissimo piano di conoscenze filologiche. Tolkien padre provò più volte a sperimentare l’uso del verso allitterativo per realizzare componimenti poetici, qualche volta riuscendo a terminare l’opera come in Sir Gawain and the Green Knight in cui riuscì a rendere il verso allitterativo del XIV secolo in un metro analogo in inglese moderno, qualche volta arrivando a un passo dalla fine. È questo il caso de La caduta di Artù, poema inedito e incompiuto appunto, che Bompiani ha pubblicato di recente nella traduzione di Sebastiano Fusco e la cura di Gianfranco De Turris, uno dei massimi esperti mondiali dell’opera di Tolkien. Una iniziativa preziosa nell’obiettivo perché ha permesso di mandare alle stampe un inedito di Tolkien a oltre quarant’anni dalla morte ma preziosa anche nel cammino perché ha permesso di mettere in luce un aspetto poco conosciuto dell’autore britannico e sicuramente più legato alla sua attività accademica di studioso di lingue e letterature medioevali.
 De La caduta di Artù si parla per la prima volta in una lettera del 1955 anche se non c’è alcuna indicazione che chiarisca quando l’opera fu cominciata e quando Tolkien decise di abbandonarla. A proposito dei motivi per cui l’iniziativa subì uno stallo ci viene in aiuto Christopher Tolkien quando, nella prefazione all’opera scrive «per i motivi dell’abbandono di tali tentativi ambiziosi quando erano già molto avanti nella loro stesura, si può far riferimento alle circostanze della sua vita dopo il conseguimento della cattedra di Anglo-Sassone a Oxford nel 1925; gli impegni derivanti dalla sua posizione e dalle sue ricerche accademiche, e inoltre le necessità, le preoccupazioni e le spese legate alla famiglia». Detta così potrà sembrare singolare. Di solito si tende a considerare un grande autore lontano dalle incombenze della vita quotidiana ma il fatto che Tolkien possa aver interrotto progetti letterari per pensare ai suoi cari e a ciò che di più importante aveva al mondo, cioè la famiglia, conferisce ai messaggi etici e morali che emergono dalle sue opere una forza ancora più vivida.
De La caduta di Artù si parla per la prima volta in una lettera del 1955 anche se non c’è alcuna indicazione che chiarisca quando l’opera fu cominciata e quando Tolkien decise di abbandonarla. A proposito dei motivi per cui l’iniziativa subì uno stallo ci viene in aiuto Christopher Tolkien quando, nella prefazione all’opera scrive «per i motivi dell’abbandono di tali tentativi ambiziosi quando erano già molto avanti nella loro stesura, si può far riferimento alle circostanze della sua vita dopo il conseguimento della cattedra di Anglo-Sassone a Oxford nel 1925; gli impegni derivanti dalla sua posizione e dalle sue ricerche accademiche, e inoltre le necessità, le preoccupazioni e le spese legate alla famiglia». Detta così potrà sembrare singolare. Di solito si tende a considerare un grande autore lontano dalle incombenze della vita quotidiana ma il fatto che Tolkien possa aver interrotto progetti letterari per pensare ai suoi cari e a ciò che di più importante aveva al mondo, cioè la famiglia, conferisce ai messaggi etici e morali che emergono dalle sue opere una forza ancora più vivida.
Per comprendere il senso del poema incompiuto appena dato alle stampe occorre ricordare dunque la profonda tradizione cattolica della famiglia del professore di Oxford. La vicenda raccontata nel testo, come osserva De Turris nella postfazione, si svolge su tre livelli: uno umano, uno storico e uno metastorico. Sul livello umano si racconta la vicenda della tragica e illecita passione tra Lancillotto e Ginevra. Sul livello storico la capitolazione dei resti dell’impero romano devastato dalle invasioni barbariche.
Ma è il livello metastorico quello che ci interessa maggiormente. La tempesta che tutto sconvolge e rinnova è la cifra costante che Tolkien ha dato a La caduta di Artù. La tempesta che, nei quattro canti compiuti (il quinto è solo un inizio) è osservata dalle torri, dalle coste, è affrontata dai vascelli in mare e si abbatte con violenza sulle scogliere solo per lasciare, ritraendosi, un’alba livida e cupa come il velo di un sudario.
La tempesta che Tolkien richiama come vera protagonista del poema è indubbiamente la lotta radicale tra bene e male, fra l’ordine e il caos e fra il diritto e la sovversione. La lotta tra la normalità del relativismo e la magia dei valori non negoziabili. Una lotta che, scrive ancora De Turris, «è in ciascuno di noi e ciascuno di noi la combatte da solo ogni giorno, guidato unicamente dalla propria coscienza».
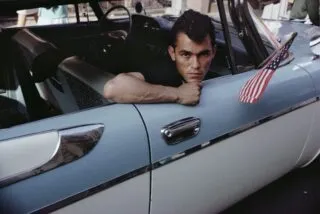


0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!