
Il tira-e-molla strategico di Trump con l’Iran

Scoppierà una guerra fra Stati Uniti e Repubblica islamica dell’Iran? Probabilmente no. Quello che la Guida suprema della rivoluzione iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, ha definito “il duello” in corso con gli Usa assomiglia più a una rischiosa mano di poker che a una marcia da sonnambuli verso la tragedia. Mano di poker voluta da Donald Trump e subìta dagli iraniani.
Il crescendo di azioni ostili contro Tehran iniziato dal presidente americano con la denuncia, nel maggio dello scorso anno, dell’accordo sul nucleare iraniano concluso nel 2015, proseguito con l’applicazione di pesantissime sanzioni economiche che hanno coinvolto anche gli alleati degli Stati Uniti nel novembre 2018, giunto al culmine con tre nuovi round di misure punitive contro i Guardiani della Rivoluzione e contro l’ayatollah Khamenei fra l’aprile e il giugno di quest’anno, va letto soprattutto in un’ottica di esigenze di politica interna dell’amministrazione Trump.
Meglio di Obama
Il presidente vuole dimostrare agli americani, in vista delle elezioni presidenziali del 2020, di essere in grado di concludere un accordo con l’Iran molto più ampio e severo di quello approvato da Barack Obama, che includerebbe una rinuncia esplicita dell’Iran alle armi atomiche e limitazioni ai suoi programmi missilistici, e che quindi tarperebbe realmente le ali a potenziali minacce nucleari e non nucleari provenienti dalla repubblica islamica.
L’escalation avviata nel maggio 2018 ha permesso fino ad oggi a Trump di rinsaldare i legami coi governi di Israele e Arabia Saudita, i due paesi che più si sono dichiarati contrari agli accordi internazionali del 2015 che vanno sotto l’acronimo Jcpoa e che hanno visto l’inedita convergenza di Usa, Russia, Cina e Unione Europea. Una scelta dovuta anche questa più a fattori di politica interna che a scelte strategiche di politica estera: la postura anti-iraniana ha fruttato all’amministrazione Trump lauti contratti per la vendita di armamenti americani a Riyadh e in prospettiva il voto di una quota crescente di ebrei americani alle prossime presidenziali (Trump è il presidente Usa del Dopoguerra che ha ricevuto meno voti dagli elettori appartenenti alla minoranza ebraica, ma con la decisione di trasferire l’ambasciata americana a Gerusalemme e di mettere alle corde l’Iran le cose dovrebbero cambiare sensibilmente alle presidenziali del 2020).
Negoziato oltre ogni decenza
Unione Europea e Russia per una volta sono d’accordo che l’accordo sul nucleare iraniano del 2015 rappresentava una garanzia sufficiente per la sicurezza regionale e globale che non andava rimessa in discussione, e che in ogni caso i negoziati con l’Iran non dovebbero essere condotti con mezzi come l’embargo sul petrolio e richieste irrealistiche come i “12 punti” elencati a mo’ di ultimatum nell’intervento del segretario di Stato Mike Pompeo alla Heritage Foundation, che mettendo spalle al muro l’interlocutore lo spingerebbero a reazioni disperate, fatali per la pace.
Il negoziato duro oltre ogni decenza condito di aperture improvvise e imprevedibili è pero il marchio di fabbrica di Donald Trump, da lui praticato quando faceva l’immobiliarista, distillato nel libro The art of the deal e oggi applicato anche al campo delle relazioni internazionali. Questo metodo – che assomiglia a quello usato da Henry Kissinger coi nord-vietnamiti quando era segretario di Stato di Richard Nixon – mira a disorientare l’interlocutore alternando chiusure e aperture in modo che quest’ultimo non riesca a definire una propria linea di azione coerente, continuamente spiazzato dalle giravolte della controparte; e ha come regola d’oro quella di avviare o riaprire un negoziato partendo sempre da una posizione di forza rispetto all’avversario, ottenuta ponendo un fatto eclatante (la denuncia di un trattato, l’imposizione di sanzioni, ecc.).
Incoerente e contraddittorio
Uomini come Mike Pompeo e come il consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton, “falchi” storicamente fautori di un “regime change” a Tehran, si stanno dimostrando perfettamente organici ai metodi di Trump. Pompeo in momenti diversi ha dichiarato che l’Iran stava rispettando gli accordi sul nucleare (a un’udienza del Congresso) e subito dopo che non li stava rispettando; ha formulato l’ultimatum dei dodici punti (che prevederebbero la rinuncia non solo al nucleare ma ai programmi missilistici e al sostegno finanziario e militare del governo di Damasco, di Hezbollah libanese e delle milizie sciite irachene) ma ieri ha dichiarato, come Trump, che gli Usa non vogliono una guerra con l’Iran ma un nuovo accordo che prenda il posto di quello approvato da Obama. Criticato e accusato di incoerenza e contraddittorietà, Trump ribatte che il suo modo di agire ha avuto successo nel caso del Nafta (l’accordo commerciale con Messico e Canada concluso ai tempi di Bill Clinton e ora rimodulato), della questione dei migranti col Messico e della Corea del Nord, che ha effettivamente sospeso gli esperimenti coi missili balistici dal novembre 2017 (quelli sparati nel maggio scorso nel mar del Giappone erano a corto raggio e sono caduti in acque internazionali). Resta da vedere se paesi con tradizioni politiche millenarie come Cina e Iran si mostreranno sensibili alle tattiche trumpiane.
Vicolo cieco iraniano
L’Iran, per parte sua, sembra aver deciso di rispondere a Trump alzando la tensione nell’area nella convinzione che questo sia l’unico modo per chiamare il bluff del presidente americano: le mine contro le petroliere giapponesi, l’abbattimento di un drone americano probabilmente in acque internazionali e la minaccia di bloccare la navigazione nello stretto di Hormuz (dove transita il 35 per cento del petrolio commerciato nel mondo per via marittima) alludono ai costi che lo strangolamento economico dell’Iran o una guerra vera e propria potrebbero avere per l’economia e per gli equilibri mondiali. Trump non può permettersi di affrontare la campagna per le presidenziali con una guerra guerreggiata in corso in Medio Oriente, e gli stessi paesi arabi che maggiormente hanno aizzato gli Usa contro Tehran esitano di fronte a uno scenario che vedrebbe Dubai e Riyadh bombardate da missili iraniani e le acque del Golfo rese impraticabili da mine e imbarcazioni attrezzate per attacchi suicidi, secondo la dottrina del confltto asimmetrico messa a punto dai generali della Repubblica islamica negli ultimi anni. Tehran stringe la cintura e mira a guadagnare tempo in attesa che dalle presidenziali Usa esca vittorioso un candidato Democratico che rimetterebbe sul piedistallo l’accordo sul nucleare voluto e sottoscritto da Barack Obama e cancellato da Trump. Se però si trattasse di un Democratico della varietà Hillary Clinton si ritroverebbero a dover far fronte a una escalation militare Usa in Siria e nello Yemen a fianco delle componenti sunnite alleate dell’Arabia Saudita, contro gli attori locali filo-iraniani. Per gli ayatollah la quadratura del cerchio resta impossibile.
Foto Ansa

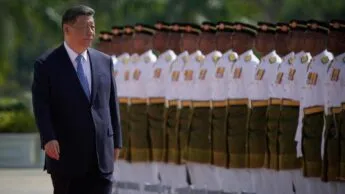

0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!