
Il mito di Amore e Psiche. Quella scheggia di Dio nel cuore
Psiche era una principessa e aveva due sorelle. Tutte e tre erano bellissime, ma Psiche di più; sembrava una dea e nessuno voleva sposarla perché la sua bellezza incuteva timore. Troppa realtà fa male agli occhi. Il padre consultò un oracolo che presagì un mostro orribile come marito. Psiche, agghindata da sposa, venne esposta su una roccia e lì lasciata sola. Ma un vento dolce la rapì, trasportandola su un verde prato. Era il giardino di un palazzo magnifico, le cui porte si aprivano al suo passaggio e voci di invisibili servitori si mettevano al suo servizio. Di stupore in stupore passò la prima giornata. Giunta la sera avvertì una presenza: era il marito della profezia; non lo poteva vedere, ma il suo affetto e calore non le sembrarono affatto mostruosi. Lui non le disse chi fosse e l’avvertì di non tentare di scoprirlo, altrimenti l’avrebbe perduto per sempre. Passarono insieme notti di passione finché un giorno la nostalgia di casa si fece sentire. Così, dopo molte insistenze, il marito concesse a Psiche di uscire dal palazzo per andare a trovare i suoi cari. Quando le sorelle sposate la rividero, innamorata e felice, portare loro doni magnifici, provarono gelosia e la spinsero a disobbedire all’ordine e a scoprire chi fosse il marito. Così avvenne che rientrata a palazzo, la notte dopo cedette alla tentazione. Alla luce di una lampada ad olio scoprì che, al suo fianco, dormiva un bellissimo adolescente. La mano le tremò dall’emozione e una goccia d’olio bollente cadde su di lui. Amore si svegliò e fuggì via, per sempre. La storia avrà un lieto fine ma, prima di diventare immortale e di sposare il suo Amore, Psiche dovrà superare quattro difficili prove di iniziazione, riconquistare il favore di Venere (la futura suocera) e rischiare la morte per riaccendere Eros con la sua bellezza.
La mostra a Palazzo Marino di Milano inizia davanti alla grande tela Psyché et l’Amour di François Gérard (1770-1837), che l’aveva presentata al Salon di Parigi del 1798, suscitando grandi entusiasmi. Proviene dal Louvre, dove entrò alla morte del pittore. Considerato da Ingres il più bel quadro della scuola di David (di cui Gérard era stato allievo), l’opera raffigura in un verde paesaggio i due protagonisti del mito greco. Psiche, dallo sguardo di sonnambula, non vede Amore che la bacia teneramente sulla fronte. Sembrano la versione a colori di Amore e Psiche stanti di Canova, eseguita un anno prima e pure in mostra. In un immobilismo incantato, l’unico accento di vita è il palpito d’ali di una farfalla bianca. La stessa che Psiche depone delicatamente nella mano di Amore del gruppo scultoreo del Canova e la stessa che si staglia in bassorilievo sul piedistallo decorato a ghirlande.
[internal_gallery gid=63549]
Nelle più antiche credenze popolari l’anima usciva dal corpo morto sotto forma di farfalla e ancora in anni recenti un grande artista dell’Arte Povera come Alighiero Boetti (1940-1994) eseguiva il suo autoritratto come un corpo disteso per terra che prende il sole, fatto di cemento a presa rapida e con una farfalla cavolaia (nera e gialla) sul cuore. Soltanto lo sguardo che si posa sul corpo con la gratuità di una fragile farfalla – sembra suggerire l’artista – può fermare il nostro irreversibile scivolamento verso il nulla.
L’uomo non è frutto del caso e la sua anima (Psiche in greco) – ci dicono Apuleio e i neoclassici – non è fatta per il nulla; l’anima è fatta per la felicità, per l’amore eterno e si nutre di un desiderio mai sazio: i greci lo chiamavano Eros e i latini Cupido. L’anima è una scheggia di Dio nel cuore dell’uomo, è la tensione vitale che spinge l’essere umano, imperfetto e limitato, verso la bellezza infinita che lo ha creato. Ogni vero artista ne fa esperienza e Antonio Canova ne sentì tutto il tormento. Durante il soggiorno romano (1779-1815) aveva incontrato Domenica, figlia dell’incisore Giovanni Volpato e con lei aveva iniziato una tenera amicizia. Nel tempo, pero, il legame si era fatto molto travagliato. Lui non l’amava in modo totale e ogni volta la tradiva con la sua arte. Un’inquietudine esistenziale che proprio a Roma spinse lo scultore a creare le sue opere più belle: Amore e Psiche, Le tre Grazie, la Maddalena penitente e numerose altre.
Come vive nella loro casta immobilità
I capolavori di Canova ci interrogano. Che cosa sarebbero l’amore e la bellezza senz’anima? «Lavoro tutto il giorno come una bestia – scriveva lo scultore al suo amico Melchior Cesarotti – ma è vero altresì che quasi tutto il giorno ascolto leggere i tomi di Omero». Ha quarant’anni ed è già il prediletto di papi e sovrani di mezza Europa, da Venezia a Roma, da Parigi a Vienna, quando nel 1797 scolpisce in un blocco di marmo bianco come la neve le due figure di Amore e Psiche stanti. Le ha levigate con pazienza e perizia, una tecnica tutta sua per rendere il modellato sensibile alla luce e leggero come seta. Sembrano vive nella loro casta immobilità. Gliele aveva commissionate un anno prima, nel 1796, il colonnello scozzese John Campbell (divenuto poi Lord Cawdor) che già nel 1787, di passaggio a Roma, gli aveva ordinato il più celebre Amore e Psiche giacenti. Campbell tuttavia, appassionato collezionista dalle finanze non sempre all’altezza delle sue ambizioni, non entra in possesso dei due gruppi scultorei che finiscono invece nel Castello di Villiers-la-Garenne, residenza del generale Murat, acquistati per quattromila zecchini d’oro nel 1801. Mostrati a tutta Parigi in una memorabile festa organizzata nella primavera del 1802 in onore del cognato – il primo console Bonaparte – entrambi i marmi del Canova vengono poi acquisiti da Napoleone come contropartita per il regno di Napoli, da lui ceduto alla sorella Carolina e all’impetuoso marito e portati dall’imperatore al Louvre di Parigi. Dei due gruppi scultorei esistono due repliche autografe all’Ermitage di San Pietroburgo. Sono due capolavori della scultura neoclassica, concepiti secondo i canoni estetici teorizzati dal Winckelmann di «nobile semplicità» e di «quieta grandezza», ma in prima battuta vennero apprezzati soprattutto da uomini d’armi né semplici, né nobili! Tant’è. La struggente favola di Amore e Psiche, tratta dalle Metamorfosi di Apuleio, era tornata in auge per la sua valenza morale, proprio in quegli anni post rivoluzionari.

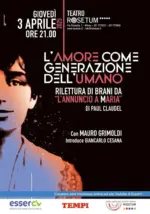
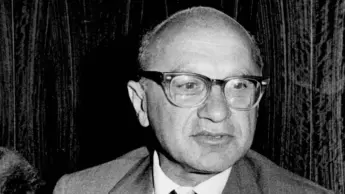
1 commento
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono chiusi.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!