
Il mestiere di educare. Emilia Vergani (1949-2000)

Articolo tratto dal numero di novembre 2020 di Tempi. Questo contenuto è riservato agli abbonati: grazie al tuo abbonamento puoi scegliere se sfogliare la versione digitale del mensile o accedere online ai singoli contenuti del numero.
Da medico, visitando in ambulatorio, spesso mi capita di ascoltare persone che esordiscono nel presentare il loro problema clinico sottolineando la propria risoluzione a prendersi finalmente cura di sé, dopo avere passato tempo, anni, a prendersi cura degli altri; il messaggio sottinteso è che occuparsi degli altri è la causa del problema clinico attuale o del suo aggravarsi. Insomma, curare gli altri sembra che porti a trascurare se stessi.
Ogni volta che mi capita di ascoltare questo discorso mi viene in mente mia madre. Per lei era l’opposto. Prendersi cura degli altri coincideva con il prendersi cura di sé.
Mia madre, Emilia Vergani, era un’assistente sociale. Occuparsi degli altri era il suo lavoro. Tuttavia anche nel periodo in cui abbandonò l’impiego per stare a casa con noi figli piccoli, spesso ci conduceva con sé a trovare persone, soprattutto donne, nelle loro case; quando c’erano bambini ci lasciava a giocare con loro in salotto mentre lei si sedeva al tavolo a parlare con queste persone. Certe condizioni di povertà e di malattia mi impressionavano. Ricordo un ragazzino che non aveva lo strato corneo del viso per una malattia probabilmente del sistema immunitario. Una faccia senza pelle, con la carne umida in vista. Mi ricordo le ragazze madri della Mater Vitae: giovanissime che potevano avere solo pochi anni più di me con marmocchi frignanti in braccio. Mamme senza marito. Mia madre ci spiegava tutto: non aveva paura di parlare ai suoi figli dell’indigenza, della miseria, della malattia.
Le sue giornate si svolgevano in questo modo: cura dei figli e del marito e continui incontri con gente di ogni tipo. Le mie sorelle raccontano che dopo la sua morte, passeggiando per Carate Brianza (Mb), erano fermate da persone che non avevano mai visto prima; le quali le bloccavano per esprimere gratitudine per quello che nostra madre aveva fatto per loro. Persone sconosciute. Chissà come, quando e in cosa era stata loro vicino. Di fatto, lei manteneva un rapporto con questa gente oltre l’orario e l’impegno lavorativo, e coinvolgeva i suoi amici nell’aiutarle.
Lei si prendeva cura degli altri non per banale altruismo, ma con dedizione. Come spiegò una volta durante un convegno a Milano: esiste un modo finto di prendersi in carico delle situazioni nel contingente che è veramente il contrario di un processo educativo. «Non si può dire per esempio: “Gli ho trovato un lavoro, con questa famiglia ho finito”. Ho finito cosa? Io con i miei figli non posso mai dire “ho finito”». Mio padre dice di lei: «Aveva un carattere assolutamente originale. Aveva un giudizio chiaro su cose e persone, ma paradossalmente senza misura. Il giudizio, cioè, non terminava mai nella definizione, ma nella dedizione». Don Luigi Giussani, il fondatore del movimento di Comunione e liberazione, diceva che mia madre era come una stufa: dove c’era lei l’ambiente si scaldava. Oppure diceva che era un catalizzatore. Le persone rimanevano legate, si coagulavano intorno alla sua persona, perché lei si legava a loro. Si dedicava a loro. Tu capivi che le interessavi.
Rendere tutto nuovo
Questo non era unicamente un’inclinazione del suo carattere, ma un bisogno profondo che lei stessa aveva. Una necessità che aveva di rapporto, di bene, di amore. Quando scorgeva negli altri questo suo stesso bisogno, non rimaneva indifferente: doveva fare qualcosa, muoversi, intervenire, instaurare un rapporto. Leggendo il suo diario è molto chiaro che questo desiderio di bene per lei era drammatico: «Non è che mi metto ad amare di più, ma è che il mio bisogno è essere amata di più». Tutto il mio comportamento, anche quello di cui mi vergogno, è la ricerca di questo: «Una piaga incurabile che non vuole guarire». È una continua inquietudine soprattutto se l’amore totale te lo aspetti da chi non lo può dare. Un desiderio così, se non si spegne nel tempo, può bruciare una persona. Lei trovò in Giussani e nel movimento di Cl la strada affinché questo fuoco non si spegnesse e allo stesso tempo venisse indirizzato verso la costruzione di qualcosa di grande.

Mia madre era cresciuta in una famiglia cattolica brianzola degli anni Cinquanta. Aveva intrapreso l’esperienza del Gpg (Gruppo parrocchiale giovanile) dove conobbe mio padre e gli amici che poi sarebbero diventati il nucleo della comunità di Cl di Carate. Giussani aveva reso vivo e presente per loro quel Cristo che credevano morto 2000 anni prima. Non parlo di attualizzazione del messaggio cristiano, ma di carisma, cioè di Spirito santo che fa vivere ciò che è morto, che rende tutto nuovo.
L’incontro con Giussani fu per mia madre la possibilità di crescere nella fede, cioè di crescere nel riconoscere presente Cristo oggi. Secondo l’insegnamento che Giussani le trasmise, a lei e a tanti altri, la fede è riconoscere una presenza; per esempio è riconoscere che quando il prete durante la Messa spezza il pane e versa il vino consacrandoli, lì è presente, in quel preciso momento storico, Cristo. Riconoscere questo è un atto di fede: «Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro». Nell’esperienza di Chiesa che lei faceva riconosceva viva la presenza di Cristo. La fede diventava il tessuto di granulazione della ferita che aveva. Riconoscere una presenza per lei non era far finta di riconoscere Cristo presente, ma vivere il dramma della verità e ragionevolezza di quella presenza: pregare che si presentasse.
Qualcosa di mio che ti do
Si trova scritto nel suo diario: «Mi colpisce sempre pensare che per non avere visto il bene che Dio gli voleva, il popolo ebraico, invece che rimanere nel deserto 40 giorni, è rimasto 40 anni». Era una donna inquieta. Dice di lei il cardinale Angelo Scola, che la conosceva bene sin dalla giovinezza: «In ogni gesto e in ogni rapporto mostrava quella sorta di inquietudine agostiniana, che oserei definire verginale. Un’inquietudine per il suo compimento che contagiava chiunque incontrasse. Incontrarla voleva dire dover fare i conti con una domanda che lei sapeva suscitarti nel cuore inevitabilmente: “A che punto sono io nel mio cammino verso Dio?”».
Nell’incontro con Giussani e il movimento di Cl Emilia aveva potuto riconoscere presente l’interlocutore ultimo del suo bisogno profondo. Dal dialogo tra quell’io e il Mistero presente, in ogni gesto, in ogni rapporto, Emilia mostrava un’inquietudine verginale. Cioè l’inquietudine di quelle vergini sante che lei leggeva, i cui libri erano sempre sul suo comodino, di cui annotava le frasi nel suo diario: santa Teresina del Bambin Gesù, santa Caterina da Siena, eccetera. La verginità non è solo un’astensione sessuale. La verginità è un paradosso; è il paradosso della frase che Gesù dice ai suoi nell’ultima cena prima di andare a morire per loro: «Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici». Nell’incontro con il movimento e con Giussani lei si sentì abbracciata veramente in quel desiderio di bene che avvertiva. Comprese in termini esperienziali di ragione e affezione quel paradosso che è la verginità, e cioè che l’unico modo affinché la vita possa essere compiuta è il donarla tutta.

Innanzitutto l’opera di In-Presa nasce da questa consapevolezza. Non dall’altruismo di una brava donna, ma dalla coscienza nuova e precisa del senso delle cose che sono, e che Emilia sentiva, vedeva e toccava. Dalla percezione viva del suo essere abbracciata da Cristo. Nel movimento Emilia trovava il terreno fertile affinché quel seme di bene che aveva addosso non la sprofondasse, ma crescesse rigoglioso. In secondo luogo, credo che nel guardare don Giussani lei abbia capito che il modo più puro e vero di volere bene a una persona per sempre fosse l’educazione. È qualcosa di mio che ti do perché sia tuo per sempre, anche quando io non ci sarò più. Da questi due giudizi, che lei esprimeva a parole e nei fatti, credo sia nata In-Presa.
La nostalgia del mare
Emilia impostò tutta la sua opera educativa prendendo spunto da un libro di don Giussani, Il rischio educativo, sottolineando la frase di un importante teologo austriaco, J. A. Jungmann: «Educazione è introduzione alla realtà totale». Educare non vuol dire solo insegnare una competenza teorica o pratica, ma consegnare uno spunto di giudizio, un criterio con cui vagliare tutta la vita. Per rendere con un’immagine questo riconoscimento si potrebbe usare la famosa frase di Antoine De Saint-Exupéry: «Se vuoi costruire una nave, non radunare uomini solo per raccogliere il legno e distribuire i compiti, ma insegna loro la nostalgia del mare ampio e infinito».
Cosa fece Emilia? C’era un ragazzo un po’ scapestrato che frequentava la terza media e a scuola non lo volevano più, la mamma non riusciva più a tenerlo a casa, non aveva il papà, la Usl lo inserì in un istituto di Milano da cui, dopo pochi giorni, fuggì. Lo psicologo disse: non so più cosa fare, cosa si potrebbe fare? Lei accolse il ragazzo a casa nostra: stava con noi fino a sera e poi rincasava; prese contatti con un’amica professoressa della scuola media del paese che ne permise l’inserimento in una classe. A casa il ragazzo era agitato, a scuola era un disastro, ma aveva una passione: “truccare” i motorini. Ricordo che portava sempre nello zaino qualcuno di questi carburatori modificati che mostrava, vantandosi, agli amici. In mia madre maturò la consapevolezza che per ragazzi così problematici l’iter normale (prima impari a scuola, poi vai a lavorare) non era utile. Occorreva mettere subito all’opera questi giovani e, contemporaneamente, sostenerli educativamente nella scuola.
Prima uno, poi due, poi tanti
Il suo ideale era che fossero impegnati al mattino nel lavoro e che al pomeriggio formalizzassero in conoscenza ciò di cui avevano fatto esperienza. Coinvolse un amico carrozziere di Carate da cui il ragazzo iniziò a lavorare. Poi arrivò un secondo ragazzo più “incasinato” del primo. Vennero coinvolti due amici elettricisti. Poi arrivarono altri ragazzi e vennero coinvolte famiglie che potessero accoglierli. Poi si pensò a un luogo dove questi giovani potessero trovarsi dopo la scuola o il lavoro. Dove c’era qualcuno che apparecchiava la tavola e preparava il pranzo. Dove c’erano una cucina e un divano. Dove i ragazzi mangiavano con gli adulti che si erano coinvolti con loro, dove potevano confrontarsi.
Il metodo, come diceva mio padre, era di proporre a questi ragazzi la vita della comunità in cui lei viveva, come gesti e come persone. Questo luogo, questo gruppo di amici venne chiamato Centro In-Presa, per sottolineare che il ragazzo veniva “preso” dentro e rimandare alla parola “impresa” cioè all’ambito lavorativo. All’inizio i ragazzi che frequentavano assiduamente il Centro erano circa una ventina. Non si trattava solo di finire la scuola o imparare un mestiere. La pretesa era introdurre questi ragazzi alla realtà totale, cioè metterli in condizione di camminare.
Una grande opera
Oggi In-Presa si occupa di circa 410 ragazzi, vi lavorano 72 persone retribuite, e vi collaborano circa 90 volontari. In-Presa offre formazione professionale, aiuto allo studio e inserimento lavorativo e si rivolge in particolare a giovani in situazione di dispersione scolastica e a rischio di disagio sociale: ragazzi fragili e vulnerabili spesso già segnati da tante esperienze di sconfitta. Di questi 410 ragazzi, 270 frequentano la scuola, cioè il Centro di formazione professionale con due percorsi: operatore della ristorazione / tecnico di cucina e operatore elettrico / impianti fotovoltaici.

Uno dei percorsi formativi che più caratterizzano le attività di In-Presa è il corso in alternanza scuola lavoro, che si rivolge ad adolescenti a forte rischio di dispersione scolastica, con almeno due bocciature. Per offrire la possibilità di fare delle significative esperienze di stage, collaborano con In-Presa circa 300 grandi aziende; artigiani e imprenditori della zona, che operano nei più svariati settori: ristoranti, pizzerie, bar, gelaterie, gastronomie, ma anche meccanici, elettricisti, falegnami, carrozzieri, florovivaisti, tipografi… Da anni esistono delle collaborazioni stabili con realtà come Slow Food, Parco Valle del Lambro, Novotel, Costa Crociere, Eataly; con loro si studiano progetti legati alla didattica. Inoltre sono state avviate iniziative di formazione in assetto lavorativo (on the job) tra cui una pasticceria didattica e servizi di catering.
Novanta dei 410 ragazzi sono coinvolti in attività di orientamento al lavoro. Per loro in questi anni sono stati avviati nuovi laboratori come la ciclo-officina per la riparazione di biciclette, l’orto, il laboratorio di sartoria… Infine, altri 50 ragazzi (i più piccoli) frequentano le medie e ad In-Presa sono aiutati con attività di “sostegno scolastico” e di aiuto allo studio in collaborazione con le scuole che frequentano.
In-Presa oggi è una grande opera perché l’idea e l’impegno di una persona sono diventati passione, sacrificio e lavoro di molti. Molti hanno fatta propria l’intuizione di Emilia e l’hanno sviluppata fruttuosamente secondo la loro indole, la loro passione e la loro creatività.
***

Una mostra a vent’anni dalla morte
Per ricordare i vent’anni dalla scomparsa di Emilia Vergani è stata preparata una mostra e un catalogo (Itaca Libri). Causa restrizioni per il virus, rimandiamo alla consultazione dei siti in-presa.it e itacalibri.it per avere informazioni aggiornate sulle date dell’evento e la distribuzione del catalogo.


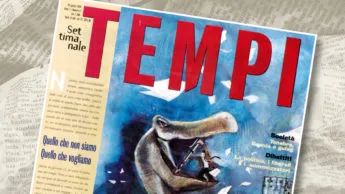
0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!