
Il “canone letterario” della Silicon Valley
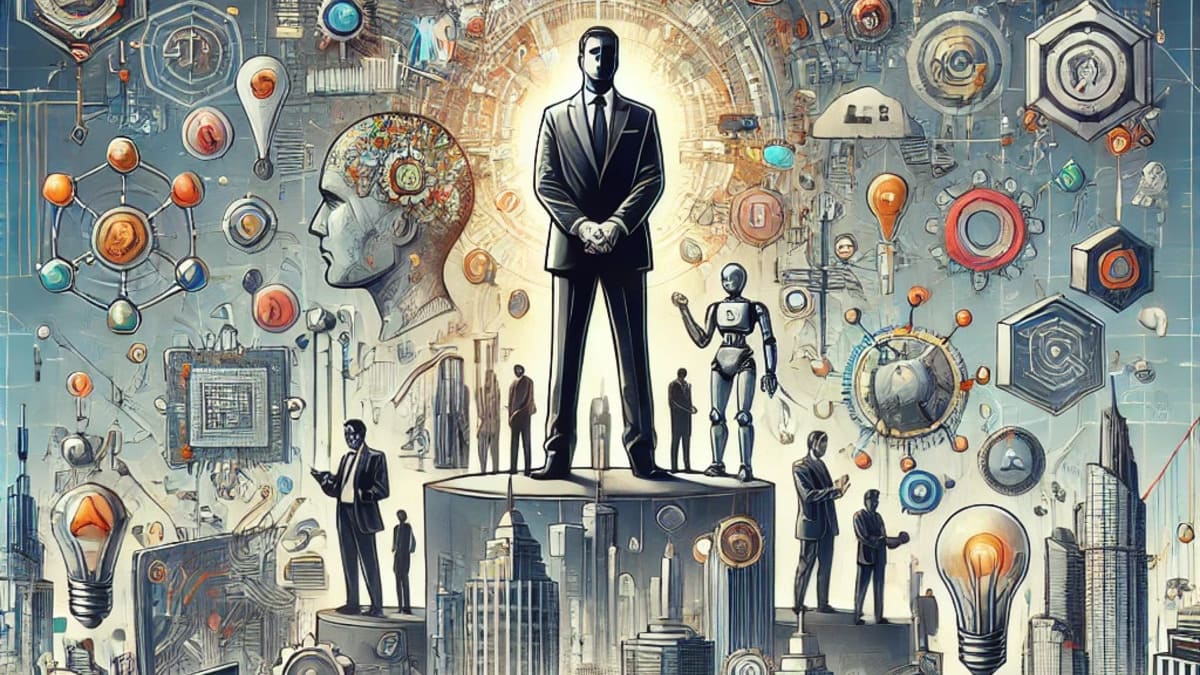
C’è un gruppo che ha influenza in tutto il mondo. Sono i capi della Silicon Valley, i signori dell’innovazione tecnologica e informatica in grado di orientare in modo decisivo le vite di miliardi di persone.
Una considerazione di tal fatta è talmente generica da essere facilmente attaccabile e difendibile. Eppure mantiene una sua plausibilità, quando si rifletta sul fatto che fondatori, presidenti, amministratori delegati, Ceo ecc. delle grandi e medie multinazionali tecnologiche della Silicon Valley creano prodotti e servizi in grado di muovere migliaia di miliardi di dollari. La storia di Nvidia, diventata in pochi mesi la prima società al mondo per capitalizzazione, è solo l’ultimo esempio di rapido successo finanziario grazie all’innovazione e al dominio di un settore tecnologico.
Dalla fantascienza alle biografie dei miliardari
Qual è la ricetta di questi successi a ripetizione? Come pensano i signori della Silicon Valley? Un saggista americano, Tanner Greer, ha chiesto pubblicamente quali libri abbiano letto. Gli ha risposto per primo Patrick Collison, il miliardario co-fondatore di Stripe, con una lista di circa 40 titoli; altri hanno proposto varianti o integrazioni. C’è accordo sulla “vaghezza” del canone: sono volumi nei quali reperire gli ideali a cui ci ispira, più che libri che tutti gli interessati hanno letto. O forse sono i testi di cui bisogna saper parlare.
Guardando anche ai titoli non tradotti, si possono scorgere alcuni tratti comuni. Le opere narrative sono per lo più di fantascienza; quelle di saggistica riguardano la divulgazione scientifica, la programmazione e l’ingegneria del software (con l’aggiunta di un saggio di architettura). Ci sono le biografie dei grandi innovatori, compresi uomini del passato come Theodore Roosevelt (23esimo presidente degli Stati Uniti, quello del “teddy bear”) o John D. Rockefeller, il fondatore della Standard Oil, ma con un occhio soprattutto agli artefici della rivoluzione scientifica e tecnologica americana. Non mancano le storie relative alla Silicon Valley vera e propria, con i memoriali dedicati alla nascita del personal computer, del Macintosh, di Windows NT. Da sottolineare, anche per le scelte di traduzione, la storia della bomba atomica accanto a quella degli ideatori del videogioco Doom. E a condire il tutto, i libri dei miliardari della Silicon Valley – da Thiel a Horowitz – che spiegano il modo in cui arrivare al successo.

Al servizio del pragmatismo
Altrettanto comuni sono le assenze: non ci sono i classici della letteratura e del pensiero, i testi di una qualsiasi grande tradizione religiosa. È questa mancanza di spirito a destare meraviglia: ha senso un’etica senza spirito? Si può immaginare il futuro a partire da un radicato pragmatismo? In fondo questi ideali sembrano tutti volti allo stesso scopo: realizzare prodotti in grado di sfondare e trasformare le imprese innovative in gigantesche corporation capaci di dominare il mondo. Rispetto a quanto può essere essenziale per il resto dell’umanità, nella Silicon Valley sembra diffusa una benigna neutralità, se non un marcato disinteresse.
Più che di pensiero, allora, si tratta di “ciò che i ‘tecnici’ chiamano pensiero”, per riprendere il titolo del libro di Adrian Daub. Dobbiamo collegare queste letture al risultato che ne consegue: innovazioni spesso audaci, ma soprattutto aziende che puntano a dominare il mercato. Un po’ come racconta The Founder, il film sulla storia di McDonald’s: Ray Kroc, il fondatore, è quello che intuisce come costruire un impero economico a partire dalle innovazioni dei fratelli McDonald, a cui finisce per sottrarre anche il cognome.
Conta “come” si legge
Non conta insomma solo che cosa si legge, ma anche la motivazione, lo scopo con cui si legge un testo. C’è un passo di Chesterton (All’insegna della spada spezzata) che appare calzante: «Sir Arthur St. Clare […] era un uomo che leggeva la “sua” Bibbia. Ecco il guaio. Quando capirà la gente che è inutile leggere la propria Bibbia se non si legge anche quella degli altri? Un tipografo legge la Bibbia in cerca di errori di stampa; la legge un mormone e vi trova la poligamia; un adepto della Christian Science legge la sua, e vi trova che non abbiamo né gambe né braccia».
All’origine delle avventure della Silicon Valley ci saranno anche le leggi della robotica di Asimov o l’oggettivismo di Ayn Rand, il gene egoista di Dawkins o la curiosità di Feynman, la controcultura degli anni ’60 e la sperimentazione dal basso, il localismo della realtà californiana. Alla fine, però, conta non solo ciò che – si presume – sia stato letto, ma anche il modo in cui è stato letto, le ragioni che hanno portato a estrarre determinati contenuti da certe pagine. In una parola, conta il lettore con le sue motivazioni e i suoi scopi.



0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!