
I tre capolavori tornati alla luce

Articolo tratto dal numero di novembre 2020 di Tempi. Questo contenuto è riservato agli abbonati: grazie al tuo abbonamento puoi scegliere se sfogliare la versione digitale del mensile o accedere online ai singoli contenuti del numero.
L’Istituto Romano di San Michele è il più grande centro d’assistenza dedicato agli anziani a Roma e uno dei più importanti d’Italia. Il San Michele, come viene affettuosamente chiamato dai romani, è un luogo e un monumento sorprendente dove la cura meticolosa rivolta ogni giorno ad una comunità di circa cento anziani grazie a uno staff specializzato convive con una storia secolare che solo di recente si è riusciti a valorizzare grazie alla determinazione del Segretario Generale dell’Istituto, Claudio Panella, e al sostegno della Fondazione Sorgente Group, presieduta dal professore Valter Mainetti.
Nell’ottobre 2018 l’Istituto ha avviato per la prima volta dalla sua fondazione un’ispezione del proprio patrimonio storico artistico che ha dato risultati straordinari e inaspettati. Gli edifici razionalisti progettati da Alberto Calza Bini alla metà degli anni Trenta del Novecento, attuale sede del centro assistenza e degli uffici amministrativi, non avrebbero mai fatto pensare all’esistenza di una collezione d’arte antica e moderna abbandonata da decenni al suo interno. Di fatto sono emersi (e continuano ad emergere) capolavori che permetteranno di riconsiderare, in parte, la storia dell’arte a Roma. L’Istituto Romano di San Michele nacque nella seconda metà del Seicento a Trastevere dove prese forma in piena epoca barocca un colosso destinato a diventare un braccio armato della Curia romana: l’Ospizio Apostolico del San Michele. Fortemente voluto per arginare i mali storici di Roma – prostituzione, accattonaggio e abbandono minorile – il Pontificio Istituto finì per diventare all’inizio del XVIII secolo un centro modello per il controllo sociale nelle grandi città d’Europa, accomunate da problemi molto simili.
Una briciola del patrimonio
A contrasto con l’idea di una Roma barocca tutta feste a palazzo e artisti in cerca di fortuna, la città che filtra dalle vicende dell’Ospizio Apostolico è un luogo vero e crudo. Bambini abbandonati, vecchi e prostitute tolte dalla strada ben presto, però, diventarono un’enorme opportunità: la comunità trasteverina da bomba sociale si trasformò in un potenziale vivaio di talenti naturali grazie all’incredibile intuizione delle scuole d’arte e mestieri. Pittura, scultura e arazzeria diventarono l’ambito obiettivo di un riscatto sociale alla portata degli ultimi, grazie ad un’offerta formativa gratuita e di alto livello rivolta agli ospiti dell’Ospizio. È così che una quantità spropositata di opere d’arte affluì negli ambienti immensi del complesso, destinata alla didattica delle scuole d’arte e mestieri ma anche all’arredo degli spazi comuni e delle aule di culto interne. Manufatti d’ogni sorta ingrossarono tra Settecento e Ottocento il patrimonio dell’Ospizio grazie a donazioni e lasciti testamentari: donare beni al San Michele significava anche creare una trama di rapporti sociali e politici che poteva portare ai piani alti della Curia. Immaginare la formazione nel tempo di una vera e propria collezione è tuttavia impossibile; la vocazione sociale e assistenziale dell’Ospizio Apostolico non lasciava spazio alla difficile cura di una raccolta d’arte e ciò comportò la mancata creazione di inventari analitici.

Dopo la presa di Roma nel 1870 e l’annessione della città al Regno d’Italia anche il San Michele, come tutti gli istituti e gli organi politici e diplomatici pontifici, cadde in una profonda decadenza solo in parte arginata dal controllo esercitato su di esso dal Comune di Roma. Ammalorato e privo di manutenzione, l’Ospizio e ciò che restava delle scuole d’arte furono trasferiti nei primi anni Trenta del Novecento nell’attuale sede di Tor Marancia, all’epoca ancora in piena campagna. Alberto Calza Bini disegnò un complesso in linea con le tendenze razionaliste di Marcello Piacentini ma senza arrivare alle finezze stilistiche e urbanistiche delle città satelliti pontine come Sabaudia o Latina; ne risultò un sistema di edifici funzionale ma non memorabile sul lato estetico. Più grave fu il trasferimento delle opere d’arte e degli arredi dalla storica sede di Trastevere al nuovo complesso di Tor Marancia, a un passo dal febbrile cantiere del quartiere espositivo Eur-E42: mancando gli inventari la maggior parte di esse furono rubate o disperse senza alcuno strumento che potesse consentire, a posteriori, di recuperarne almeno una parte. Una briciola di quel patrimonio, tuttavia, riuscì miracolosamente a salvarsi ed entrò nelle austere stanze della nuova sede dell’Istituto. Le opere ritenute più importanti furono destinate ad arredo degli uffici e quelle più modeste o presunte tali, la maggior parte, furono sistemate in uno stanzone al piano terreno adibito a deposito.
Rimasto ignorato per decenni, nel 2018 il deposito di pittura e scultura, ormai fatiscente, è stato per la prima volta svuotato e ispezionato, mettendo fine a una situazione di degrado. Da settembre 2019 la Fondazione Sorgente Group sostiene il restauro delle opere ritrovate al San Michele, in particolare di tre capolavori che l’Istituto ha ritenuto tra i più significativi dell’intera collezione.
Si tratta di un San Giuseppe con Gesù giovinetto, olio su tela di Giovanni Baglione (1573-1643) e bottega, di una Sacra Famiglia, san Giovannino e due santi adolescenti, olio su tavola riferibile a Carlo Portelli, grande maestro fiorentino manierista attivo a cavallo del XVI secolo, e di una grande pala d’altare con la Madonna del cardo, opera di una sconosciuta ma grande pittrice dell’inizio del Novecento di nome Emma Regis.
Contrasto di assoluta bellezza
Le opere raccontano storie diverse ed ognuna è emblematica del periodo che rappresenta; Baglione – tra i più grandi interpreti del Barocco romano e noto per il processo per diffamazione intentato contro Michelangelo Merisi da Caravaggio – raffigura una composizione intima e brillante nei toni, superando la fase caravaggesca che lo aveva contraddistinto in gioventù. La pala è la seconda versione di un’opera perduta, un dipinto dello stesso soggetto che Baglione aveva realizzato per la cappella di San Giuseppe presso Santa Maria ad Martyres al Pantheon, in seno alla Confraternita dei Virtuosi al Pantheon. Spesso i maestri del barocco replicavano le proprie opere per collocarle sul mercato, ma il caso della pala di San Giuseppe al Pantheon è ancora avvolto nel mistero.

Carlo Portelli è un protagonista assoluto del manierismo fiorentino a cavallo della metà del Cinquecento; la tavola del San Michele è arrivata a noi in condizioni disastrose ed è stata sottoposta all’intervento più complesso tra quelli sostenuti dalla Fondazione Sorgente Group. Il restauro sta rivelando una gamma cromatica e una morbidezza delle pennellate tipica degli allievi di seconda generazione del Pontormo, dove la tavolozza michelangiolesca si fonde con le fisionomie allungate e visionarie della maniera moderna, creando un contrasto di assoluta bellezza.
Un tesoro sommerso
La Madonna del cardo è la scoperta che più di tutte ha fatto riconsiderare l’importanza del patrimonio artistico del San Michele; il nome dell’autore è stato scoperto casualmente durante la spolveratura preliminare al restauro: Emma Regis. Si tratta di una pittrice del tutto sconosciuta ma di qualità altissima; gli studi che accompagnano il restauro hanno rivelato che potrebbe trattarsi di un’allieva assai dotata di Giulio Aristide Sartorio, che fu docente di pittura proprio nelle scuole d’arte presso l’antica sede dell’Ospizio Apostolico a Trastevere. La pulitura ha rivelato non solo una materia intatta, costituita da pigmenti ad olio stesi a grossi grumi sulla tela, ma ha consentito di rivelare con più esattezza i tratti del volto della Vergine, che corrispondono a quelli di Elena Sangro (1897-1969), nota attrice del cinema muto attiva nei primi decenni del Novecento che per questa pala posò come modella.
L’équipe di restauro formata da Daphne De Luca, docente in Conservazione e restauro dei manufatti dipinti su supporto tessile presso l’Università degli Studi di Urbino, Roberta Porfiri, funzionario della Soprintendenza archeologia, belle Arti e paesaggio di Roma, e dalle restauratrici incaricate, Silvia Fioravanti e Veronica Soro, sta portando a risultati considerevoli, restituendo alla comunità scientifica opere d’arte inedite che gettano nuova luce sul patrimonio artistico sommerso di Roma, che ancora una volta dimostra quanto nella città eterna ci sia tutto da scoprire.
***
Tommaso Strinati, autore di questo articolo, è curatore della Collezione d’arte antica e moderna dell’Irsm


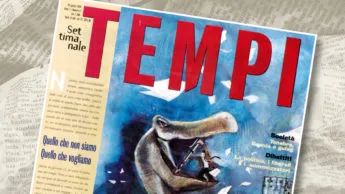
0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!