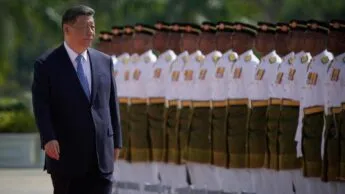
I bambini morti tra le lamiere di Sierre e la speranza
Un bambino che non torna dalla gita è un vuoto nel pensiero – perfino oltre il controsenso. Mio figlio, mentre guardavamo il telegiornale che ci aggiornava sulla tragedia di Sierre dello scorso 13 marzo, mi ha chiesto: «Mamma, come fa una cosa dura come l’acciaio a sbriciolarsi?». Come possono le cose più preziose, certe e sante che abbiamo crollare e sbriciolarsi così di colpo?
Il mio pensiero, quasi per rifugiarsi, è finito a pensare al giorno in cui nostro figlio lo abbiamo portato a casa dall’ospedale, quando è nato. Io e mio marito facemmo l’intero tragitto di strada in auto in silenzio: un buon venti minuti di strada, che conoscevamo a memoria perché faceva parte dei vari percorsi della routine quotidiana. Io non pensavo a niente, perché guardando i campi, le case e più lontano le colline; mi perdevo a fissare quegli oggetti uno ad uno. E la strada mi sembrava lunghissima e tutte le cose mi sembravano nuove. Ruppi il silenzio solo per dire a mio marito, che guidava: «Non è più la stessa strada, vero?». Annuì, dicendomi che stava pensando la stessa cosa.
Perché, con una coscienza mai avuta prima, d’improvviso sembrava evidente e chiarissimamente giustificabile che ogni singolo oggetto presente al di fuori dell’abitacolo – dal segnale stradale storto fin su al sole – era in quel momento lì per noi. Ma lo stesso sole che a me pareva amico, quel giorno di cinque anni fa, campeggia terso, luminoso e ancora più brillante in quella meravigliosa cartolina che è la Svizzera, che fa da sfondo alle immagini che ci vengono mostrate e ci documentano la cronaca fuori da quella galleria. E lì il sole splende nonostante tutto; e sembra o un invito illogico o una sprezzante inconsapevolezza. A noi che siamo rimasti colpiti tantissimo, pur dalle nostre case così lontane da quella galleria, risulta insostenibile anche solo immaginare che suono ha il pianto del soccorritore che scava tra le lamiere, o il silenzio dei bambini sopravvissuti o quello dei genitori che dal Belgio vanno verso gli ospedali svizzeri. È quasi meccanico spostare l’emozione ingestibile sulle notizie tecniche che si moltiplicano, stordendoci di dati, ricostruzioni e spiegazioni. Su youtube è disponibile un video che ricostruisce tutto l’accaduto – sembra un videogioco di simulazione di guida e, così, sei anche tu a bordo di quel pullman: mentre le immagini scorrono in una virtual-realtà c’è una voce che parla in inglese e spiega l’intera dinamica dell’evento, le cause (errore meccanico o l’autista distratto che armeggia col Dvd), quanto è lunga la galleria e quando è stata inaugurata, a che velocità massima si può andare lì dentro, le statistiche sulla frequenza degli incidenti di pullman in Svizzera. È una realtà virtuale, non fosse altro perché non c’è nessuna persona, solo vetture. È una ricostruzione senza soggetto.
Ed è il soggetto che forse ci sfugge. Sì, le informazioni sui soggetti coinvolti le sappiamo: 52 persone, 28 morti di cui 22 bambini e altri 24 feriti. Ma il soggetto vero (quello di cui ci parla la sostanza di questa tragedia) è qualcosa che scardina la nostra percezione comune della vita, di ciò che siamo e facciamo.
Nel torpore della vita quotidiana prevale un’idea ingannevole per cui essere al mondo – esserci – non basta a sostenere appieno la consistenza della vita. L’unità di misura prevalente sono gli eventi e i loro esiti, bilanci e progetti; veniamo traviati dall’illusoria prospettiva di dar valore alla vita in quanto progresso. Salvo poi constatare, pressoché quotidianamente, che quella che sembra una legge di natura raramente segue questo ipotetico corso naturale, e le eccezioni all’idea di un ciclo vitale sono clamorosamente più numerose, tragiche, comiche – incredibili. E poi ci sono momenti come questo in cui “incredibili” diventa ai nostri occhi “inaccettabili”.
Questi momenti incomprensibili noi li chiamiamo correttamente incidenti, perché incidono e feriscono la realtà: è come se d’improvviso cadessero i teli delle scenografie teatrali e lo spettacolo s’interrompesse bruscamente svelando la penombra delle quinte. Tutto salta.
E per qualche istante o momento di tempo più o meno lungo, il nostro equilibrio interrotto indugia una volta di più su quel tremendo pensiero: «Io non so cosa sarà di me tra cinque minuti». È un dubbio? Un terrore? O la ricerca di una speranza? È dura chiamare in causa la parola speranza di fronte alle lamiere sbriciolate, perché non è plausibile chiamarla in causa facendo un salto – cioè staccandoci da terra, e rifugiandoci nella consolazione di un pensiero che ci porta altrove.
In un romanzo dell’americano Wendell Berry, ambientato nel corso della Seconda Guerra mondiale, c’è un padre che riceve una lettera dall’esercito in cui gli si comunica che il figlio, soldato in servizio al fronte, risulta «disperso in azione». Quell’uomo per l’intero corso del romanzo convive con lo strazio indicibile dell’incertezza di un destino sospeso – del non potere neppure avere la disperazione di piangere un figlio morto. Un giorno bussa alla sua porta il prete del villaggio, venuto a compiere quel dovere che gli impone il suo ufficio di pastore, il «dovere» di confortare gli afflitti: «Nelle parole di quel predicatore la Città Celeste si ergeva imponente, sovrastando le loro vite, la casa, il paese – la speranza finale, in cui tutti gli enigmi e la fine del mondo sono compresi, illuminati e legati. Questa era la speranza del predicatore, che s’innalzava da solo verso l’alto, al di fuori delle pretese del tempo e delle pene. E in quel volo in cui s’era lanciato, era libero dal vincolo del mondo. Ma in questa speranza – in questa rincuorante e semplicistica costruzione del pensiero – Mat si rendeva conto di non essere libero, e di non esserlo mai stato. Si sentiva destinato a dover sperare dentro il mondo, dentro il recinto dei suoi affetti. La sua speranza nel Paradiso doveva essere la speranza per cui un uomo stretto nei vincoli del mondo sente che la sua vita non è ultimamente inutile o insignificante, una speranza il cui fardello deve essere molto più pesante di quello della disperazione» (W. Berry, A Place on Earth).
Questa è la conclusione a cui anche un uomo come Giobbe arrivò. Non c’è libro della Bibbia più spudoratamente realista in senso positivo di quello in cui ci viene mostrato il grido straziante e doloroso di un uomo messo alla prova fino all’estremo. «Me ne stavo tranquillo ed Egli mi ha scosso, mi ha afferrato per il collo e mi ha stritolato; ha fatto di me il suo bersaglio». Dalla quieta serenità di una vita agiata e prospera Giobbe viene precipitato nell’abisso della disperazione all’improvviso: ogni sua proprietà perduta, tutti i suoi figli morti, il suo stesso corpo assalito e divorato dalle piaghe. L’unico interlocutore che Giobbe reclama è Dio stesso. E solo di fronte alla sua coscienza nuda e ferita può spalancarsi l’ipotesi seria che Dio ha da proporre a Giobbe. Un’ipotesi talmente seria che prorompe in una domanda che suona tanto d’accusa: «Dov’eri tu quando io fondavo la terra?». Ma quello che poi Dio dipana davanti agli occhi di Giobbe è come una festa di forme, di colori, di misure esorbitanti. Dio racconta la sua Creazione disegnando come un bambino, proprio con la stessa esuberanza e stravaganza che vediamo nei disegni che hanno lasciato quei bambini a ricordo della loro vacanza in Svizzera sulla neve, e come i disegni che i loro amici hanno fatto per i compagni morti. Non è una realtà virtuale spiegata, ma è uno sguardo inebriato e quasi esaltato che se ne esce con un elenco mirabolante di dettagli pronunciati a raffica – come fanno i bambini: la poca intelligenza dello struzzo, le mascelle dell’ippopotamo, i germogli d’erba, i depositi della neve e della rugiada, i legami tra le stelle delle Pleiadi.
Insomma, l’unica cosa in grado di soddisfare il cuore di un uomo toccato dal male in ogni fibra non ha nulla a che vedere con una valida spiegazione logica. Non ha nulla a che vedere con una ponderata valutazione delle cause e degli effetti. La risposta conclusiva di Giobbe a Dio, infatti, è paradossale: «Io ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno veduto». Cosa ha veduto Giobbe se non il mondo che aveva già di fronte ogni giorno? – verrebbe da dire. Sì, ha semplicemente rivisto una ad una le cose. Senza cortesia e gentilezza è stato costretto a considerare ogni animale, ogni granello, ogni goccia, dal punto di vista di chi le ha immaginate e le ha amate creandole. La sua pochezza di essere umano (peccati, limiti, miserie, mortalità) si ribalta alla luce della gigantesca pretesa impostagli dalla voce del Creatore stesso, e cioè che il suo piccolo essere è ed è già una clamorosa evidenza della sconfitta sul nulla.
L’evento della nascita è qualcosa d’incredibile e concreto, è lo scudo – e la spada – che ignari ci portiamo addosso per accompagnare la battaglia, la fatica, l’avventura del vivere; è una speranza pesante – cioè solida – ed è al principio di tutto: non è scalfita dal modo in cui la morte sorprenderà ciascuno di noi (se nella tenera giovinezza o nell’avanzata e stanca vecchiaia); non riguarda le nostre conquiste umane, quanto tempo avremo avuto per radicare o distruggere le nostre illusioni, il modo in cui avremo potuto maturare la nostre capacità affettive e le intuizioni intellettive; non riguarda neppure la fede positiva nella Resurrezione che con libera e autentica adesione potremo scegliere o negare.
C’è. È l’alba di una vittoria che, il più delle volte inconsapevolmente, portiamo a spasso con noi, giorno per giorno – per quanto pochi o tanti possano essere i giorni in cui passeggeremo per il mondo.



0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!