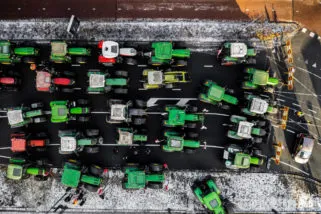
La formula dell’Apocalisse


Articolo tratto dal numero di Tempi in edicola (vai alla pagina degli abbonamenti) – Guerra dei sette anni. Minden, 1° agosto 1759. Un reggimento di Redcoats avanza a falcate decise, baionetta inastata, al ritmo della marcia dei British Grenadiers, l’Union Jack garrisce allo zufolare dei pifferi e al rullo dei tamburi. A riceverli, impeccabilmente allineati in immacolate uniformi, i soldati di Louis Georges Érasme, sesto marchese di Contades, signore di Montgeoffroy, maresciallo di Francia. Quindi la telecamera di Stanley Kubrick inquadra da tergo i francesi, i Culs Blancs (sic, pure le brache erano bianche), tricorni neri bordati di bianco, perfette acconciature raccolte in codini infiocchettati che ricadono fra le spalle. Fintantoché un rauco feu! non darà la stura all’approssimativa pirotecnia degli spari, non si avrà battaglia ma coreografia.
Questa scena del film Barry Lyndon restituisce, con la potenza della (sempre veritiera) intuizione romanzesca, ciò che, alla fine del XVIII secolo, gli smarriti contemporanei rimpiangeranno come la guerre en dentelles, “la guerra in merletti”, così definita non solo e non tanto per la courtoisie richiesta ai “gentiluomini in armi”, ma per il fatto dell’essere la guerra essa stessa un’istituzione, solenne atto pubblico di uno Stato sovrano verso un altro Stato sovrano, capace di trattenerne la violenza nel perimetro del campo di battaglia e dei vincoli stabiliti dallo ius gentium, il diritto delle genti della teologia politica di Carl Schmitt, capace di frenare l’umana propensione all’auto-annientamento. Di lì a poco, dal vaso di Pandora della modernità sarebbe però sfuggita una sorta di guerra mai vista prima.
A Valmy, il 20 settembre 1792, un esercito di contadini va in soccorso alla Francia rivoluzionaria contro l’armata della prima coalizione formata da 150 mila regolari di Austria, Prussia e Assia e da 20 mila volontari realisti francesi emigrati, al comando del duca di Brunswick. Al suo fianco c’è un giovane ufficiale prussiano, Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz, spettatore incredulo di quello che si sta parando dinnanzi ai suoi stessi occhi: la prima leva di massa della storia ha scaricato sul fronte falangi di coscritti, sanculotti vestiti di nuovo in celesti uniformi, i Bleuets, che si sono ora aggiunti ai Culs Blancs dell’esercito regolare, un vero «popolo in armi», ideologizzato, dove i due terzi degli ufficiali e dei sottufficiali sono eletti dal basso come premio al coraggio e al civismo rivoluzionario, che non solo sopporta il cannoneggiamento senza sciogliersi come neve al sole, come era accaduto nelle precedenti battaglie, ma contrattacca alla baionetta costringendo uno scioccato Brunswick a ritirare le sue colonne. Per il futuro teorico dell’arte militare è solo la prima di una serie di umilianti disillusioni che culminerà nel disastro di Jena, dove sorgerà, ad un tempo modello ed ostacolo, l’inarrivabile «dio della guerra»: Napoleone.
 Un duello su vasta scala
Un duello su vasta scala
Hegel, presente anch’egli a Jena, dirà di aver visto dalla finestra «lo Spirito del mondo a cavallo». Ma solo Clausewitz coglierà il vero senso di tale epifania della storia: ciò che si è infatti confitto come punta di diamante nella sua fronte incontaminata è la formula dell’Apocalisse. Che solo più tardi, posseduto dal risentimento, metterà nero su bianco nel libro I della sua opera incompiuta, Vom Kriege (Della Guerra). Morirà nella medesima epidemia di colera che falcerà Hegel e il collega Gneisenau. L’illuminazione ricevuta come una pallottola vagante da un così improbabile autore, dovrà però attendere l’ultimo René Girard di Achever Clausewitz (Portando Clausewitz all’estremo, 2007), per trovare una lettura in grado di consegnarcene le più gravi implicazioni.
C’è qualcuno di voi che si ricordi per qual mai oscuro punto d’onore, precedenza non accordata o cenno di saluto non contraccambiato, gli ufficiali degli ussari Feraud e D’Hubert del racconto The Duel di Conrad, nelle pause concesse fra una campagna napoleonica e l’altra, seguitino a sfidarsi all’ultimo sangue? Nella trasposizione cinematografica di Ridley Scott, la donna di guarnigione innamorata di D’Hubert, esasperata, chiederà lumi a una cartomante, che dal mazzo estrarrà un tarocco: «Il due di spade: significa contesa senza motivo, un conflitto che seguita senza sbocco». Veridica sibilla! È su tale sorda rivalità, di cui non c’è traccia nella tavola delle categorie kantiane, che il Generalmajor von Clausewitz modella la sua definizione di guerra, all’inizio del suo trattato. Lo vediamo, chiuso nel suo gabinetto dell’Allgemeine Kriegsschule, la Scuola di guerra di Berlino, di cui è direttore dalla Restaurazione, ma dove si trova circondato da malevoli parigrado che han servito sotto l’Empereur. In piedi, lo sguardo perduto al di là del finestrone, detta allo scritturale:
«Non daremo della guerra una grave definizione scientifica; ci atterremo alla sua forma elementare: il combattimento singolare, il duello. La guerra non è che un duello su vasta scala.
La moltitudine di duelli particolari di cui si compone, considerata nel suo insieme, può rappresentarsi con l’azione di due lottatori. Ciascuno di essi vuole, a mezzo della propria forza fisica, costringere l’avversario a piegarsi alla propria volontà; suo scopo immediato è di abbatterlo e, con ciò, rendergli impossibile ogni ulteriore resistenza.
La guerra è dunque un atto di forza che ha per iscopo di costringere l’avversario a sottomettersi alla nostra volontà».
Ora però il ricordo deve essere andato a Borodino. Si trovava infatti nelle file dello zar nel giorno più mortale (80 mila fra morti, feriti e prigionieri) del carnaio universale inaugurato dalle guerre napoleoniche, perché l’osservazione che aggiunge a margine non è di quelle fatte per rassicurare:
«Gli spiriti umanitari potrebbero immaginare che esistano metodi tecnici per disarmare o abbattere l’avversario senza infliggergli troppe ferite e che sia questa la finalità autentica dell’arte militare. Per quanto seducente ne sia l’apparenza, occorre distruggere tale errore poiché, in questioni così pericolose come la guerra, sono appunto gli errori risultanti da bontà d’animo quelli maggiormente perniciosi.
Poiché l’impiego della forza fisica in tutta la sua portata non esclude affatto la cooperazione dell’intelligenza, colui che impiega tale forza senza restrizione, senza risparmio di sangue, acquista il sopravvento sopra un avversario che non faccia altrettanto e gli detta in conseguenza la propria legge; ed entrambi i principi di azione tendono così verso l’assoluto, senza trovare altri limiti che nei contrappesi insiti in essi».
La tendenza all’estremo
Sì, un duello, ma come «tendenza all’estremo», dove il «sentimento ostile» (la passione guerriera) finirà, d’ora innanzi, per sopravanzare «l’intenzione ostile» (la decisione razionale di combattere):
«In una parola, le più violente passioni possono accendersi anche fra i popoli più civili […].
Confermiamo dunque: “La guerra è un atto di forza, all’impiego della quale non esistono limiti: i belligeranti si impongono legge mutualmente; ne risulta un’azione reciproca che logicamente deve condurre all’estremo”».
Ed è dal concetto di «azione reciproca» (che traduce il termine Wechselwirkung) fra belligeranti, che si pensano protagonisti nell’agire mentre sono in realtà agiti dai rivali, che René Girard resta soggiogato, perché Clausewitz scopre nella guerra una legge di valore universale: la «tendenza all’estremo» che monta da tale reciprocità è la corsa del mondo moderno all’auto-annichilimento. Tale intuizione è infatti profondamente in sintonia con tutto il pensiero del maestro scomparso nel 2015, dalla critica letteraria allo studio del religioso nelle società arcaiche, fino alla rilettura antropologica dei Vangeli e della tradizione profetica ebraica. Sì, quando parla di «sterminio del nemico», con l’occhio sulla miccia dei suoi cannoni, questo Clausewitz osservato da un pensatore anticonvenzionale come Girard, sociologo darwiniano e apologeta del cristianesimo, non è più lo stratega glossato da Raymond Aron o da Basil Liddell Hart, ma un profeta: il disvelamento delle sue cose future, collimate oltre la volata degli obici, in greco si scrive apokálypsis.
Per capire non bastano le dimostrazioni teoretiche sulla parabola del proietto, ma ci vorrebbe forse Beethoven. No, non la Marcia funebre dell’Eroica, con il buco nella partitura, là dove il nostro Ludovico Van ha rabbiosamente obliterato l’imprudente dedica al tiranno còrso, reo di aver tradito gli originali ideali di fraternità universale («Alle Menschen werden Brüder…»), ma il Beethoven chiaroveggente che sul pentagramma verga tutto il suo struggimento per il futuro nell’Allegretto della Settima!

In principio. In principio c’è sempre un accordo. Il tempo di aggiustarsi il giro manica del frac e “Lenny” Bernstein dà l’attacco ai Wiener Philharmoniker. E i Wiener gli danno l’accordo iniziale. Mesto la minore suonato solo dai fiati (flauti, oboi, clarinetti, fagotti e corni), forte che si smorza in pianissimo in poco più di due battute, come se Dio svuotasse le gote insufflando la coscienza di sé nella sagoma dell’uomo tratta dal fango dell’evoluzione. Poi alla terza battuta, viole, violoncelli e bassi enunciano piano una frase che procede a tentoni, alternando semimine “tenute” (implora Ludovico Van sulla partitura) allo “staccato” delle crome, tempo due quarti, tàa-tàtta-tàa-tàa… e il sapiens sapiens guadagnerà la posizione eretta ma solo per cadere. E non esiste altro uomo che «l’uomo della caduta». È l’apprendistato umano che Girard definisce processo di «ominizzazione», ossia il passaggio dall’animalità all’umanità avvenuto da migliaia di anni. L’ipotesi del maestro di Avignone, oggi sempre più suffragata dalle scoperte delle neuroscienze (ad esempio sui neuroni specchio) è mimetica: il «desiderio mimetico», o imitazione reciproca, è il fondamento originario e permanente della condizione umana, dal suo primitivo originarsi nei primati non umani fino alla data di oggi, dove 7 miliardi 500 milioni di individui si reputano tutti originali e autodeterminati nel realizzare la loro volontà di potenza mentre desiderano solo lo sguardo desiderante dell’altro. No. Noi siamo in virtù dell’imitazione reciproca.
Non sentite come anche i secondi violini, che ora sono entrati, spingano le viole a infiorare il tema originale che srotola le sue spirali in crescendo? È per il loro imitarsi in misura maggiore rispetto agli animali che gli uomini hanno dovuto trovare un rimedio a una somiglianza così contagiosa che può portare alla pura e semplice scomparsa della loro società: se desidero (per definizione) la roba d’altri e la donna d’altri, finisce a pietrate. Possiamo rifiutarci di vedere, come fa l’antropologia culturale à la Lévi-Strauss, ma il dispositivo esperito da ogni gruppo umano per ovviare alla violenza latente è il sacrificio, il capro espiatorio: dall’alba dell’umanità, milioni di vittime innocenti sono state immolate in tal modo, per consentire ai loro simili di convivere e non auto-distruggersi. Da qui escono le religioni e le istituzioni umane. È il «peccato originale», la stanza degli orrori tenuta sotto chiave, fin dalla fondazione del mondo.
Il mercato come campo di battaglia
In tutte le narrazioni culturali primigenie la soluzione è invariabilmente il fratricidio fondatore: Osiri e Seth, Caino e Abele, Romolo e Remo e l’elenco arriva fino ai due duellanti di Clausewitz. E la verità che Clausewitz proclama sulla forma estrema della rivalità mimetica fra gli uomini ha qualcosa di trascendente, che va ben oltre il trattato, ad uso del Principe, su come vada condotta la guerra. Il Clausewitz del libro I di Vom Kriege parla delle leggi che portano all’evoluzione della violenza in quanto tale, come noi potremmo interrogarci sulle leggi economiche che portano alla dinamica del prodotto interno lordo: se Machiavelli aveva proclamato l’autonomia della politica dalla morale, dalla religione o da qualsivoglia movente o spirito umanitario mai possa aggradarci, Clausewitz proclama l’autonomia della guerra dalla politica. D’ora in poi la politica rincorrerà la violenza pura e l’unica dialettica su cui si potrà filosofeggiare sarà quella fra la difesa e l’attacco. Come per Eraclito, Pólemos, il demone della guerra, è tornato ad essere il padre di tutte le cose.
Non è forse questa la stessa pretesa della globalizzazione economica? Basta cambiare i termini e parlare invece di mercato, domanda e offerta. Ma Clausewitz ci avverte: fra guerra e commercio internazionale c’è differenza di «grado» ma non di «natura», il passaggio dalla partita doppia allo scambio termonucleare è roba da niente al minimo dubbio che l’avversario possa farlo per primo.
Hashtag per i buoni selvaggi
Il tempo nuovo in cui Clausewitz ci introduce è un tempo dove vige la reciprocità assoluta, dove l’unica legge possibile è quella che si impongono mutualmente i belligeranti e dove il nemico è la prima fonte di apprendimento, ovviamente per imitazione accrescitiva: è Napoleone che insegna ai prussiani umiliati il militarismo, saranno i prussiani a rendere la pariglia ai francesi nel 1871, e non si può certo dare a Clausewitz del pazzo visionario se pensiamo che, solo attorno alla rivalità franco-tedesca, avremo la Prima Guerra mondiale con il mattatoio di Verdun (600 mila fra morti, feriti e dispersi) e la Seconda Guerra mondiale con la Shoah e l’olocausto nucleare di Hiroshima e Nagasaki! Per René Girard, Clausewitz preannuncia, in realtà, la fine dell’Europa, Hitler e Stalin: l’America ci libererà faticosamente da entrambi ma solo per consegnarci al suo «non-pensiero». Oggi ci troviamo veramente di fronte al nulla, ci dice Girard: se Clausewitz annuncia il crepuscolo della guerra come istituzione, oggi assistiamo alla sua sostituzione con la violenza generalizzata, gli stermini etnico-religiosi, i terroristi suicidi, la terza guerra mondiale «a pezzetti» di Bergoglio.
Ora, se trent’anni fa ci avessero detto che l’islamismo avrebbe raccolto il testimone della Guerra fredda, ci saremmo messi a ridere, ma gli stessi politici, militari e banchieri che non han saputo o voluto vedere ciò che si preparava, restano al comando, continuano a rassicurarci. Come fanno i damerini della modernità che, da tre secoli, non vivono che per l’orgasmo della decostruzione di qualsivoglia istituzione, rituale, diritto, capace di dar razionalità alla politica o un po’ di senso alla vita degli uomini, ammazzasette da salotto che ieri starnutivano prese di tabacco, discettando di Liberté, Égalité, Fraternité, quasi fosse un nuovo gioco di società, mentre avevano la testa bell’e infilata nella ghigliottina, e oggigiorno smaniano per portare la Vuota Novella dei loro hashtag ai Bons Sauvages di turno (che altro non aspirano se non di spiccargliela ancora, la testa dal collo, nel nome però di una religione arcaica, del ressentiment). No, non sanno da che storia sono usciti. Per Girard, noi siamo la prima società consapevole di potersi distruggere in maniera definitiva, solo ci manca la credenza su cui appoggiare questo sapere. Solo il cristianesimo può fornire una spiegazione a un fenomeno totalmente irrazionale come questa «tendenza all’estremo», perché Cristo ha tolto agli uomini le loro stampelle sacrificali, lasciandoli davanti a una scelta terribile: o credere alla violenza, oppure non crederci più.
Sotto i nostri occhi
Il cristianesimo è questa incredulità. E la parola di Dio si dispiega con la massima forza proprio nei testi apocalittici, ma gli stessi testi apocalittici ci preavvisano che gli uomini non ascolteranno. No, non stanno ascoltando, chiunque lo può vedere. Bisognerebbe prendere sul serio questa parola che si sta avverando sotto ai nostri occhi, adesso!
È la fine? Ora l’Allegretto della Settima è al fortissimo, al pieno orchestrale, con i primi violini che si abbattono come dispacci di disfatta, i colpi dei timpani come i pugni della baldracca fortuna, Bonaparte caracolla in sella, ad ogni passo del suo cavallo impastoiato nel fango della battaglia persa, il capo infossato nelle spalle si squassa fino a piantare il mento nel petto, come se la feluca si dovesse inchinare a rendere omaggio a tutto l’odio di cui è capace il mondo. La musica presto finirà, quando l’incendio avrà tutto consumato. Silenzio. Ma questa pace è quella dei campisanti.



0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!