
Finché c’è vita c’è speranza (in una malattia)

Articolo tratto dal numero di ottobre 2020 di Tempi. Questo contenuto è riservato agli abbonati: grazie al tuo abbonamento puoi scegliere se sfogliare la versione digitale del mensile o accedere online ai singoli contenuti del numero.
«In duecentocinquanta di quelle case ci sono duecentocinquanta camere dove qualcuno riconosce la scienza medica, duecentocinquanta letti dove un corpo disteso sta a testimoniare che la vita ha un senso, e grazie a me un senso medico. Di notte è anche più bello, perché ci sono le luci. E quasi tutte quelle luci sono mie. I non-malati dormono nel buio. Scompaiono. Ma i malati hanno lasciato accesi i loro lumini o le loro lampade. La notte mi libera di tutto ciò che è al di fuori della medicina, mi sbarazza della sua molestia, della provocazione. Il distretto si trasforma in una sorta di firmamento di cui sono io il perpetuo creatore».
Il 15 dicembre del 1923 andava in scena a Parigi la prima di Knock o Il trionfo della medicina di Jules Romains, poeta, romanziere, filosofo e autore teatrale francese tanto apprezzato in vita quanto velocemente dimenticato dopo la sua morte, avvenuta nel 1972. A quasi cent’anni da quella prima rappresentazione, Liberilibri ha deciso di ripubblicare questo breve testo (lo aveva già fatto con una prima edizione nel 2007) che pare tagliato su misura per questi tempi in cui la salute è diventata l’unica cosa che conta.
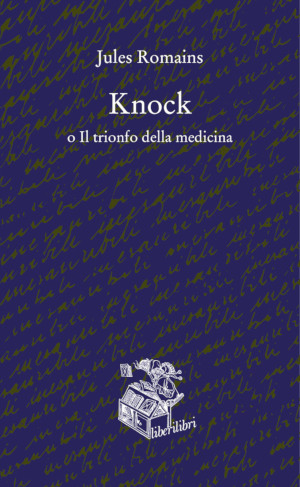
La storia è semplice: il dottor Parpalaid, medico condotto del paesino di Saint-Maurice, decide di andare a esercitare la professione a Lione, e lascia il suo posto al più giovane Knock. In trent’anni Parpalaid non ha praticamente mai curato nessuno, chi andava a farsi visitare da lui veniva al massimo invitato a riposare e bere camomilla: è in fondo uno scettico della medicina, che pure pratica, annota con distaccata accettazione il fatto che chi deve morire muore, tanto che gli abitanti di Saint-Maurice hanno praticamente smesso di andare a farsi visitare da lui. La sua fortuna sono state le «grandi epidemie mondiali di influenza», durante le quali nel suo distretto c’è stata una mortalità molto più alta che in tutto il resto della Francia. Knock è il suo opposto, un Davigo con il camice per il quale «gli individui sani sono dei malati che ignorano di esserlo». Si è appassionato alla medicina leggendo fin da bambino articoli, trattati e foglietti illustrativi dei medicinali, poi ha studiato e ha ben chiara la sua missione di medico: convincere le persone di essere malate affinché esprimano il bisogno di essere curate.
Impossibile non cogliere nel testo continue analogie con certi eccessi visti in questi mesi di pandemia. Lo spiega bene Max Bruschi nell’introduzione al libro, quando descrive il «terreno fertile» su cui l’opera di convincimento di Knock opera, un «ultimo ma più raffinato cascame del positivismo, dove il “principio di precauzione” e la panmedicalizzazione, la ricerca dello scoop terroristico sono l’altra faccia della medaglia» di certi ciarlatani che pensano di curare le malattie con impacchi d’aglio e sorsate di vodka.
A ciascuno il suo acciacco
Con una lucidità spietata, appena prende possesso del suo nuovo studio di medico condotto Knock convoca il banditore del paese, il maestro della scuola e il farmacista: il primo dovrà far sapere che Knock offre un giro di visite gratuite a tutti (da cui naturalmente usciranno diagnosi tremende per ciascuno); il maestro dovrà educare i suoi allievi alla profilassi, a imparare che virus e batteri possono annidarsi ovunque; al farmacista invece Knock chiede fedeltà e promette ricchezza grazie alle ricette di medicine che prescriverà ai suoi pazienti. Le scene delle visite agli abitanti di Saint-Maurice sono dei crescendo perfetti: la normale spossatezza dopo una giornata di lavoro diventa sintomo di qualcosa di grave o che potrebbe aggravarsi, anche gli asintomatici sono comunque potenziali portatori di germi e devono restare a letto, chi sottovaluta o ride dell’eccessiva preoccupazione di ammalarsi viene umiliato in pubblico. Per Knok «ammalarsi è un concetto sorpassato, che non può resistere di fronte all’avanzare della scienza moderna. Salute è solo una parola, che senza alcun danno potrebbe essere eliminata dal nostro dizionario. Quanto a me, conosco solo individui più o meno affetti da malattie più o meno disparate e con esisti più o meno rapidi».
Il piano di Knock funziona alla perfezione, nel dubbio tutti si curano, meglio non rischiare: nel giro di pochi mesi centinaia di persone vengono ospedalizzate, allettate nelle loro case, il medico passa le sue giornate tra una visita e l’altra, e la sera contempla il suo successo guardando il firmamento di luci accese nel buio delle case, le stanze dei “suoi” malati. Ogni gesto, ogni diagnosi, ogni grammo di energia è da lui speso per un interesse superiore sia a quello del malato sia a quello del medico, «l’interesse della medicina». Un individuo sano è «né carne né pesce», «necessaria se non altro per accudire gli altri o per formare una specie di riserva dietro ai malati che hanno un’attività».
Ciò che Knock non sopporta è quando «la salute assume aria di provocazione». Chi non si allarma e anzi osa pavoneggiarsi per non essere ammalato prima o poi è destinato a cadere: il signor Raffalens, che oggi verrebbe bollato di negazionismo dagli esperti di turno, «ha continuato a sfidarmi per tre mesi – dice Knock – ma ora ci siamo». A letto anche lui, «le sue spacconate cominciavano a indebolire la coscienza medica della popolazione».
Sacerdoti e strumenti liturgici
Con il passare degli atti Knock trasfigura, diventa la Medicina con la maiuscola, la Scienza con la maiuscola, davanti alle quali ogni interesse diverso deve venire meno, anche «il rallentamento delle altre attività sociali, alcune delle quali sono, a ben guardare, importanti», gli fa notare un allibito Parpalaid, tornato dopo tre mesi in un irriconoscibile Saint-Maurice. «La cosa non mi interessa – replica Knock – io pratico la medicina». E agli abitanti del paesino francese piace essere ammalati, curati da Knock e dai suoi inservienti, essere tenuti al riparo da germi e virus che potrebbero essere fatali. La sola idea che Knock se ne possa andare e al suo posto possa tornare Parpalaid allarma tutto il paese. «Alla fin fine – nota proprio l’ex medico condotto trasferitosi a Lione – se la gente si è stufata di star bene e vuole concedersi il lusso d’ammalarsi, sbaglierebbe a impedirselo».
È un trionfo inevitabile, come da titolo dell’opera di Romains, quello della medicina di Knock: l’esperienza della Spagnola del 1918, dove con Parpalaid medico morirono molte più persone del dovuto, convince tutti a portare all’eccesso il principio di precauzione: «Una popolazione dove i più fragili sono già allettati affronterà a piè fermo un’epidemia mondiale». E in questo mondo ipermedicalizzato tutti sanno tutto: «Lo spirito medico-farmacologico corre per le strade», afferma il farmacista del paese, descrivendo con un secolo di anticipo i nostri giorni. Quelli in cui molti “esperti” emettono sentenze tragiche e definitive diventando autorità senza essere autorevoli. La tragedia è che a loro si oppongono i Parpalaid, superficiali e inetti, i quali comunque alla lunga sono destinati a soccombere.
Nelle indicazioni di scena finali, Romains parla di «strumenti liturgici» con cui i personaggi impegnati a curare gli ammalati si muovono. La dittatura degli esperti trionfa sulla pericolosità degli incompetenti, diventa religione, dogma, e illumina il mondo con «l’atmosfera spettrale della Luce Ospedaliera».
Foto Ansa


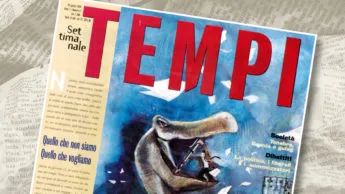
0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!