
Il Deserto dei Tartari
Fiano, Boldrini e i simboli fascisti. La democrazia è in pericolo

Non voglio entrare nello specifico del dibattito, se cioè il disegno di legge Fiano configuri un legittimo strumento per la repressione della propaganda fascista, che è incostituzionale in quanto funzionale alla riorganizzazione del disciolto partito fascista (XII disposizione finale), oppure una violazione della libertà di espressione, altro bene tutelato dalla Costituzione italiana (art. 21). Quello che ha colpito me e immagino molte altre persone è il fatto che venga presentato al parlamento italiano un progetto di legge che prevede dai sei mesi ai due anni di prigione per chi produca, acquisti o detenga un accendino con l’immagine del Duce, o una bottiglia di vino che riproduca il fascio littorio, ben 72 anni dopo che Benito Mussolini è stato fucilato e il regime fascista abbattuto.
È logico e normale che la Costituzione del 1946, scritta e approvata all’indomani del ventennio della dittatura, e la legge Scelba del 1952 proibiscano la rifondazione del partito fascista e l’apologia della medesima ideologia con l’intento di ricostituire il regime del passato, come precisò poi una sentenza della Corte costituzionale. La democrazia era in fasce, non c’era certezza che il nuovo sistema avrebbe funzionato, molti sostenitori del vecchio regime erano attivi e presenti in gran numero nelle strutture dello Stato, e c’era da tenere a bada un forte Partito comunista che avrebbe potuto far deragliare il sistema democratico: occorreva premunirsi da una controrivoluzione e da una potenziale rivoluzione. Statue, iscrizioni, lapidi che richiamavano il potere fascista furono rimosse in gran numero per gli stessi motivi.
Ogni nuovo potere, quando sale in sella e non è ancora sicuro di sé, per consolidarsi deve proibire ciò che massimamente incarnava il regime che l’ha preceduto e cancellare le memorie visibili dello stesso. Ma nella misura in cui le realizzazioni monumentali del potere precedente sono estese e solenni, sarà impossibile eliminarle tutte. Alcune rimarranno, e il loro destino sarà il termometro del successo o dell’insuccesso del nuovo sistema: il fatto che la basilica di Santa Sofia a Istanbul (già Costantinopoli) sia diventata una moschea (prima di diventare un museo nel 1935) e che la grande moschea di Cordova sia diventata la cattedrale dell’Immacolata Concezione è un indicatore della forza e della stabilità dei sistemi politico-religiosi che hanno preso il posto di quelli sconfitti.
Un nuovo potere che cerca di radicarsi, che sta ancora combattendo e non è sicuro della vittoria, distrugge l’organizzazione e i simboli materiali del potere avverso. Lo facevano gli antichi condottieri (Alessandro rase al suolo Tebe, Scipione l’Africano Cartagine), lo hanno fatto i soggetti rivoluzionari come le Guardie rosse di Mao in Cina, i talebani in Afghanistan, l’Isis in Mesopotamia. Un nuovo potere sicuro di sé ingloba i simboli del vecchio regime, e permette la sua sopravvivenza a livello folkloristico e coreografico. Il fatto che gli Stati Uniti abbiano permesso l’esistenza di partiti nazisti, le loro patetiche liturgie pubbliche e il loro armamentario di memorabilia anche dopo la Seconda Guerra mondiale, è un segno del trionfo politico e militare della democrazia americana, non del suo lassismo.
Recentemente Laura Boldrini evocava con rammarico il fatto che la Germania si è completamente liberata dei simboli del passato nazista, architetture comprese, mentre l’Italia non ha seguito lo stesso processo, il che a suo parere sarebbe fonte di sofferenza per molti. La presidente della Camera trascura un fatto: che a differenza dell’Italia post-bellica a decidere il destino dei lasciti del nazismo in Germania non sono stati i tedeschi, ma quasi sempre le forze di occupazione dei paesi che contro la Germania nazista avevano fatto la guerra. Se la loro sovranità fosse stata un po’ meno limitata, forse i tedeschi avrebbero deciso in un altro modo. Là dove la gente del posto ha avuto qualche possibilità di scelta, le cose sono andate diversamente. Non solo in Italia, ma per esempio anche nei paesi dell’ex Unione Sovietica.
Nel settembre scorso mi trovavo a Stepanakert, la capitale dell’autoproclamata repubblica armena del Nagorno Karabakh (Artsakh nella dizione locale) nei giorni in cui si commemoravano i caduti della guerra di indipendenza dall’Azerbaigian del 1991-1994. La celebrazione si svolgeva attorno al grande obelisco (21 metri di altezza) eretto dal governo sovietico per celebrare i caduti della Seconda Guerra mondiale (molti di loro sepolti in una fossa comune nella collina antistante il monumento), quello stesso governo che ai tempi di Stalin aveva consegnato la regione all’amministrazione dell’Azerbaigian contro la volontà della grande maggioranza dei suoi abitanti, distrutto le chiese armene e negli anni seguenti aveva respinto ogni richiesta di autonomia. Le attuali autorità armene hanno lasciato intatta la stele con la sua piastra metallica con la stella e la falce e il martello sovietici, e in basso hanno aggiunto elementi architettonici ornati di teste e croci funerarie della tradizione armena. Anche le divise dei soldati del picchetto d’onore sono le stesse che si vestivano nell’Armata Rossa, sul tipico berretto rialzato c’è perfino la stella circondata da foglie di alloro. Ma intorno alla stella ci sono i colori della bandiera del Nagorno Karabakh (gli stessi dell’Armenia) e nella parte più alta della falda c’è un’aquila aureolata che sormonta una spada e uno scudo crociato rotondo, lo stemma delle forze armate della repubblica.
Queste miscele di simboli e queste soluzioni graduali rispetto a un passato ingombrante mi sono sempre sembrate il modo giusto per gli esseri umani di stare dentro alla storia: conservare parte di ciò che arriva da un passato concluso e condannato è giusto sia perché dobbiamo qualcosa a tutti coloro che ci hanno preceduto, buoni e cattivi, sia perché il modo più efficace di non farsi condizionare in negativo e anzi trarre forza da una testimonianza storica che rimanda a un male è assorbirla. Nel tempo allargherà e renderà più matura la coscienza di noi stessi e della nostra storia e ci renderà più forti, fino al momento in cui la convivenza con essa ci risulterà del tutto normale.
Oggi a nessuno verrebbe in mente di radere al suolo il Colosseo perché è stato teatro di sofferenze umane indicibili, una proposta di distruzione dello stesso solleverebbe incredulità: il Colosseo fa parte della lista Unesco dei patrimoni dell’umanità. Ma non sarebbe stato affatto strano, anzi sarebbe stato plausibile, abbatterlo all’indomani dell’editto di Teodosio. Invece i cristiani furono lungimiranti.
Vengo da una delle città dove l’impronta dell’architettura fascista è stata più profonda: sono nato e ho vissuto per molti anni a Forlì. Per liberare la città dagli edifici collegati più direttamente al fascismo dopo la caduta del regime si sarebbero dovuti riattualizzare bombardamenti come quelli di Dresda o di Coventry: a Forlì sono fascistissimi il Collegio aeronautico della gioventù italiana, zeppo di mosaici del ventennio, dentro al quale sono state ricavate una mezza dozzina di scuole tuttora in funzione, il palazzo delle Poste, il Palazzo degli Uffici statali, l’edificio della Stazione ferroviaria, il monumento ai caduti della Prima guerra mondiale al centro del Piazzale della Vittoria, la statua di Icaro e praticamente tutti gli edifici che si trovano sul viale che collega la piazza col monumento alla vittoria alla stazione ferroviaria. Quel viale, creato ex novo, fu intitolato prima a Benito Mussolini poi, per disposizione dello stesso duce, fu rinominato viale XXVIII Ottobre (la data della Marcia su Roma). Dopo il 25 aprile 1945 è stato ribattezzato viale della Libertà, nome che conserva fino ad oggi.
Forlì, amministrata prima da giunte centriste e poi dai primi anni Settanta sempre da giunte di sinistra, ha cancellato le scritte fasciste dagli edifici e rimosso i fasci marmorei (tranne quelli della Casa del Mutilato in via Maroncelli), ma ha conservato quelli fusi nel metallo dei lampioni di viale della Libertà e di piazza Saffi, la piazza centrale della città dove si svolgono le manifestazioni del Primo Maggio e i comizi di tutti i principali partiti politici. Nonostante tutta questa visibilissima propaganda fascista, il Movimento sociale italiano non è mai riuscito a eleggere più di un paio di consiglieri comunali su 40. Figuriamoci l’incidenza dei portachiavi con l’immagine del Duce o degli sporadici saluti romani allo stadio.
L’improvvisa irruzione del ddl Fiano nell’attualità politica è stata spiegata con le manovre del Partito democratico per recuperare voti a sinistra o con la biografia del proponente, figlio di un deportato ebreo ad Auschwitz. L’immancabile intervento di Laura Boldrini è stato spiegato con la tracimante ricerca di visibilità che è il brand della presidente della Camera. Ma la spiegazione, a mio parere, è molto più allarmante: quando un sistema politico rianima i conflitti del passato escogitando punizioni contro i nostalgici e rimozioni di simboli storici, significa che è in crisi. Significa che non è più sicuro di sé e cerca di rilegittimarsi.
La rimozione dei simboli franchisti in Spagna e di quelli dei confederati negli Stati Uniti molti anni dopo che il franchismo e la causa confederata sono stati consegnati agli archivi non sono un segno di forza, ma di debolezza della democrazia spagnola e di quella americana. Spagna e Stati Uniti sono attraversati da profonde forze centrifughe e disgregatrici, che sempre più faranno notizia nel tempo a venire. Per l’Italia vale lo stesso discorso: se il Pd, partito architrave del governo, e alte cariche istituzionali devono ricorrere alla guerra contro i simboli di un passato consegnato ai libri di storia per rilegittimarsi, significa che il sistema democratico sta vivendo una crisi drammatica.
In Italia non esiste un pericolo fascista, perché i nostalgici del fascismo sono semplicemente dei nostalgici. Il radunarsi e fare il saluto romano al campo X del Cimitero maggiore di Milano o a quello di Cremona non è fascismo: è il surrogato della controrivoluzione fascista che non si è capaci di fare. È, appunto, manifestazione di nostalgia. Mettere questi fatti al centro del dibattito politico da parte di chi ricopre importanti ruoli nelle istituzioni è un’arma di distrazione di massa dai drammatici problemi che l’Italia sta vivendo.
Foto Foro italico da Shutterstock

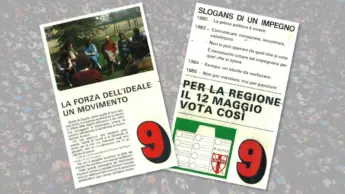

0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!